“I divoratori” di Stefano Sgambati
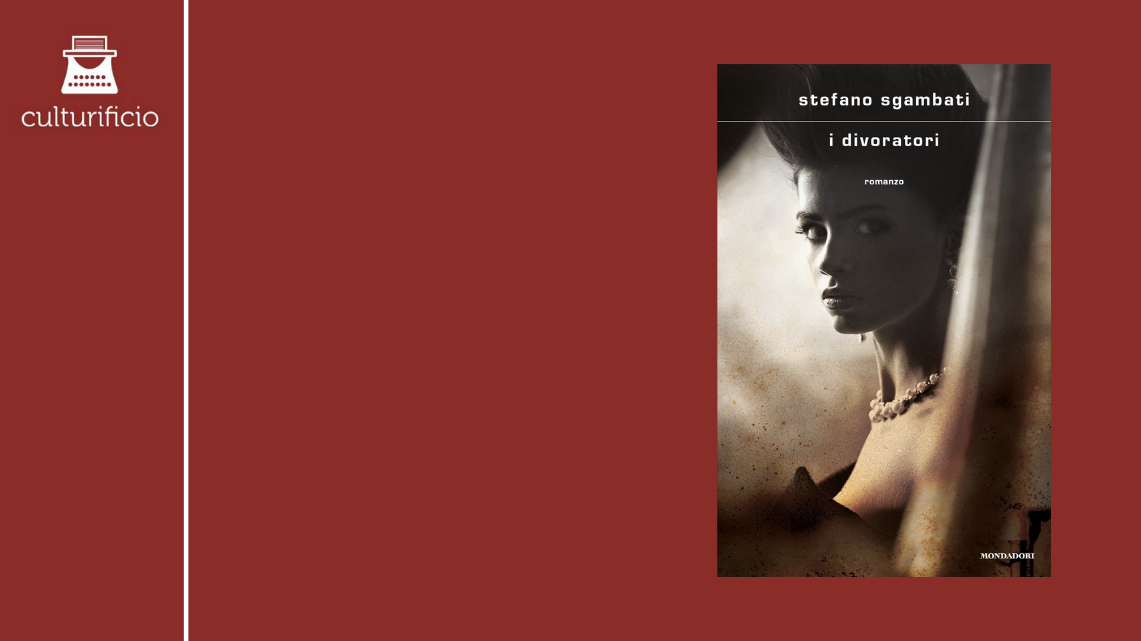
Aveva provato lo stesso ad essere felice, a sentirsi orgoglioso o soddisfatto, ma più che altro dominava la sensazione che il momento migliore della sua vita fosse passato.
Una cena in un ristorante di lusso, tre coppie, Saverio ed Elena, Giordano e Frida, e le star: Daniel William King e sua moglie Sally Parson, entrambi belli, bellissimi, i più belli del mondo. E poi il maître del ristorante, Carlo, la sua abulica madre, la famiglia sgangherata e, per finire, ciliegina sulla torta, lo chef Franco Ceravolo. Ecco i protagonisti, o per dirla con Sgambati i corpi di questo romanzo, edito da Mondadori, originalissimo, potente, che riesce a catturare l’attenzione del lettore fin dalla prima pagina. Sgambati instaura una magia narrativa davvero stupefacente, da quella sala del ristorante dove sono seduti i nostri protagonisti, non si allontana mai e, tramite analessi, ricostruisce le storie dei personaggi, rendendoli tridimensionali, a tutto tondo, e in uno spazio così piccolo riesce ad ampliare gli orizzonti del possibile dilatando il tempo e lo spazio, costruendo un mondo fittizio attraverso il quale veicola la sua visione dell’uomo che si può probabilmente sintetizzare nella massima hobbesiana «homo homini lupus».
Ma, nonostante la sentenza opra citata, non definirei Sgambati uno scrittore cinico, quanto uno scrittore arrabbiato che sa scrivere in modo originale e, soprattutto, intelligente; nel romanzo in filigrana si possono trovare tantissime sfumature di emozioni che l’autore riesce a sublimare nella scrittura. C’è la rabbia, la pietà, la delusione, la tristezza, la paura. Viene da chiedersi, per cosa? Di cosa vuole parlare Sgambati? Chi sono i divoratori?
Nel romanzo, con le dovute differenze, tutti i personaggi sono divoratori, la questione fondamentale sta nel porre la lente sul rapporto che ciascuno di loro ha con gli altri e, quindi, con loro stessi. Daniel William King e sua moglie Sally Parson (impossibile non pensare a Brad Pitt e Angelina Jolie) sono star e agli occhi divoratori degli altri commensali, sono corpi che destano la massima curiosità e diventano modelli, sono idoli; chiunque vorrebbe essere nei loro panni. DW. King, però, guardandosi allo specchio una mattina prima di un ciak pensa e rielabora: «[…] non potevo davvero essere io quella persona così enorme».
Qualcosa sta logorando l’attore dall’interno, qualcosa, però, che è legato a filo doppio con qualcos’altro che sta all’esterno; un meccanismo complicato per il quale diventi divoratore di te stesso, perché quando la tua persona è in grado di muovere business da milioni e milioni di dollari, quando il tuo viso, così dannatamente perfetto è noto e adorato in tutto il mondo, la tua percezione appunto enorme diventa un peso che ti devi portare dietro e la lotta con “il gemello siamese più forte” è persa in partenza.
Diventa quindi allegorica la sontuosa stanza nella quale i protagonisti sono riuniti: mangiare, divorare, consumare, ecco i verbi che serpeggiano per tutto il romanzo. Le coppie citate all’inizio intrattengono conversazioni che sono volte ad ottenere qualcosa. Ecco che chi ti sta davanti non è più una persona ma un qualcosa che puoi, che devi usare a tuo piacimento, per i tuoi fini; i rapporti umani diventano così governati da un meccanismo di sopraffazione: sconfiggere l’altro per ottenere ciò di cui tu hai bisogno, per riempire un vuoto, per colmare una tua incapacità o, molto più trivialmente, per ottenere del sesso.
Il pensiero di perderla […] gli aveva tirato fuori un coraggio che non sapeva di possedere: era stata quella la prima volta che aveva conosciuto il lato di sé che si innesca in automatico, che operava scelte alla velocità della luce davanti a un oggetto del desiderio.
Per Carlo, Vesta, una prostituta, è un oggetto del desiderio grazie al quale può avere ciò di cui ha bisogno: potere e umiliazione, essere vittima e carnefice. La scrittura di Sgambati è impietosa, furiosa, vera:
Non aveva goduto granché: […] ma l’umiliazione a cui si era sottoposto era l’umiliazione che aveva inflitto al figlio dei suoi genitori e quindi a quei genitori stessi e così alla sua vita.
Lo stile maturo e unico dell’autore rende vivida ogni scena di vita quotidiana che, a seconda dei casi, diventa triste e mortifera oppure tenera e normale. Carlo guarda i suoi genitori davanti alla tv, osserva la stanza vuota e secondo lui male arredata; sua madre, automaticamente, chiede a suo padre:
«Giovanni, li mangi i bastoncini Findus stasera?»
«Un’altra volta?”» «“Così li finiamo».
«Però fammeli fritti. Ché le cose al forno mi hanno cacato il cazzo».
La scena subito si carica di un’aura negativa, di qualcosa che si trascina stancamente, senza volontà, che continua come una triste abitudine che non assomiglia alla quieta accettazione dell’amore, bensì alla rassegnazione e alla rinuncia.
In questa realtà vuota di valori e piena di spaesamento, il peggiore dei mali non è tanto l’assenza di bussole morali, quanto il fatto che ci siano bussole che orientano su punti cardinali distruttivi. Kierkegaard scriveva: «Quelli che oggi non si fermano all’amore, dove credono di andare? Alla saggezza terrena, al bieco calcolo, alla piccineria e all’infelicità?». I personaggi che Sgambati ha creato mi ricordano molto gli uomini schifosi di David Foster Wallace nella sua omonima raccolta di racconti, uomini schifosi che si sentono post-amore, post-fede, post-tutto, che adorano il denaro, il successo, loro stessi, incapaci di spinte autentiche al sacrificio per l’altro che diventa, quindi, un prolungamento del loro ego, un oggetto di cui si possono servire e poi scartare, quando capiscono che non ne vale più la pena.
Introducendo nel romanzo celebrità del nostro tempo, da Fabio Fazio a Damien Hirst (geniale il loro accostamento) Sgambati ancora saldamente tutta la sua narrazione al nostro presente, dicendoci che la realtà cruda, violenta e destabilizzante di cui ci parla, è la nostra, è quella nella quale viviamo e che possiamo tranquillamente, purtroppo, riconoscere. Sembra che abbiamo assorbito un imperativo categorico che mai è esistito nella storia dell’umanità: consuma più che puoi. Tutto. Gli oggetti, i soldi, te stesso, le persone, divora quello che puoi divorare e passa alla pietanza successiva. Ma così facendo cosa resta? Cosa può costituire un freno all’inevitabile sfacelo che verrà da un tale modo di sentire? Se la ricerca del significato della vita è condotta su dei presupposti sbagliati, non potremo che arrivare ad un’aberrante conclusione: che anche i limoni montaliani sono di plastica. «La vita senza violenza non aveva senso», arriverà a concludere uno dei personaggi.
Negli ultimi tre capitoli del romanzo (davvero spaziali) quello che succede nella stanza del ristorante è pienamente allegorico: il Simbolo dell’Occidente è sfigurato, il crollo è imminente, la bandiera sotto la quale preghiamo è stata lacerata e allora non esistono più freni, non ci sono più limiti; l’ordine fasullo che ci faceva interpretare correttamente delle parti, come se fossimo tutti piccole marionette, diventa quello che in realtà è sempre stato: caos. E quando il disordine regna, le persone diventano semplicemente corpi, perdono il valore che non hanno mai avuto e ogni falso ideale che poggia unicamente sulla violenza, sulla sopraffazione e sulla conquista si consuma, come su bruciasse nelle fiamme dell’inferno.
Fuori dal ristorante Sgambati colloca una macchina, nella quale un tassista, Sebastiano «[…] fiero della sua famiglia semplice, di lavoratori, di gente che si voleva bene, che amava passare il proprio tempo assieme, senza retorica o false narrazioni», porta via dall’inferno dell’Occidente chi non c’entra e chi si pente, lontano dal chiassoso niente, nella serena quiete generata da chi sa amare l’altra persona e basta.
La felicità non è tale finché non ci togliamo dal “centro”: del mondo, dell’universo, della nostra falsatissima solipsistica percezione.
Chiudo la recensione con una frase del già citato David Foster Wallace perché mi sembra particolarmente calzante con quello che Sgambati è riuscito a fare scrivendo questo bellissimo romanzo:
Il talento è solo uno strumento. […] Non dico che senza sarei comunque in grado di dare compiutezza al mio lavoro, ma si direbbe che la grande distinzione fra l’arte che vale e l’arte così-così sia da ricercare nell’intento posto al cuore dell’arte, nei programmi della coscienza che si celano dietro al testo. C’entra invece l’amore. La disciplina necessaria a far parlare quella parte di sé capace di amare anziché quella parte che vuole solo essere amata.