“The Girl with the Needle” di Magnus von Horn
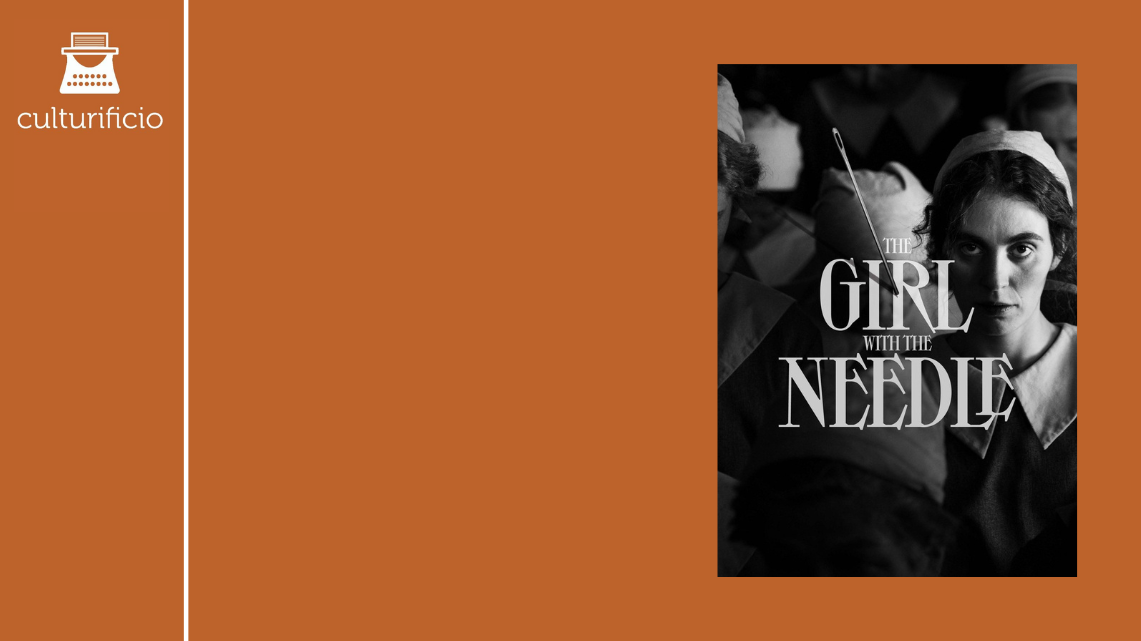
Se non l’avessi fatto tu, non l’avrebbe fatto nessuno.
The Girl with the Needle (Pigen med nålen, 2024) di Magnus von Horn è una fiaba gotica e oscura, in bianco e nero, tratta da fatti realmente accaduti. Un racconto sulla crudeltà, sull’empatia e sulla fragilità umana in una società disintegrata dalla Grande guerra.
Copenaghen, fine della Prima guerra mondiale. Karoline Nielsen (Vic Carmen Sonne) è una giovane operaia danese della fabbrica tessile Kitzler. Sbattuta fuori di casa, sola e con una situazione economica complicata, cede all’interessamento del proprietario della fabbrica, Jørgen, che approfitta della sua fragilità per conquistarla. Il ritorno dalla guerra di una persona cara e l’incontro con la negoziante di dolciumi Dagmar (Trine Dyrholm) sconvolgeranno per sempre la vita di Karoline.
Le immagini in bianco e nero, il suono penetrante e stridulo dei violini fuoricampo, Karoline che si sta strofinando le braccia e il viso con una saponetta per lavarsi, uno specchio che riflette i lineamenti della protagonista. Si apre con questa scena The Girl with the Needle: in pochi istanti vengono determinate le linee stilistiche e le scenografiche gotiche della pellicola. Un’atmosfera cupa e inquietante che prende per mano lo spettatore e lo accompagna durante tutta la narrazione.
Karoline cerca di aggrapparsi con le unghie e con i denti alla speranza e prova a sopravvivere in un contesto sempre più complicato. Appena riesce a trovare quello che può sembrare un lieto equilibrio quotidiano ecco che arriva una doccia fredda, e poi un’altra e un’altra ancora. Una serie di sfortune che legano la protagonista a una triste e maligna realtà. In diverse inquadrature, Karoline tenta di evadere con la mente, guarda il cielo attraverso la finestra di casa, osserva la città attraverso un appannato finestrino oppure cerca sé stessa nel riflesso di uno specchio – chi sono davvero? Cosa sto facendo? – in quell’universo iconografico sulla dualità: un’anima persa e spezzata nei meandri dell’esistenza.
Il desiderio di affetto, la sicurezza, l’emancipazione e l’apparente disponibilità di Dagmar, accompagnata dalla figlia Erena, sono gli aspetti che conquistano subito Karoline e che la convincono a seguire la stessa strada: aiutare le donne che non possono tenere i propri bambini e cercare delle famiglie agiate che possano adottarli e garantire loro un futuro migliore. In questo contesto, così complicato, da un punto di vista sociale ed emotivo, l’evasione metaforica attraverso lo sguardo viene sostituita dall’utilizzo compulsivo di etere. Ed ecco che l’evasione inizia a prendere forma e diventa tangibile, con l’arrivo di altre notizie sconfortanti che alimentano questo desiderio di fuga.
Un altro elemento cardine della narrazione è sicuramente Peter: sfigurato dalla guerra, ha bisogno di una maschera per nascondere il volto. Quest’uomo, dimenticato dalla nazione e deriso dagli stessi abitanti della città, si trasforma in una sorta di emblema, esteticamente lynchiano e grottesco, di resilienza. Da soldato a fenomeno da baraccone, proprio nello spettacolo itinerante riesce a trovare una sorta di nuova famiglia composta da altre figure dimenticate. Il suo ritorno improvviso, l’esclusione e la sua grave deformità – sottolineata sonoramente e impeccabilmente dal respiro profondo e affannoso causato dalla maschera – aggiungono un’anima in pena al già ricco banchetto di sconforto e malvagità della pellicola.
Il mondo è un posto terribile. Ma dobbiamo credere che non sia così.
La storia che viene narrata è davvero tagliente, cruda. La speranza non sembra mai toccare, neanche lontanamente, il destino delle diverse figure. Ma è proprio in questa estenuante ambientazione che il regista Magnus von Horn, con l’aiuto di una brillante colonna sonora della cantante e compositrice Frederikke Hoffmeier – in arte Puce Mary –, riesce a equilibrare le comuni problematiche e le relazioni tra i protagonisti con le crudeli e sbalorditive vicende che accadono sullo sfondo. Tutto si muove, tutto cambia. La paura, l’ingenuità e la fragilità di Karoline diventano una calamita: sia per i personaggi che ruotano intorno a lei, sia per il susseguirsi degli eclatanti avvenimenti del racconto. Il male, la paura e la sofferenza, che aleggiano costantemente sulla scena, contrastano con la leggerezza d’animo di alcuni individui. L’armonia tra queste tematiche, unita alle affascinanti inquadrature, all’ambientazione gotica e all’incalzante accompagnamento sonoro, restituisce una tensione piscologica penetrante e coinvolgente.
Il bianco e nero è incantevole, quando torni indietro nel tempo o in un altro mondo il bianco e nero è stupendo. E c’è una sorta di sensazione particolare in questo. Alcune storie dovrebbero essere raccontate in bianco e nero, ed è piuttosto ovvio. Aiuta davvero a tornare indietro nel tempo (David Lynch, The Idea Dictates Everything, «KGSM MediaCache», 13 gennaio 2006).
La scelta della fotografia in bianco e nero è tremendamente efficace perché rimanda alle grandi opere della cinematografia muta, nello specifico a quelle dell’Espressionismo tedesco e a quelle del cinema sperimentale sovietico. A questo proposito, le suggestioni filmiche possono essere molteplici: la scena e l’inquadratura dei momenti in cui Karoline chiude le giornate lavorativa nella fabbrica Kitzler rimandano a L’uscita dalle officine Lumière (1895, Louis Lumière); il gioco di luci, riflessi e ombre che formano dei tagli squadrati e geometrici delle inquadrature nelle molteplici riprese delle fredde stanze e dei minuti cortili interni riecheggiano Il gabinetto del dottor Galigari (1920, Robert Wiene). O ancora, le tante riprese ravvicinate sull’occhio della protagonista riprendono L’uomo con la macchina da presa (1929, Dziga Vertov). E per sottolineare questa direzione referenziale, e il metacinema, uno dei pochi momenti sereni e liberi tra Karoline e Dagmar si svolge proprio in una sala cinematografia, durante la proiezione di un film muto con i cartelli di testo – dove, con un altro tipo di fruizione, torna il tema dell’evasione.
Andando oltre il macrocosmo di riferimenti cinematografici, e provando a mettere da parte l’aspetto drammatico e criminale delle vicende, The Girl with the Needle è un film che verte sulla complicità femminile, sull’emarginazione economia e comunitaria degli ultimi, sulla drastica disparità sociale, sulla maternità e sulle difficoltà delle donne, sul rapporto tra l’umanità e la guerra. Un film in cui l’evasione dalla realtà è uno degli unici rifugi per proseguire la propria vita e andare avanti, con uno sguardo in camera verso lo spettatore.