“La Cecilia” di Michela Panichi
storia del nome
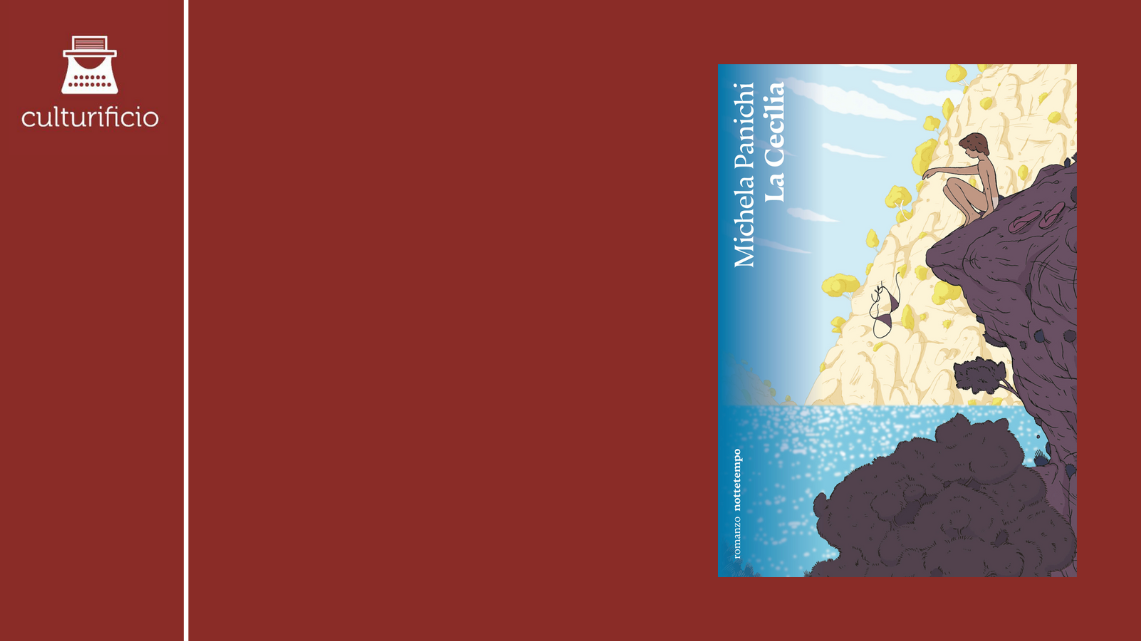
Che i corpi ci anticipano in quello che stiamo diventando lo sappiamo fino a un certo punto. Perché il nostro corpo è una sintesi di materia biologica e di sentire ma esiste anche una parte che non ci appartiene, e che si dà soltanto attraverso lo sguardo altrui. Quello per cui Cecilia, nell’estate dei suoi tredici anni, asseconda un’ambiguità collettiva che la fa essere sempre femmina e qualche volta, di nascosto e soltanto davanti a certe persone, maschio.
La Cecilia, l’esordio letterario di Michela Panichi per nottetempo, mette l’articolo davanti al nome proprio di persona. E lo neutralizza, perché se si abbassa la maiuscola il nome proprio si fa nome comune di animale, e la cecilia è ora qualcosa di non umano, un essere sia maschio che femmina, brutto e che non vede. Un anfibio di mare, il verme che Cecilia sente dentro allo stomaco, di più: che è lei, perché il suo corpo non ancora sviluppato oscilla tra i due generi, come fanno certe specie di animali. Cecilia lo apprende dall’atlante di suo fratello Luca, dove legge anche che ha lo stesso nome di un anfibio. Durante questa estate spesso lo consulterà per trovare i motivi di quello che accade al suo corpo e a quelli degli altri, quando sono attratti l’uno dall’altro. Le manovre di seduzione degli animali sono un topos narrativo della storia, sono il primo linguaggio erotico-sentimentale che Cecilia può parlare.
Durante l’estro gli animali diventano violenti. È così perché l’accoppiamento deve mettere d’accordo due corpi e apparati, fluidi interni, voglie esterne, e anche quando tutto funziona c’è sempre qualche intralcio.
Questa storia sta tutta nel nome, Cecilia, scelto dal padre, e che sillabato dal padre, Ce-ci-lia, diventa pieno. C’è poi Luca, l’altro maschio della famiglia, il fratello minore, e una madre tenuta a distanza.
Cecilia, un pomeriggio di quell’estate a Ischia, su una spiaggia diversa dal solito e più distante, ha i capelli molto corti e indossa il costume del fratello. Perché è più comodo, perché il suo petto è ancora sessualmente neutro e lei sa che non sarà così ancora a lungo. Poi l’equivoco: dei ragazzi le si rivolgono al maschile e lei li asseconda. In quel contesto e con quelle persone, si chiama Luca, è sia femmina che, insieme a loro, maschio. Non sta molto a pensarci: si sente bene vestendo in modo maschile, comincia a provare qualcosa per una ragazza del gruppo, ed essere un maschio è più comodo, a cui tutti credono. È qualcosa di sottinteso, ancora una volta, al suo nome, al legame primigenio con il padre; Cecilia sente di essere più vicina a lui e al fratello, e molto lontana invece dalla madre. A lei, e in generale al femminile, Cecilia associa qualcosa di fisicamente sgradevole e di sporco: il sangue, che ogni mese lascia il corpo e la sua figura implicitamente sensuale, che le ricorda che anche la sua sta per cambiare.
Cecilia incontra quindi Alba. Sono le descrizioni del suo corpo ad anticiparla nello scritto, a suggerire le sue apparizioni. Le spalline morbide del costume che scendono, l’odore della crema, il velo di sabbia sporca che di solito ha sotto i piedi: il particolare rinvia alla presenza. Se Alba vuole sapere tutto in fretta, Cecilia tende a dilatare questo tempo dell’equivoco, sempre più attratta da lei; attraverso questa dinamica, Panichi rende narrativamente il desiderio implicito in un’innocenza ancora molto marcata, infantile. Ne trasmette l’ambivalenza soffusa con un linguaggio sensoriale che, come su un tavolo operatorio, scandaglia i corpi e talvolta li separa, li descrive nelle funzioni più biologiche, oppure li sublima nei suoi significati altri. Nemmeno tanto più grande di Cecilia, completamente diversa da lei, Alba è bellissima e sente l’urgenza di usare il suo corpo. È un’altra lezione di quell’estate: molte volte amiamo per contrasto, frughiamo dentro al desiderio in cerca di un altro-me stesso, quantomeno come vorremmo che fosse. A volte, se amiamo gli altri è proprio perché non potrebbero mai essere noi.
L’estate di Cecilia a Ischia ha l’odore del sudore dei maschi, si appiccica sulla pelle con l’umidità e la salsedine: dato che le mancano le parole per raccontarsi quello che le sta accadendo, l’educazione sentimentale e corporea di Cecilia avviene attraverso immagini evocative, sinestesie che toccano il corpo e passano da un senso all’altro. Cecilia vuole capire e cerca quello che non sa nel nel contatto meccanico, allo stesso modo degli animali, conoscendo il desiderio nella sua animalità.
La forma del romanzo riprende questa ricerca, e ogni capitolo si apre con una nozione scientifica, soprattutto dal mondo animale:
Non esiste nessuna specie in cui per l’accoppiamento non vi sia una qualche forma di conflitto, se escludiamo quelle che sono monogame per la vita, come alcuni uccelli.
E intanto l’identificazione con la cecilia è sempre più marcata, si materializza nei pensieri e nei sogni notturni, come una tenia nello stomaco la mangia da dentro e s’ingrossa con la manchevolezza dei genitori, le ambiguità dei sentimenti, le bugie di tutti. Cecilia è sempre più femmina perché molto vicina allo sviluppo e intanto è sempre più maschio, quando ruba un’imbottitura del reggiseno della madre e ne fa una protesi per riempire il costume da bagno del fratello.
Non è la storia di pochi, non è la storia di qualcuno su tanti, non è un unico corpo che si paralizza mentre gli altri, in massa, procedono. Questa storia è la vita. Tutti abbiamo cercato o continuiamo a cercare delle forme più comode per il nostro corpo, tutti alle volte fatichiamo a crederlo nostro. È un romanzo che può aprire a un riconoscersi collettivo e Panichi – con questo testo finalista al Premio Calvino –, attraverso una narrazione assolutamente delicata, fa affiorare domande lasciate in sospeso, dentro, da qualche parte, anche altre rispetto a quelle dell’io narrante. Come se essere cambiati e cambiate nei corpi, averli visti prendere certe forme e lasciarne indietro altre, potesse farci prendere atto di tutto quello che ci stava accadendo e così accettarlo. Spesso non è stato così.
Il corpo, a partire dalla sua carne e dalla materia biologica, è il primo spazio di senso e di narrazione.
Il paguro terrestre usa una conchiglia per proteggere il suo corpo delicato. La conchiglia solitamente è quella di una lumaca di mare. La crescita del paguro è molto lenta ma, quando esso diventa troppo grande, sarà necessaria una nuova conchiglia di dimensioni maggiori. Lo scambio di conchiglia è piuttosto comune.