“Macaco”: un’epica di normalità
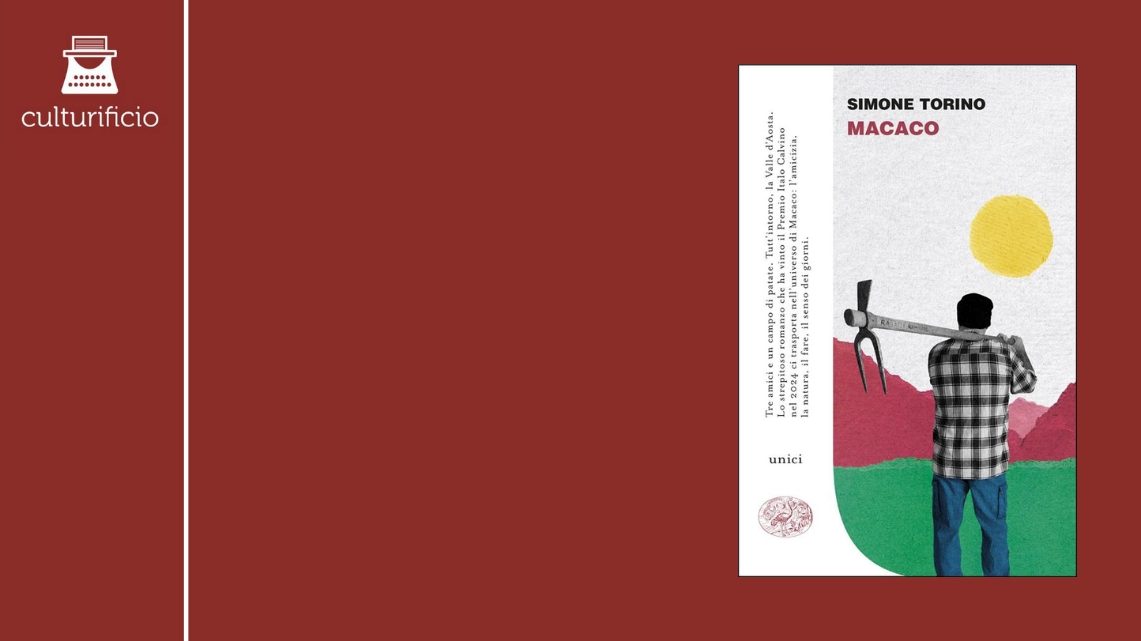
Diamo nomi alle cose per le differenze. Anche a noi, ci diamo nomi. Per comodità.
Dei protagonisti di questa storia conosciamo solo i soprannomi. Macaco, infatti, è come lo chiamano gli altri, ma a lui non dispiace. Abita da solo con le sue due gatte, gioca a basket, fuma la pipa e per guadagnarsi da vivere coltiva i campi di patate di Magnifico – capo fanfarone – insieme a Bestemmia (soprannome che non ha bisogno di spiegazioni) e Zitto, che è sordo. I nomi servono a differenziare, ci spiega, e quelli che si sono scelti parlano chiaro.
Macaco è anche il titolo di questa storia, l’esordio di Simone Torino, vincitore del Premio Calvino 2024, pubblicato nel 2025 nella collana «Unici» di Einaudi.
Il romanzo prende spunto dall’esperienza biografica dell’autore – che ha trascorso otto anni come bracciante agricolo in Val d’Aosta – e finisce per configurarsi come una narrazione epica di normalità, ridefinendo il concetto stesso di eroe.
Il primo elemento caratterizzante è lo spazio: la vicenda è ambientata per la maggior parte nella valle di Gressoney. Tuttavia, il lavoro nei campi, tra le montagne, è raccontato senza alcun lirismo o idealizzazione. Non è una campagna sentimentale, da tramonti e “vita lenta”. Si tratta piuttosto di una natura che primeggia sull’uomo, scandendone l’esistenza: luce e buio segnano l’inizio e la fine della giornata; il sole e la pioggia decidono se si lavora o si riposa.
Torino accompagna il lettore in questo microcosmo con i suoi orari, le sue regole, in cui ciò che conta sono i rapporti umani, stretti nel silenzio e nella fatica.
I tre protagonisti sono uomini ai margini, goffi, segnati da limiti fisici e sociali, dalla fatica e dai vizi. Dei vinti verghiani a tutti gli effetti, cui manca perfino l’ambizione di volere qualcosa di diverso. Perché, in fondo, la loro vita – così com’è – basta.
Nonostante conducano un’esistenza minimale, fondata sulla necessità, priva di fronzoli e estranea al superfluo, Macaco, Bestemmia e Zitto riescono a conservare la forma più ostinata di eroicità: l’umanità. È del tutto naturale, allora, che Macaco desideri imparare la lingua dei segni per comunicare con Zitto anche in assenza di Bestemmia, che solitamente fa da mediatore; come è istintivo, nonostante le difficoltà, che entrambi restino vicini all’amico quando viene lasciato dalla moglie e cerchino di salvarlo dall’alcolismo:
– Solo, a me spiace, – dico ancora.
Mani in faccia, soffia.
– Non voglio che muori, – dico.
Si asciuga, si alza. Schiarisce la gola.
– Non mi frega se mi vedi che piango, – dice, tira su col naso: – ma non dirmi le cose di amicizia, che mi fa troppo.
Una fratellanza la loro fatta di gesti semplici, impacciati ma autentici.
Il lavoro usurante e la stanchezza fisica, infatti, nulla possono contro i tre non-eroi, uniti da una solidarietà concreta, ruvida ma capace di resistere all’abbrutimento che ci si aspetterebbe dalla realtà in cui vivono. Un abbrutimento che si manifesta nell’aspetto e nelle abitudini:
Prima di uscire metto il cappello, ma al contrario.
Il cappello berretto.
Faccio così: lo tengo qualche settimana girato normale, poi lo rivolto, dall’etichetta. Vado avanti per giorni, prima da una parte, poi dall’altra, finché ha l’odore dei cani di strada. Quando sa di cagnone, lo lavo. Me l’ha insegnato Bestemmia. Lo Zitto no, è pulito. Ha sempre una camicia diversa, e mette il dopobarba. […]
– Cosa c’hai nel naso, i gatti?
Glielo dico, ma non gli frega.
Lo Zitto no: curato. Le orecchie: rasate. Liscio.
Io taglio, ma così, come viene viene. L’acqua la uso, d’estate. D’inverno no, mi lavo agli allenamenti. Tre volte a settimana. È tanto? È quanto basta.
Una storia semplice che accende un faro su una realtà marginale ma indispensabile, come quella agricola – spesso idealizzata, ma in realtà segnata da condizioni di lavoro estenuanti, precarietà e sfruttamento – in cui l’unica vera ricchezza è l’aiuto reciproco tra chi condivide la stessa fatica e gli stessi ritmi.
Ma il paesaggio rurale non è l’unico spazio abitato dai protagonisti. In una prospettiva dualistica, Simone Torino li sposta talvolta nella dimensione urbana. Il confronto diventa allora scontro tra due modelli opposti di convivenza: da una parte la collettività della campagna, l’amicizia tra i tre protagonisti; dall’altra l’individualismo della città, dove il senso di fiducia si sfalda lasciando spazio al sospetto. Ciò è evidente in uno scambio tra Macaco e un compagno di “palla a canestro”, Pierre, di fronte alla possibilità che qualcuno rubi una gallina.
Macaco è attratto dalla città, ma non la comprende fino in fondo. Non ne conosce i codici, né le regole: è uno spazio che lo fa sentire estraneo, fuori luogo. Eppure, spinto dalla curiosità, non rinuncia a esplorarla. Lo seguiamo così in una serata torinese di poetry slam, o ancora in un ristorante, dove la dissonanza tra il suo modo di essere e l’ambiente circostante emerge, ancora più stridente, con delicatezza e ironia:
Noi, e per noi intendo io e Bestemmia, Zitto no, siamo abituati al rumore: risa grosse, voci alte, colpi sul legno a mano piatta. Invece, qui, gente che bisbiglia, bicchieri tenuti dal gambo, musica tranquilla, bassa.
Arriva la cameriera, camicia bianca, stretta, maniche al gomito, gonna nera. Dà dei signori a tutti e tre, chiede le giacche.
– Ho il maglione, va bene lo stesso? – dico.
– Sì, il maglione va bene, – dice, e le scappa un sorriso.
Sento come se ho detto una vaccata, a dire del maglione.
I brevi estratti citati bastano a chiarire cosa renda Macaco davvero straordinario: la scrittura. Scarna, ritmata, mimetica del parlato. È una lingua che sembra nascere direttamente dai personaggi, senza mediazioni né abbellimenti. Quasi inventata, capace di restituire con naturalezza l’estrazione sociale e l’ambiente, e al tempo stesso densa, precisa, centrata.
Simone Torino, con un passato da poeta, dimostra particolare attenzione al suono delle parole, alla loro musicalità. E questa, forse, è la sua vera cifra.
La voce e la focalizzazione sono quelle di Macaco: «maschio quarantenne, moro, barbuto, di mezza altezza, dalle braccia lunghe e le gambe storte». Un tipo timido, ingenuo, spesso a disagio – soprattutto davanti a Matilde, una donna che tenta di frequentare, con cui sogna qualcosa di tenero, pudico e maldestro, «una cosa tipo api, fiori, non sessuale».
Un personaggio straordinario che incarna una virilità nuova, fatta di fragilità, esitazioni, attenzione all’altro. Un protagonista che sovverte l’immagine tradizionale del maschio rude, temprato dalla fatica, distante dai sentimenti. Per questo è necessario: perché dimostra che un’alternativa esiste – oltre ogni pregiudizio, posizione sociale, grado di istruzione – e può essere raccontata.
Macaco, in fondo, non è solo un soprannome: è una posizione, uno sguardo laterale sul mondo. Con il suo esordio, Simone Torino dà voce a chi solitamente non ne ha, restituendo dignità alla vita spoglia di chi resta ai margini. Attraverso l’uso della lingua e della sintassi, nei silenzi e nell’inadeguatezza che attraversano Macaco, Zitto e Bestemmia, prende forma una nuova idea di eroismo: senza gesta eclatanti, fatto di piccoli gesti quotidiani, di resistenza silenziosa, di un’incrollabile fedeltà a sé stessi, anche quando il mondo sembra respingerli.
Un modo di essere eroi che è discreto, ruvido, profondamente umano. E proprio per questo, autenticamente letterario.
di Silvia Castellani