La Noia e La Nausea
l’esistenzialismo di Sartre e Moravia
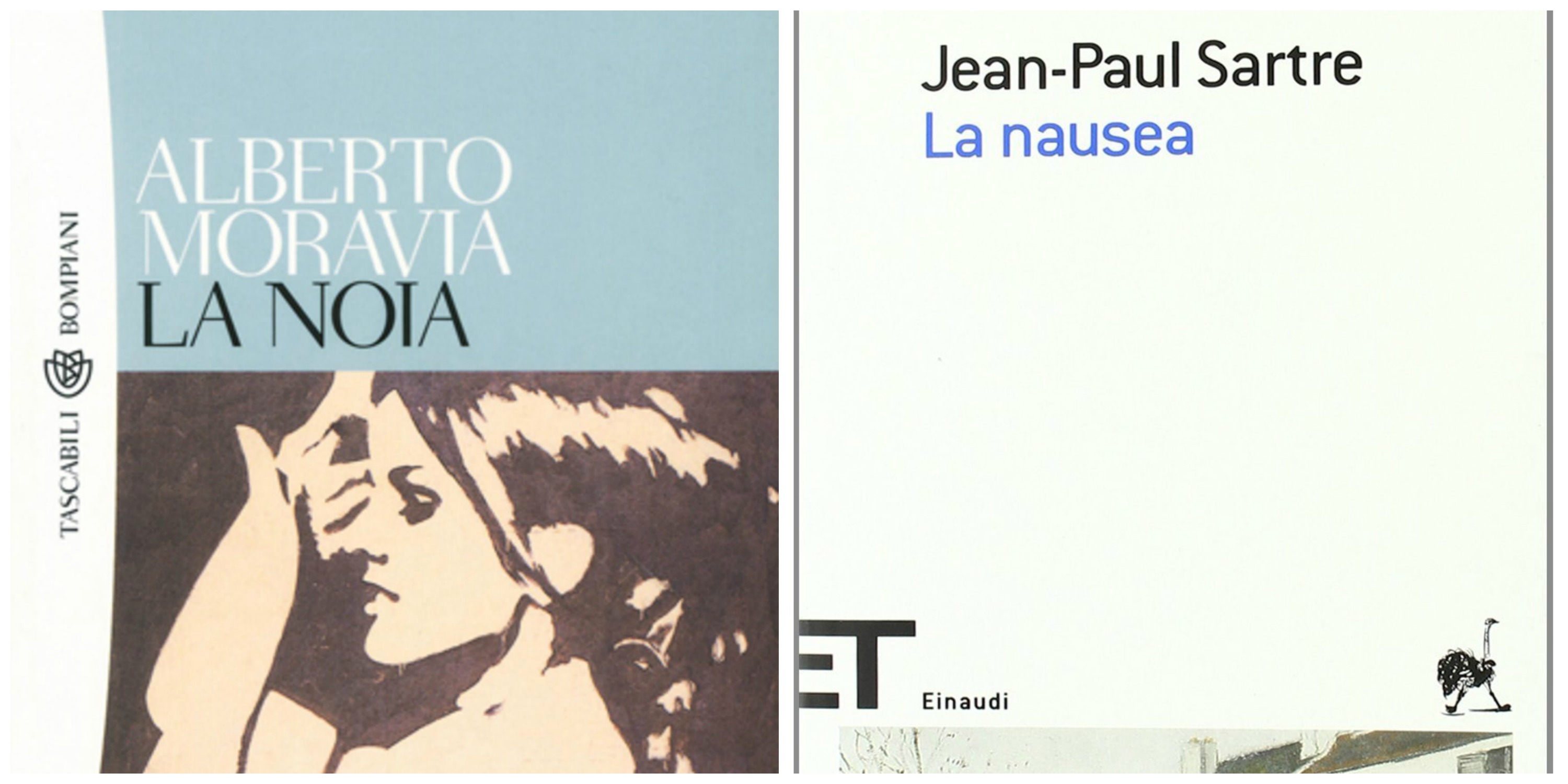
C’è un abisso invalicabile tra l’uomo e le cose che lo circondano, che nel ‘900 diventa una prigione per molti scrittori giudicati colpevoli e incarcerati in quella fortezza.
Lavorare di raziocinio nella bolgia infernale del XX secolo è un crimine che pagheranno molte vite devote alla filosofia, alla letteratura, martirizzate affinché il loro verbo giungesse a noi più pulito e reale possibile: il più delle volte angoscioso e nichilista, difficile da digerire e allo stesso tempo da mantenere distante con finto disinteresse.
Due romanzi sembrano percorrere in forme, sviluppi, reazioni e atmosfere indipendenti, una via che prende un nome diverso a seconda della città in cui si vive, della famiglia in cui si cresce, della vita che si conduce, che culmina tuttavia nello stesso identico luogo di perdizione o distorsione profonda del senso dell’esistenza, oramai senza un Dio a cui affidarsi nella selva oscura: sono “La Noia” (1960) e “La Nausea” (1939).
 Moravia e Sartre, o meglio Dino e Antoine Roquentin, pur con una guerra di mezzo (la più grande) sembrano praticamente la stessa persona, l’uno a Roma, l’altro nel sud della Francia, eppure vicini di casa; forse Dino, figlio della guerra, è più consapevole del male che lo affligge: lo sa descrivere, ha una forma ben definita e sa che gli appartiene da quando era molto giovane, è la noia. “La noia”, per lui, “è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà”, 1 parla di un “avvizzimento degli oggetti, ossia dell’oscura consapevolezza che tra me e le cose non ci fosse alcun rapporto”. 2
Moravia e Sartre, o meglio Dino e Antoine Roquentin, pur con una guerra di mezzo (la più grande) sembrano praticamente la stessa persona, l’uno a Roma, l’altro nel sud della Francia, eppure vicini di casa; forse Dino, figlio della guerra, è più consapevole del male che lo affligge: lo sa descrivere, ha una forma ben definita e sa che gli appartiene da quando era molto giovane, è la noia. “La noia”, per lui, “è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà”, 1 parla di un “avvizzimento degli oggetti, ossia dell’oscura consapevolezza che tra me e le cose non ci fosse alcun rapporto”. 2
È scientifico nella sua diagnosi, l’ha maturata in anni di esperienza consapevole di distacco dall’altro da sé, che si riflette nel suo mestiere di pittore che cessa di dipingere dalla prima riga della sua storia.
Di lui sappiamo tutto o quasi, già dal prologo che precede il primo capitolo; sembra inspiegabile e impensabile ogni svolgimento di una storia con certe premesse, che pure risulterà sotto alcuni punti di vista meno drammatica di quella del suo alter ego francese, che affronta invece un crollo di cui egli è spettatore stordito e unico attore sulla scena contemporaneamente.
 Antoine Roquentin è uno storico che da tre anni si è trasferito nella cittadina di Bouville per lavorare ad una dettagliata ricerca storica su tale marchese Rollebon. Mentre il pittore di Moravia è dottore e paziente di se stesso, Roquentin è malato di qualcosa che egli inizialmente rifiuta: nella prima pagina del suo diario racconta del momento in cui ha sentito per la prima volta la “Nausea” tenendo in mano un ciottolo, ma non sa dargli un nome, non lo realizza sul momento, è restio ad indagare su quella strana sensazione, fino a quando, una decina di pagine dopo prova di nuovo la stessa repulsione: “Ora me ne accorgo, mi ricordo meglio ciò che ho provato l’altro giorno, quando tenevo quel ciottolo. Era una specie di nausea dolciastra. Com’era spiacevole! E proveniva dal ciottolo, ne son sicuro…”. 3
Antoine Roquentin è uno storico che da tre anni si è trasferito nella cittadina di Bouville per lavorare ad una dettagliata ricerca storica su tale marchese Rollebon. Mentre il pittore di Moravia è dottore e paziente di se stesso, Roquentin è malato di qualcosa che egli inizialmente rifiuta: nella prima pagina del suo diario racconta del momento in cui ha sentito per la prima volta la “Nausea” tenendo in mano un ciottolo, ma non sa dargli un nome, non lo realizza sul momento, è restio ad indagare su quella strana sensazione, fino a quando, una decina di pagine dopo prova di nuovo la stessa repulsione: “Ora me ne accorgo, mi ricordo meglio ciò che ho provato l’altro giorno, quando tenevo quel ciottolo. Era una specie di nausea dolciastra. Com’era spiacevole! E proveniva dal ciottolo, ne son sicuro…”. 3
Al contrario di Dino, Roquentin non sa mai con precisione definire questa nausea, va per analogie, descrive ogni cambiamento che il suo corpo nauseato produce, egli è scientifico ma soltanto nella redazione fedele dei suoi crolli che rischiano in certi momenti di non poter essere contenuti dalla pagina, è esattamente sul filo dell’incomunicabile, ed è proprio perché quelle sensazioni sono nuove per lui quanto per noi che leggiamo per la prima volta. La storia di Antoine è la cronaca di un malato che scopre la sua malattia; quella di Dino è il racconto della debole terapia di guarigione.
In entrambi i romanzi, il rapporto di microcosmo come specchio del macrocosmo dominatore si capovolge: gli oggetti semplici della quotidianità sono la scintilla dell’alienazione; per lo storiografo di Sartre sono il ciottolo, la pagina ingiallita per strada, o il bicchiere di birra di cui l’uomo non sostiene lo sguardo; lo stesso bicchiere che quando “avvizzisce” davanti al pittore di Moravia scaturisce in lui la noia, l’impossibilità di crearne un contatto logico quanto il modo in cui l’oggetto si palesa: queste alienazioni avvengono in maniere diverse, ma rimane il fatto che strania il protagonista e lo stesso lettore quando legge che questi due uomini sono in un rapporto di inferiorità nei confronti di un bicchiere di vetro!
Lo sviluppo successivo è una conseguenza drammatica quanto logica: entrambi i protagonisti dei due romanzi perdono la certezza della loro identità, la quale invece di perdersi nel nulla cosmico si attacca a qualcos’altro come un virus: Antoine Roquentin si accorge di essere e conoscere più il marchese Rollebon oggetto dei suoi studi – peraltro una figura dalla personalità mediocre e dall’importanza storica ancora minore – che non se stesso; ed ugualmente il pittore Dino comincia una relazione di plastica con Cecilia, l’ultima delle ragazze del suo anziano vicino di studio Balestrieri (anch’egli pittore) il giorno dopo che quest’ultimo era morto davanti a lei durante un amplesso sessuale. Dal momento della sua morte, Balestrieri, mediocre pittore a cui Dino non aveva mai prestato alcuna attenzione, diventa un ossessione, l’unico argomento nelle piatte conversazioni tra i due nuovi amanti; Dino vuole essere sicuro di non diventare uno schiavo succube dell’enigmaticità della ragazza come lo era diventato Balestrieri, ma è esattamente ciò che diventa pagina dopo pagina.
La Noia e la Nausea mangiano a poco a poco questi due uomini in maniere quasi diametralmente opposte che finiscono per incontrarsi nell’essenza o nella mancanza dell’essenza del tutto: Dino è sopraffatto dall’impossibilità di annoiarsi completamente di Cecilia, giungendo a tentare di oggettivarla pagandola per fare sesso, mentre lei al contrario sembra costantemente disinteressata e annoiata da lui, cosicché egli la possiede senza veramente possederla, e la desidera quando ella gli sfugge; questo innesca un insano cortocircuito in cui il pittore che non dipinge vuole assolutamente possedere per un attimo a tal punto Cecilia, da staccarla da quella noia che per la prima volta lo vede oggetto, e da annoiarsi a sua volta di lei sin dal secondo successivo, e per portare a compimento questa macchinazione vorrebbe sposarla.
Dal canto suo Antoine Roquentin è sommerso dall’improvvisa rivelazione dell’esistenza mentre si trova in un giardino pubblico; il passo è molto teso, onirico e allo stesso tempo rivelatorio di quel qualcosa in più che tutto permea, che di tutto è sostrato e che rende i significati particolari di una pochezza avvilente: tutto è di troppo, compreso lui stesso; la chiave della sua nausea è ora ben più chiara, ma questo non sembra assolutamente a guarirlo sul momento.
“Non posso dire di sentirmi sollevato né contento: al contrario, è una cosa che m’accascia. Soltanto, il mio scopo è raggiunto: so quello che volevo sapere; tutto quello che m’è accaduto dal mese di gennaio l’ho capito ora. La Nausea non m’ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto; ma non la subisco più, non è più una malattia né un accesso passeggero: sono io stesso.” 4
 Il finale invece, si rivelerà decisamente inaspettato in entrambi i romanzi; l’uomo di Sartre, come fosse un’alternativa all’Ulisse moderno di Joyce è statico, paralizzato come Leopold Bloom, ma è decisamente più omerico nella sua rinascita dal baratro della morte intellettuale, e come Ulisse finisce il suo viaggio fin nell’Inferno per cominciarne un altro. Moravia è decisamente meno convincente, o meglio, è difficile accettare da lettore la tranquillità con cui Dino, sopravvissuto ad un tentativo suicida, conclude dicendo:
Il finale invece, si rivelerà decisamente inaspettato in entrambi i romanzi; l’uomo di Sartre, come fosse un’alternativa all’Ulisse moderno di Joyce è statico, paralizzato come Leopold Bloom, ma è decisamente più omerico nella sua rinascita dal baratro della morte intellettuale, e come Ulisse finisce il suo viaggio fin nell’Inferno per cominciarne un altro. Moravia è decisamente meno convincente, o meglio, è difficile accettare da lettore la tranquillità con cui Dino, sopravvissuto ad un tentativo suicida, conclude dicendo:
“Così, alla fine, il solo risultato veramente sicuro era che avevo imparato ad amare Cecilia, o meglio, ad amare senza più.” 5
1 Alberto Moravia, “La Noia”, Bompiani, 1971, p. 7
2 Ivi p.9
3 Jean-Paul Sartre, “La Nausea”, Einaudi, 1990, p. 13
4 Ivi p.130
5 Alberto Moravia, “La Noia”, Bompiani, 1971, p. 347
Articolo a cura di Leonardo Passari