I luoghi della mente di Joan Didion
Lettura di "Verso Betlemme"
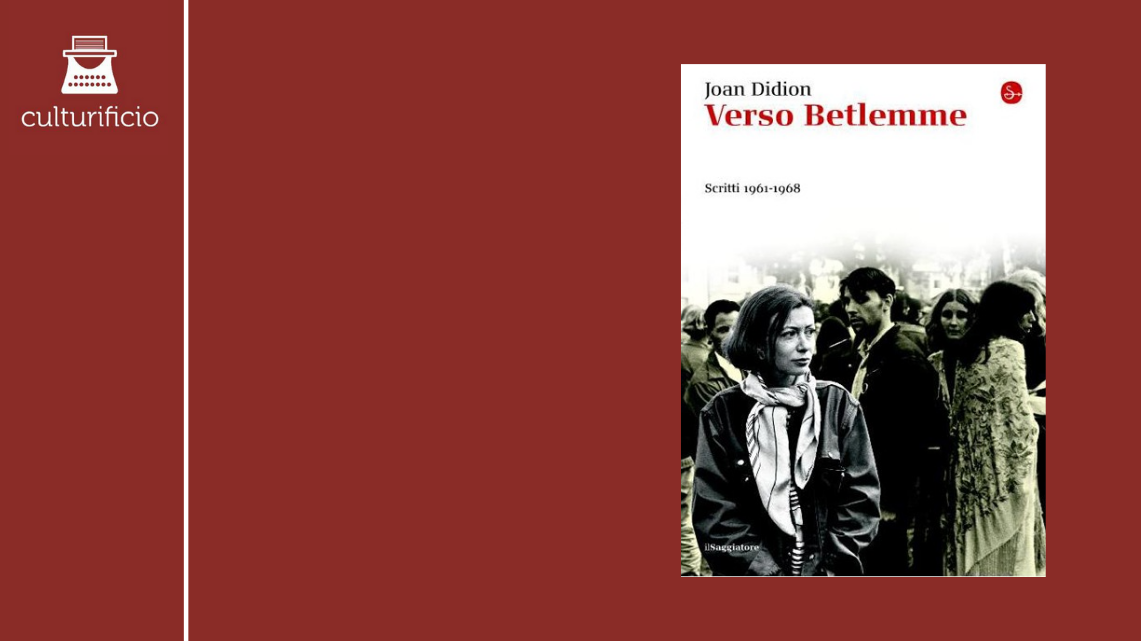
All’inizio del 2020 – non ricordo il mese – ho scritto sul quaderno dove annoto le mie letture che avrei voluto leggere Joan Didion entro la fine dell’anno. Nella mia mente leggere Didion equivaleva ad aprire l’ebook de L’anno del pensiero magico che staziona sul mio kindle da tempo, ma alla fine ho letto Verso Betlemme.
Si tratta di una raccolta di articoli e reportage scritti negli anni Sessanta e probabilmente non l’avrei mai cominciato se non fosse stato per il gruppo di lettura al quale partecipo da quest’estate. Non pensavo nemmeno che sarei arrivata a scrivere qualcosa su questo libro, finché non ho letto l’ultimo pezzo, Bei tempi addio, nel quale si parla di New York, dell’avere vent’anni e dell’averne ventotto, di costa est e di costa ovest. Non saprei dire per quale motivo il mio cervello abbia fatto quest’associazione, ma mi sono ritrovata a pensare alla Rob interpretata da Zoë Kravitz nella versione di High fidelity che è uscita nel 2020. C’è questa scena molto peculiare in cui Rob è seduta su una poltrona del suo salotto, guarda direttamente in camera e dice qualcosa come: «Mettere insieme una playlist è un’arte» e «una playlist non la puoi ascoltare con lo shuffle, devi andare dalla prima all’ultima canzone, seguire l’ordine». Credo fortemente nel fatto che Verso Betlemme sia per la maggior parte una costruzione, precisissima e fondante; leggere in ordine sparso gli articoli che contiene non avrebbe senso. Bisogna partire da Sognatori del tempo dorato e arrivare a Bei tempi andati senza scorciatoie. Finito tutto, la sensazione sarà quella di essere usciti da qualche minuto d’apnea. E invece la lettura è durata un paio di ore, forse tre.
Joan Didion è giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, saggista e, sicuramente, mi dimentico qualcosa. È nata nel 1934 in California, e viaggiò molto, nei primi anni della sua vita, fino a che nel 1943 insieme alla madre non si stabilisce a Sacramento. Spesso il suo nome viene fatto quando si parla di New Journalism e leggendo Verso Betlemme è molto chiaro il perché. È uno stile di scrittura nato intorno agli anni Sessanta, in particolare nelle zone di New York e della California; al suo interno i confini tra letteratura e giornalismo sono molto labili ed è previsto l’inserimento di moduli tipici della narrativa così da rendere più immersiva l’esperienza del lettore. Tom Wolfe conia il termine nel 1973, indicando anche i requisiti del nuovo stile, elencati nella sua stessa antologia, The New Journalism: ridurre al minimo l’intervento del cronista, costruendo l’articolo per scene che si succedono come all’interno di un romanzo, inserire dialoghi anziché nudi dati, caratterizzare i personaggi tramite dettagli e particolari anche apparentemente insignificanti, presentare le scene dal punto di vista del personaggio, e non prenderne dunque le distanze.
Verso Betlemme è costruito su tali regole, nella prima parte (Stili di vita della terra dorata); nelle altre due – Personali e Sette luoghi della mente – l’operazione di Didion si fa, a mio avviso, ancora più interessante, tanto da avvicinarsi a quel che si trova in un qualsiasi libro di Emmanuel Carrère. I libri dello scrittore francese sono inclassificabili: memoir, reportage, autobiografie, biografie, personal essays. Sono miscugli apparentemente inimitabili e certo ben costruiti che hanno consacrato Carrère come inquilino stabile dell’olimpo degli scrittori contemporanei.
Gli articoli di Didion me l’hanno ricordato, almeno in parte. Sono pezzi più brevi e per forza di cose, concentrando tutta la propria carica in una decina, quindicina di pagine al massimo, l’autrice ottiene un risultato diverso rispetto a libri che di pagine ne hanno venti volte tante. Eppure, c’è qualcosa di ugualmente intenso nelle parole che Joan Didion incasella con cura nei suoi scritti.
Non mi venne in mente di chiamare un dottore, perché non ne conoscevo nessuno, e sebbene avessi pensato di chiamare la reception per chiedere di spegnere il condizionatore, non mi decisi mai a farlo, perché non sapevo quanto lasciare di mancia a chiunque fosse venuto – qualcuno era mai stato così giovane? Vi sto giusto dicendo che qualcuno lo era. In quei tre lunghi giorni non feci altro che parlare in interurbana col ragazzo che già sapevo non avrei mai sposato in primavera. Sarei rimasta a New York, gli dissi, solo sei mesi, e intanto vedevo il ponte di Brooklyn dalla mia finestra. In realtà il ponte era il Triborough, e io mi fermai otto anni.
Didion è – credo, o almeno questa è l’impressione che ne ho ricavato – una di quelle figure in grado di affascinare inevitabilmente le persone che le stanno intorno. Tramite la lettura del solo Verso Betlemme si percepisce già un certo magnetismo ed è come se attraverso la lettura si potesse formare un rapporto molto stretto tra l’autrice e chi sta dall’altra parte. Non sono solita fantasticare sulla persona che si cela dietro il narratore delle storie che leggo, ma immagino che questo sia un caso limite.
Nel momento in cui Didion parla della prassi di tenere un diario – in Sul tenere un taccuino – la sua immagine di scrittrice è particolarmente nitida e, quando parla del fallimento (Sul rispetto di sé) lo è altrettanto quella di donna. Il grande pregio di Verso Betlemme credo sia quello di non aver fatto sconti e di aver seguito un percorso che, a posteriori, appare chiarissimo. La raccolta è un ritratto veridico e crudele degli Stati Uniti degli anni Sessanta, il quale conta anche la narrazione magistrale del mito del Flower Power che Didion ha lasciato nell’articolo che dà nome al libro e quella di un processo che finisce per diventare l’emblema del sogno americano fallito. Joan Didion è stata capace di mantenere uno sguardo particolarmente lucido. Ciò le ha permesso di analizzare, quasi vivisezionando, eventi che a un primo sguardo non avrebbero suscitato alcun interesse. Al tempo stesso però (ed è il punto forte del libro), calata all’interno di un contesto sociale descritto con grande consapevolezza e un certo distacco, c’è l’esperienza particolare di una donna che prova a rapportarsi con sé stessa con l’analiticità di cui è capace quando parla di Sposalizi assurdi e di John Wayne.
Il risultato è dei più felici, a mio parere: Joan Didion ha fatto propria la massima che consiglia agli scrittori di impiegare all’interno delle proprie opere tutto quello che possiedono, in termini astratti e concreti, e ha scritto pagine intense, toccanti, divertenti, passando dalla cultura pop ai classici della letteratura, costruendo anche una sorta di educazione che si basa sul rispetto di sé inteso come una sorta di disciplina orientale e su una consapevolezza ferma dei luoghi fisici o mentali che le hanno dato asilo.
Quel tipo di rispetto di sé è una disciplina, un abito mentale che non può essere simulato, ma può essere sviluppato, migliorato con la pratica, indotto con la forza. Una volta mi consigliarono, come antidoto al pianto, di mettere in testa un sacchetto di carta. Di fatto, c’è una solida ragione fisiologica per fare esattamente questo – ha qualcosa a che vedere con l’ossigeno – ma l’effetto psicologico è di per sé incalcolabile: è estremamente difficile continuare a fingersi la Cathy di Cime tempestose con la testa in un sacchetto del supermercato. Ci sono argomentazioni analoghe per tutte le piccole discipline.
Didion scrive e sembra che sia molto facile farlo, per lei, quasi come sedere al bar di La Scala a Beverly Hills; Verso Betlemme scorre liscio dall’inizio alla fine e non ha sussulti, né passi che stridono. Più ci si avvicina, però, questa impressione viene a cadere e tutta la fatica del lavoro che l’ha portata a comporre la raccolta è lì, solo abilmente coperta da pagine di grande grazia. Ci si avvicina, e sono evidenti le crepe sulla facciata di un paese che – ora è chiaro – sta andando in frantumi. Joan Didion l’ha intuito e ha intrecciato biografia e giornalismo per restituire l’immagine meravigliosa di un’America che di lì a poco sarebbe crollata, accartocciandosi su sé stessa.