“Come fanno le volpi” di Ulderico Iorillo
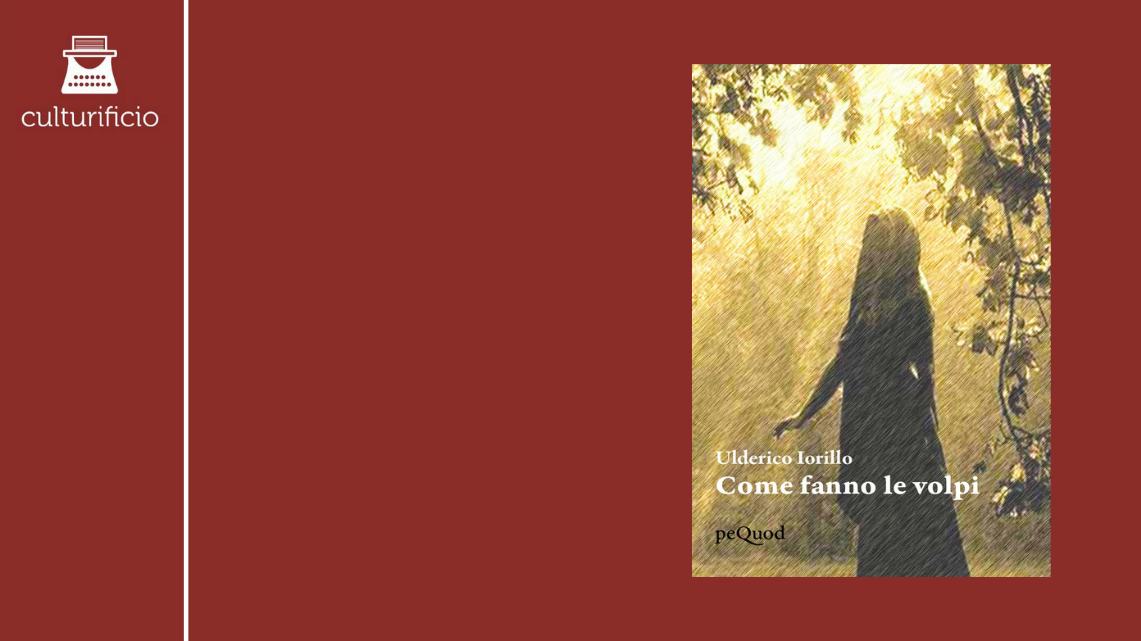
Quello di Ulderico Iorillo, autore di Come fanno le volpi (Italic Pequod), è un esordio audace. Il romanzo, infatti, si fonda su due premesse ambiziose: quella di ambientare il testo nell’Italia postunitaria, uno dei luoghi più mirabilmente indagati dalla nostra letteratura; quella di narrare con la sfrontatezza del cantastorie e del mistico. L’autore scrive così un romanzo nuovo, ambientato negli Abruzzi di fine Ottocento, anche se la terra vera e dura affiora soltanto qua e là, spesso relegata ai racconti dei personaggi secondari.
Una terra di eredità orribili: luogo di brigantaggio, soprattutto, e denso di quella cultura gretta, incrudita che – questa sì – ha spesso permeato le pagine della letteratura italiana postunitaria. Così Iorillo tocca, non segue, le tracce dell’immenso patrimonio cui si allaccia. Il testo colpisce per il distacco incantato con cui scruta – e inventa – un mondo solo in parte circoscritto nel tempo e nello spazio. Perciò nel romanzo non picchia il sole cocente della realtà – piuttosto, si spande l’ombra pallida della magia, il sospiro tenue del soprannaturale, il tormento stavolta tenace di un’umanità che, al di là dell’ambientazione storica, sembra punta da angosce profonde ed eterne. Se questa caratteristica ha indotto l’autore a far sparire, a volte, il dialetto nei dialoghi, la soluzione lascia perplessi, perché non sembra univoca e talvolta porta al tradimento dei personaggi.
In questo caso, Iorillo ritrae a torto la mano mentre altrove, con grande merito, l’affonda: il romanzo, infatti, se per genere e ambientazione può sembrare a prima vista timido o artificiosamente ritroso, a uno sguardo più acuto si mostra in verità temerario nell’approccio al mondo circostante. La sfrontatezza con cui tocca le corde più delicate della riflessione religiosa, culturale, esistenziale, che risponde alla seconda, più grande ambizione su cui si fonda il libro, sfida l’ottusità di molta letteratura odierna, trincerata in un realismo tanto stretto da sembrare parco.
Iorillo, dicevo, affronta il mondo con la voce del cantastorie e la penna del mistico: investe tutti i più alti, fondamentali temi dell’esistenza – bene e male, amore e morte, ragione e mistero – e li affronta con un’impetuosa forza nomenclatrice. Mistico e fanciullo, dà loro un nome, una forma, un principio di realtà che si fa corpo – e allora visibile e invisibile si confondono, le forze che agitano il cuore del protagonista sono le stesse che intonano l’ululato diabolico di un lupo, esse sono il lupo e ogni cosa è la sua paura, mentre fioccano numerose le metamorfosi e le entità spirituali si coagulano in figure reali. Il lettore impara a dubitare tanto del principio di causalità quanto di quello di casualità: la natura e l’uomo diventano le corde su cui soffia un vento che l’autore, attraverso rivelazioni oniriche e prosopopee fantastiche, tenta di incanalare nella prosa. Nel complesso, il romanzo riesce nel folle intento di racchiudere in sé tutto il mondo, intrecciando fatti, pensieri e sogni con un ritmo e una naturalezza che incantano.
Sin dalla prima pagina, dunque, Come fanno le volpi intreccia nascita e morte: si apre con la nascita del protagonista, Aris, che porta la morte della madre. Nato all’ombra del fumo che s’alza da una casa in fiamme in un piccolo paese del Matese, circondato dai monti dell’Appennino, Aris è forgiato da un male atavico. Del resto quelle fiamme – scoprirà poi il lettore – sono il prezzo di un patto truce e violento. La nascita di Aris acquista così i contorni di un fatto epico e il bambino si presenta al mondo come un dio, mentre il mondo lo tratta come un figlio indesiderato.
Allevato da una nomade ebrea dai poteri occulti, unica del paese in grado di ammansirlo, il “principe dei monti”, destinato a ereditare il potere sulle montagne che si stringono come una corona intorno alla sua grande casa, decide a quattordici anni di fuggire. Fugge da Calena, ostile paese di malelingue come quelli di Verga e di Silone; fugge, soprattutto, dalla violenza insensata del padre, uomo di potere che gli nega qualsiasi prova di affetto. Fugge anche, forse, da un’assenza – quella della madre –, in parte sopperita dall’amore di Anna, in parte mai davvero colmata.
Il romanzo prende forma, allora, in questo viaggio folle. Quale sia la sua meta, Aris non lo sa: semplicemente, fugge – e la fuga nei boschi diviene il teatro di una fitta serie di epifanie foriera di meraviglie e orrori, crescita e conoscenza. Germina allora sulle pagine una variegata trama di topoi; vibrano, sotto il drappo di un meridione postunitario, persino echi della letteratura stilnovistica e del romanzo bretone.
Così i boschi in cui, per gran parte della storia, Aris si trova a muoversi, sembrano quelli misteriosi e un po’ magici di Chrétien de Troyes. Come in Perceval il Gallese o Il racconto del Graal, un fanciullo orfano di un genitore prende la via dei boschi; come Perceval, ancora, trova, tra le fronde, un cavallo. Ma non «magro e stanco»: è «un murgese dal manto nero e lucido» che diventerà, nella fuga, la sua guida.
Tuttavia, roso dalla paura per l’ululato di un misterioso lupo che, senza farsi vedere, non gli dà pace, ostacolato dai dubbi della sua infanzia infelice, Aris si accorge di girare in tondo, di non riuscire ad abbandonare il monte-labirinto teatro del suo perenne vagabondaggio.
Oscillando tra il realismo dei riferimenti storici e lo psicologismo di un tema, quello della rivalità tra figlio e padre, tra i più peculiari della letteratura post-naturalistica, Iorillo narra la storia della crescita di un bambino che diventa adulto. La perdita dell’aura di Michele Parrella, il “re dei monti”, il padre tiranno, diviene l’elemento liberatore, ciò che permette la fuga e, insieme, la accorcia.
Perciò Come fanno le volpi narra la storia di una fuga angosciosa, sì, ma densa delle più importanti esperienze di vita, madre di un cambiamento radicale.
Anche qui, benché lo sguardo del narratore non si distolga dal passato – non mancano, soprattutto per via del contesto, echi di De Roberto e Tomasi di Lampedusa, mentre l’uso isolato di “cafoni” ha un precedente illustre in Silone –, il testo respira.
Respira soprattutto grazie a una prosa limpida e frammentaria, pulita ma non fredda: piuttosto, silenziosa, strettamente aderente alla realtà romanzesca, di cui tace sempre l’inessenziale. I suoi punti più alti, comunque, li raggiunge quando sembra tradire un’ispirazione cinematografica: muovendo il proprio sguardo con grande senso del tempo, l’autore procede allora per paratassi, con inquadrature strette e icastiche. E grazie alla lente di una lingua ricca di anafore, iterazioni, onomatopee – geniale il «vai via di qui» con cui esorta, una mattina, il gallo –, la materia narrata vive. Vive e, sospinta dalla polifonia che la sostiene, riesce a coinvolgere il lettore, non manca mai di stupirlo.
di Carlo Danelon