“Album di famiglia” di Alaíde Ventura Medina: fotografare l’indicibile
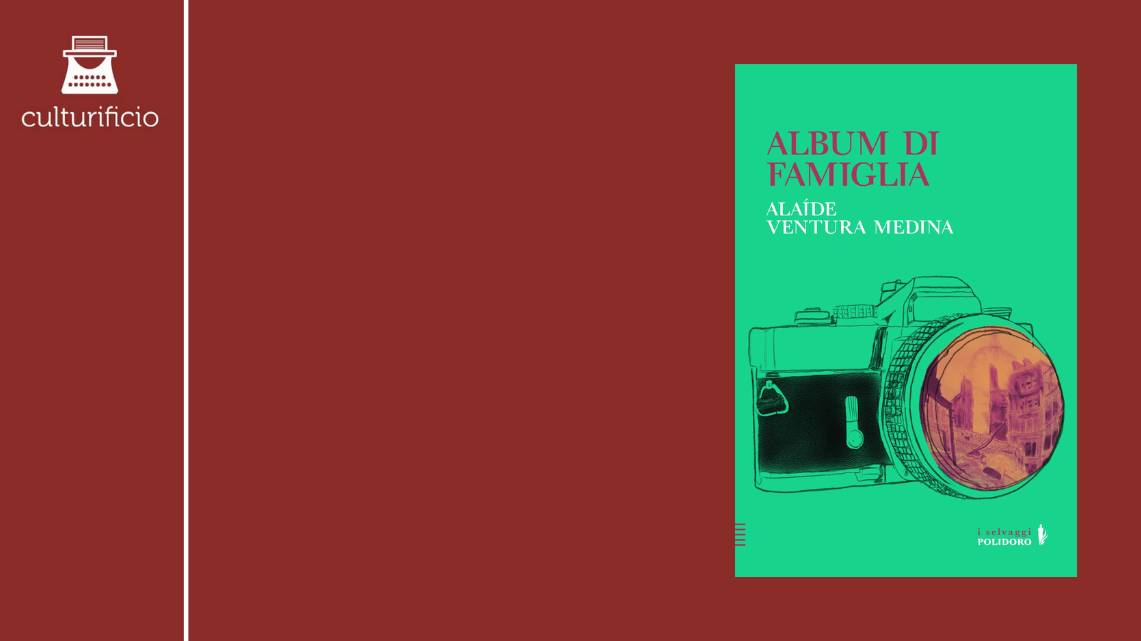
Album di famiglia di Alaíde Ventura Medina (2023, Polidoro editore, traduzione di Sara Papini) è un romanzo che si sviluppa attorno alle parole e alla loro assenza, imperniato sulla presenza ingombrante dei genitori e sui loro fantasmi. L’autrice, con una finezza quasi dolorosa, condensa in duecento pagine le guerre interne e i traumi di chi si trova a crescere in una famiglia disfunzionale.
Alaíde Ventura Medina, classe 1985, è un’antropologa messicana alla sua seconda prova letteraria. Il titolo originale del testo è Entre los rotos, tra chi è rotto, ed è la stessa narratrice a chiarire la sfaccettatura semantica di questa espressione all’inizio della seconda sezione del romanzo:
Tra persone rotte ci riconosciamo facilmente. Ci attraiamo e ci respingiamo allo stesso modo. Formiamo un club triste e sconfitto. Siamo il villaggio fondato accanto al vulcano, la città eretta su un terreno instabile. Tutti i giorni sono il giorno del grande terremoto. Il nostro popolo verrà spazzato via. Da un momento all’altro sparirà dalla faccia della Terra.
Si colloca su una faglia, dunque, questa giovane voce narrante che da sempre si è trovata in bilico tra l’amore materno e la fedeltà che sente nei confronti del padre, costretta a dover scegliere da che parte stare, come se fosse una guerra e lei si riscoprisse soldato, destinata a morire tra un tradimento e l’altro, divisa tra la realtà e le bugie che hanno costellato la sua infanzia.
Attraverso la descrizione interiore e personale, il romanzo si configura come una narrazione della violenza domestica, e allo stesso tempo come uno spaccato sociale del Messico, lasciato però con le sue contraddizioni solo sullo sfondo, tratteggiato, così da poter avere un valore quasi universale.
Questa protagonista, di cui non conosciamo il nome, di cui non riusciamo neanche ad afferrare tutti gli spigoli del carattere, procede per giustapposizione di ferite, liste con cui scandisce e descrive le persone o determinati momenti vissuti, relazioni a partire da scatti ritrovati: oltre al padre violento, l’altro fuoco dell’ellisse della sua famiglia è rappresentato dal fratello, più che dalla madre.
Il racconto della donna prende dunque il via dal fatto che il fratello Julián le ha lasciato, come un Pollicino, una scia di fotografie che ora lei si ritrova a seguire per ricostruire la storia della sua famiglia, e soprattutto per ricucire lo strappo nel rapporto paterno. Ci sono diversi modi per scomparire, e Julián anni prima ha scelto il silenzio, si è richiuso su di sé come un animale ferito incapace di difendersi, e in qualche modo ora la narratrice cerca con questo percorso di raggiungerlo e capirlo.
Scriveva Roland Barthes all’inizio del suo famosissimo saggio sulla fotografia, La camera chiara (1980):
Si direbbe che la Fotografia non sia classificabile. Mi chiesi allora da che cosa poteva dipendere quel disordine.
In primo luogo, scoprii questo. Ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta: essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai più a ripetersi esistenzialmente. In essa, l’avvenimento non si trasforma mai in altra cosa: essa riconduce sempre il corpus di cui ho bisogno al corpo che io vedo; è il Particolare assoluto, la Contingenza sovrana, spenta e come ottusa, il Tale, in breve la Tyché, l’Occasione, l’Incontro, il Reale nella sua espressione infaticabile.
La protagonista, guardando le foto scattate dal fratello, talvolta anche banali e senza chissà quale significato, vede e cristallizza la sua famiglia, sé stessa, non solo nella superficie dei sorrisi tirati delle pose, degli sguardi catturati dall’obiettivo, ma anche nel nucleo più profondo della propria esistenza. Sfogliando quei casuali reperti visivi, scava dentro al tempo perduto e ritrovato, per ricostruire anche chi è stata e chi è oggi.
Il lettore, pagina dopo pagina, si ritrova a essere spettatore di intere vite, come un ospite tanto atteso che, una volta invitato nel salotto, riceve tra le mani uno di quei vecchi album di famiglia – rituale ormai demodé con l’avvento della fotografia digitale. Ma nello sfogliare le diverse istantanee, più che in ricordi divertenti e aneddoti trasfigurati dalla memoria, si imbatte nel passato costellato di memorie dolorose, grondanti incubi e dolore della narratrice:
Recuperare oggetti tra le macerie ha senso soltanto quando si tratta di ricordi preziosi. Ma queste fotografie non sono altro che piccoli abissi personali, ferite mal cicatrizzate.
Foto al mare, foto sull’altalena, foto nella casa nuova strappate dal risentimento. Scatti di due, tre, quattro persone bruciate dall’abuso. Un primo piano di un compleanno, un ritratto di un genitore da bambino, un’immagine di un animale più o meno domestico squarciate dall’abbandono. Nessun momento catturato può salvarsi davvero dalla sofferenza, tutte le foto raffigurano attimi che hanno preceduto una violenza, uno scoppio d’ira, un momento di crisi familiare.
La narratrice le presenta al lettore con cura. Si riscontrano nel corso della narrazione una catalogazione e una descrizione puntuali, premurose quasi, per queste foto che diventano il lessico famigliare quando non ci si può parlare più e non può costruirsi una complicità, spezzata dalla scelta fraterna.
Cavarsela senza un alleato non è impossibile. È solo più difficile. La storia dovrà essere ricostruita da zero. Ma comunque, pure accompagnati, risulterà inesatta.
La prosa è uno degli elementi più riusciti del romanzo. La narrazione procede attraverso frasi brevi e spezzettate, come se le proposizioni stesse fossero istantanee appena scattate. C’è una costante urgenza di dire, una tensione nervosa nel cercare di comunicare l’incomunicabile. Alaíde Ventura Medina sceglie e dosa le parole che sembrano esercitare una pressione continua, una stessa violenza costante e allo stesso tempo quasi impalpabile. Talvolta la scrittura si fa definizione, plagiata e condizionata da quel gioco inventato dal padre – «che ha sempre voluto avere figli intelligenti» –, dalla sua ossessione per il linguaggio che ha trasmesso ai figli, fino ad arrivare all’assenza e alla negazione della parola per Julián, picchiato da bambino con un dizionario. Ed è come se attraverso questa selezione lessicale, attraverso gli elenchi e le didascalie, la narratrice cercasse di limitare, imbrigliare e rendere esatto qualcosa di inafferrabile e indicibile come i rapporti tra familiari.