“Binari” di Monica Pezzella
due nazioni separate dal desiderio
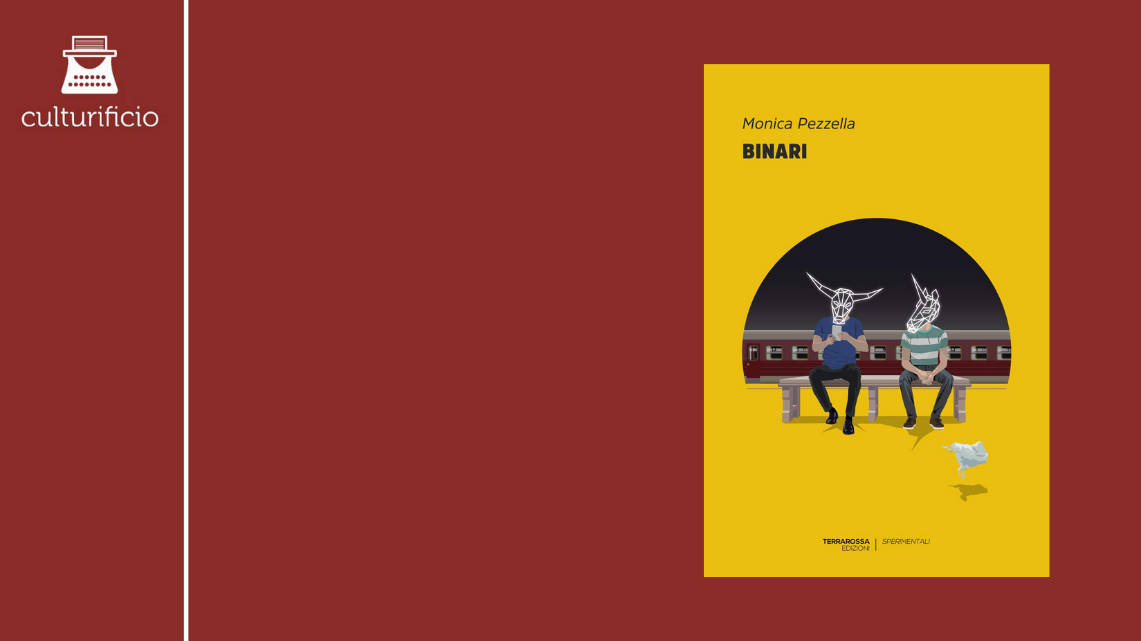
Tu intanto sai solo che ti stai muovendo su un binario, all’interno di un segmento, non hai un tempo determinabile, puoi andare avanti o indietro quante volte ti pare, far cambiare direzione al convoglio, smontare, rimontare, spostarti in tutti quegli istanti rinchiusi e rimescolare.
In Un tram che si chiama Desiderio, dramma di Tennessee Williams poi adattato nell’omonimo film, la protagonista Blanche Dubois viaggia tra due capolinea ideali: la morte e l’aspirazione, opposti e indistricabili.
La disincarnata e simpatetica Voce di Monica Pezzella ci invita a vivere un’esperienza affine, e a interpretarla; con la differenza che nel suo Binari, brevissimo romanzo edito a fine 2020 da TerraRossa Edizioni, ogni confine si fa tanto labile che la “e” che congiunge gli opposti muta sempre, inesorabilmente, in “è”: ogni fermata dell’itinerario si trasforma nel suo contrario. Così Fine è anche Inizio e Prima è anche Dopo; amore è odio, malattia, morte.
L’esordio di Pezzella trova il suo habitat naturale nella collana Sperimentali, rivolta a chi crede che «la letteratura debba sorprenderci, indagando il nostro tempo, rappresentando ciò che sfugge al nostro sguardo o forzando i margini della realtà»; ancora, Binari si cimenta in un’impresa persino più folle: scavare oltre la superficie di riverberi e specchi precipua della postmodernità.
Come in musica, Pezzella si muove sulla corda del sol, la più bassa del violino (quella che dà il nome alla rivista di cui è fondatrice e direttrice, Sulla quarta corda) fino a toccare quanto di noi stessi non vorremmo vedere.
Due ragazzi si incontrano, si amano, si allontanano. Marcel è architetto, Ale una «puttana». Una storia semplice dall’intreccio complesso, frammentario (sottolineato dall’omissione sapiente delle virgole, dai periodi che scorrono l’uno nell’altro) e temporalmente quasi privo di coordinate, fatta eccezione per la linea di demarcazione tra l’avanti Ale e il dopo Ale: un intreccio «con testa e coda smontabili e intercambiabili a seconda della direzione», dove però il lettore ingenuo ne vede una sola, e comunque viva e pulsante al cambiare di modi e tempi verbali, di punto di vista, di focalizzazione.
E sui binari della narrazione si dipana anche una fitta rete di simboli.
C’è la stazione visitata quotidianamente da Marcel per tornare al «luogo immobile», la casa: il calderone stesso dell’entropia, sineddoche della città di cui Ale è frutto e creatura. Nella stazione le individualità si separano, si diramano in vite parallele come quella di Ale, che si reinventa per ciascuno dei suoi clienti. Ma il caos regna anche sullo scrittoio di Marcel, un «rompicoglioni» amante di simmetrie e cattedrali, «che in teoria non andava a puttane ma in pratica desiderava quella puttana come un animale, un poco di più ma a volte persino meno di un animale».
C’è la casa, idealmente il rifugio, in realtà palcoscenico di un dramma da cui non si può sfuggire, perché coinvolge due sé che si spogliano dagli artifici urbani, nudi e vulnerabili di fronte agli inganni dell’incomunicabilità.
C’è la finestra, attraverso cui spiamo lo stato d’animo di Marcel e di Ale, che prende corpo in violenti temporali che battono contro i vetri o cieli sereni che segnalano una spaventosa inerzia foriera di morte.
C’è Beautiful Losers, quadro del contemporaneo Jack Vettriano, che incarna la definizione dell’amore secondo Marcel: «Tra amanti e perdenti c’è poca differenza».
Se l’ossatura di Binari si impernia su una complessa rete di astrazioni, la riflessione sull’amore, tanto onesta da sfociare nel blasfemo, dà compiutamente carne all’opera.
Per gli evangelisti stava nel cuore, è simbolico. Non trovate che il simbolismo cristiano abbia fatto di tutto per levargli qualsiasi accezione veramente, intendendo veramente veramente, fisica?.
Il muro ipocrita tra fisico e spirituale cade quando l’incontro con l’anima gemella si traduce in una reazione organica; il corpo si fa espressione dell’anima, e così Marcel ama Ale tanto da voler diventare lui e Ale vorrebbe che l’amante riempisse il vuoto dell’anima con la sua «normalità».
Marcel aspira a fare di Ale una novella Daisy Buchanan, incarnazione stessa del desiderare per antonomasia: qualcosa da possedere, di cui gli altri possano godere solo temporaneamente e sotto propria gentile concessione, e di cui lui possa bearsi senza bisogno di chiedere il permesso. Ma ecco che si instaura il meccanismo del bisogno, che lo rende dipendente, schiavo di quanto vorrebbe possedere.
All’opposto, Ale si tende verso la luce verde dell’amore di Marcel.
Perché quello che vuole da lui è un conflitto di forze uguali e contrarie che in ogni scontro non fanno che annullarsi a vicenda. Vuole che non gli dia pace che non lo lasci dormire che non lo lasci lavorare che gli tolga il tempo che si prenda il tempo che lo rubi a tutto il resto. Vuole l’unica cosa di cui dice di aver paura. Perdere il controllo.
Qualcosa a cui aspirare soltanto, qualcosa impossibile da ottenere realmente, o almeno così crede.
Quel suo potere di incorruttibilità rispetto ai sentimenti, quell’irremovibilità glaciale da far venire a chiunque il dubbio che in fondo davvero non provasse nulla, non fosse capace. Qualcosa gli mancava. Doveva controllarsi o gli veniva facile?.
L’amore abita il cuore ed è malattia. In Binari regna il paradosso: Marcel e Ale sono gli innamorati separati dal desiderio nella poesia Foreign Affairs di Stanley Kunitz, «due nazioni in assetto da guerra».
Un romanzo-avventura del corpo: ricettacolo di passione con le sue aperture segrete e disgustose, ma anche ponte di intimità coi suoi movimenti interni; mezzo di espressione e insuperabile ostacolo, soggetto vulnerabile alla reificazione tanto di un cliente quanto di un medico, o dell’anima che lo abita. Contemporaneamente tempio dell’amore e del dolore.
«Da qualche parte qualcuno di molto importante ha scritto “Davanti al dolore non ci sono eroi”». Se un sentimento è tanto primigenio da poter essere espresso solo nell’unione fisica, quando il corpo cede alla malattia la comunicazione viene a mancare, la stabilità, trovata così naturalmente e allo stesso tempo con così tanta fatica, si spezza.
Si è ribaltato tutto, non può semplicemente chiedere, deve pretendere, deve trattarlo male, vuole e non vuole che si prenda cura di lui, di sicuro non vuole chiederglielo.
Lo spazio bianco diventa terreno fertile per fraintendimento, rabbia, metamorfosi, in un odio proteo sempre sul punto di riconvertirsi in amore. Per la separazione.
Marcel, Ale, tragici difetti e tragiche mancanze sono nel fiume del tempo, un’intimità che ci è concesso di spiare a brani di attimi.
Quando «la m delle puttane è morta», «tra le tante cose che si perdono, vanno e vengono», ciò che resta oltre il capolinea è ciò che è stato davvero. Che nella fine trova affermazione di identità e statuto di insostituibilità: «l’amore però è un’altra cosa».
di Lucrezia Pei