“Borgo Polmone” – abitare un luogo che ci consuma
come sono finito qui?
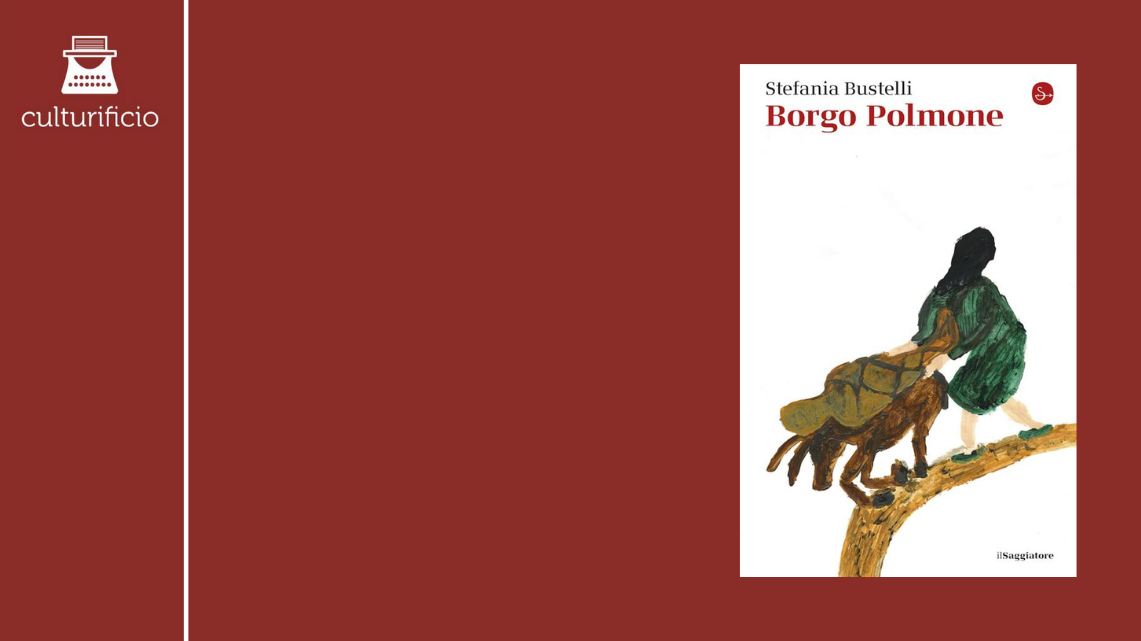
Un viandante senza nome avanza sotto un sole implacabile. Non sappiamo da dove venga, né da quanto tempo cammini. Dopo «chilometri di verde», intravede delle mura medievali: la prima traccia di civiltà. Ma ciò che sembra un approdo è, in realtà, soltanto l’inizio del viaggio.
La mole aggettante del borgo, con le case abbracciate alla roccia, mi ombreggia le spalle, sembra spingermi sul baratro appena percorso. Non mi faccio intimorire e tengo i talloni ben piantati sul terreno scosceso.
L’esordio di Stefania Bustelli, edito da Il Saggiatore, si apre così, con l’ingresso dantesco del viandante-narratore nel borgo che gli appare davanti. Un villaggio dai tratti onirici e spettrali, che richiama la Comala di Juan Rulfo. Un luogo sospeso, la manifestazione di un incubo, un varco tra la propria coscienza e l’inconscio.
Il viaggio attraverso l’oscurità comincia con un incontro: il viandante si imbatte nell’indifferenza di un uomo impassibile di fronte alle richieste di aiuto. Subito dopo, dei bambini lo avvertono: «Il borgo è malvagio».
L’atmosfera è carica di oscurità e oppressione; l’aria è satura di un odore marcescente e la solitudine lo avvolge. Non passa molto tempo prima che il protagonista contempli la morte come possibile sollievo.
Calata la notte, il viandante raggiunge un edificio e incontra una guida provvisoria, un uomo in abito blu che lo conduce all’interno. La sala è addobbata con arazzi che tentano di nascondere il marcio delle pareti senza successo; al centro c’è un tavolo imbandito. Arrivano i commensali e azzannano con foga il cibo. L’uomo ora siede su un trono – dalla descrizione non sembra del tutto umano, ma nessuno nella stanza lo è davvero – e un ago gli viene piantato nel braccio: il suo sangue scorre a riempire una brocca sul tavolo. Tenta di dire qualcosa al viandante, ma le voci degli altri nella stanza coprono la sua. Alla fine si accascia, il suo corpo ha sfamato i presenti in un rituale antropofago. Il protagonista incredulo tenta di resistere alla fame, a questa forma di corruzione senza ritorno, ma non ci riesce.
Siamo avidi, insaziabili, ne vogliamo ancora. […] Il cibo perde consistenza e sapore […] ma una voce grida nella testa e mi ordina di mangiare ancora.
Una volta seduti al tavolo è impossibile fermarsi: si continua a mangiare anche oltre la sazietà. È la logica del consumo, a scapito degli altri e di sé. Uno di loro, il volto scavato e il piatto vuoto, porta cucita sulla giacca la data della sua morte: sarà il prossimo a nutrire tutti con i propri resti. Un sistema che ingloba e si autoalimenta, finché non resterà più nulla. Nessuno, dentro questo ingranaggio, è innocente: il romanzo è un’allegoria feroce del mondo contemporaneo, una parabola cupa e lucidissima sull’estrazione di valore dagli altri – e da noi stessi – che ci lascia senza voce e senza carne. Come sono finito qui? È la domanda senza risposta del protagonista all’inizio del viaggio ma Bustelli sembra suggerirne un’altra: come si esce da un organismo – un polmone – che respira al posto nostro? E ancora, come ci si può sottrarre ai meccanismi che lo regolano, se noi stessi siamo il tessuto che lo tiene in vita?
Ma non finisce qui, perché dopo la scena della mensa arriva il sonno, e con il sonno, il sogno. Il viandante si trova davanti un albero vivo che intrappola gli esseri umani nella sua resina.
Lo stesso ramo che mi ha salvato la vita mi ha appena dato una carezza tagliente e dolorosa. L’albero si contrae in uno spasmo viscerale, vuole liberarsi di me, per lui sono un parassita, un incubo infestante.
In questo punto l’autrice mette in scena un’altra ferita del presente: la natura, stremata dai soprusi, non si piega più all’utile umano. Il ramo che prima salva e poi colpisce diventa manifesto di rivolta come la resina che gocciola e imprigiona gli esseri umani. L’atmosfera onirica e un certo realismo magico sono gli strumenti con cui Bustelli dà voce a una terra esausta, per la quale l’umano è un invasore da neutralizzare. Così, dopo l’allegoria del consumo, l’asse si sposta sui suoi effetti e ci mostra una terra lacerata che smette di accogliere e comincia a respingere.
A questo si collega anche l’episodio del padre e del figlio che vivono all’interno di una carcassa di balena: ogni giorno osservano pezzi di carne staccarsi dalle ossa del cetaceo e si chiedono cosa ne sarà di loro, dove potranno andare, quando della balena non rimarrà più nulla. L’immagine si può leggere nella stessa chiave allegorica: i due abitano una risorsa esausta, sopravvivono all’interno di ciò che hanno consumato e se il corpo finisce, finisce anche il riparo. I pezzi che scivolano via a cadenza regolare come la sabbia in una clessidra danno l’idea del tempo che scorre, dell’impossibilità di fermare questo processo.
Come si sopravvive a tutto questo? Come tollerare la vita nel borgo tra lamenti, disfacimento e morte? C’è un modo di resistere? La risposta è sì, con la parola, la poesia:
Sulla parete dell’edificio sono affissi dei fogli ingialliti. Mi avvicino: sono poesie. Questi pezzi di carta dai bordi stropicciati tengono lontani gli spiriti maligni come antichi guardiani apotropaici.
La poesia è ciò che dell’umano resta e resiste, oltre la corruzione: non redime, ma trattiene il buio. È la prova di ciò che l’uomo può essere. Per questo, nel borgo, rimane l’unico elemento non predatorio, l’ultimo baluardo di un’umanità che sta scomparendo.
Il viaggio è narrato in prima persona dal misterioso viandante senza nome, un uomo di cui non conosciamo nulla, che sembra non avere né passato né futuro. Tutto ciò che sappiamo di lui è che deve riuscire a fuggire da Borgo Polmone. Tuttavia il vero protagonista è proprio il borgo stesso: una presenza viva che – come suggeriscono i titoli dei brevi capitoli – parla, sogna, osserva, vive, brucia. Ogni incontro del protagonista assume forma allegorica, e riflette dolori e paure che non riguardano solo lui, ma anche chi legge.
In definitiva Borgo Polmone è un esordio potente. Bustelli usa una lingua tersa e visionaria, capace di restituire immagini vivide e impressionanti e di sorreggere con coerenza l’impianto allegorico. Non è una lettura rassicurante; non promette salvezza ma ci consegna una postura, lasciandoci con una domanda che non è più «Come sono finito qui» ma «che cosa siamo disposti a smettere di essere per uscire dall’ingranaggio?».
di Silvia Castellani