Chi ha tempo non aspetti tempo: la brevità della vita

La tragica grandezza di un istante o l’evanescenza di un momento, un fulmen che rapisce la vita, la distrugge, o una riflessione che la dilata ad un’ampiezza tale da non permettere di scorgerne i confini?
Seneca sostiene che “non abbiamo poco tempo, ma ne abbiamo perduto molto” e, questa, ritengo sia una verità inevitabile, che oltrepassa l’orizzonte dei secoli. Oggi, più che mai, la fiamma dell’ attimo si consuma sotto gli occhi dell’uomo, incapace di fare ritorno in se stesso.
La prescrizione del suo maestro a Lucilio, nelle Epistulae Morales, è quella di riappropriarsi del tempo necessario a se stessi e rifugiarsi nella propria anima, l’unico luogo in cui la bona mens di un saggio si trova al sicuro. Tuttavia sussiste una grande contraddizione, più di una a dire il vero, ma questa è forse la più lampante, nella concezione senecana del tempo: e cioè che l’immensità di un istante può contrarsi sino a divenire un punto minuscolo ed insignificante. Il filosofo esorta: “protinus vive!”, vivi ora, e sembra affermare, sulla scia epicurea, la necessità di cogliere l’attimo. D’altra parte, però, induce l’allievo a rivendicare la legittima proprietà della sua anima (vindica te tibi) e a meditare, a dirigere le proprie energie, su qualcosa di sublime il cui respiro non si trova all’esterno bensì all’interno di ciascun individuo. Ogni uomo che desideri un otium, nel senso di tempo libero, dignitoso, deve affrontare le medesime problematiche e gestire un’entità che, concretamente, non esiste, non ha corpo, ma di cui avverte incessantemente gli effetti: il tempo.
se stessi e rifugiarsi nella propria anima, l’unico luogo in cui la bona mens di un saggio si trova al sicuro. Tuttavia sussiste una grande contraddizione, più di una a dire il vero, ma questa è forse la più lampante, nella concezione senecana del tempo: e cioè che l’immensità di un istante può contrarsi sino a divenire un punto minuscolo ed insignificante. Il filosofo esorta: “protinus vive!”, vivi ora, e sembra affermare, sulla scia epicurea, la necessità di cogliere l’attimo. D’altra parte, però, induce l’allievo a rivendicare la legittima proprietà della sua anima (vindica te tibi) e a meditare, a dirigere le proprie energie, su qualcosa di sublime il cui respiro non si trova all’esterno bensì all’interno di ciascun individuo. Ogni uomo che desideri un otium, nel senso di tempo libero, dignitoso, deve affrontare le medesime problematiche e gestire un’entità che, concretamente, non esiste, non ha corpo, ma di cui avverte incessantemente gli effetti: il tempo.
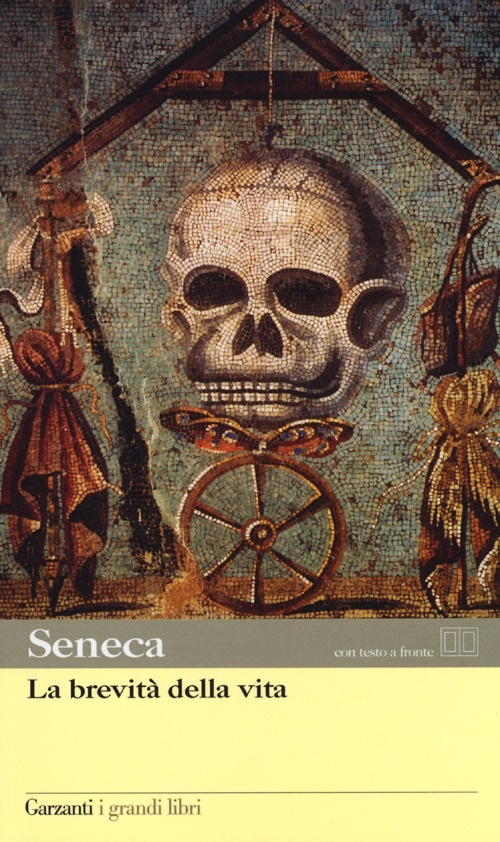 In De brevitate vitae esso è il soggetto del dialogo ed è definito “incorporalis”. Per questa sua caratteristica peculiare, gli uomini non sono capaci di apprezzarlo e, soprattutto, non gli appartiene. In merito a questo fatto, al decimo capitolo si trova una tripartizione in passato, presente e futuro che ha come scopo quello di dimostrare che nemmeno la parte più certa del tempo, quella che è già trascorsa, è propria dell’immanenza. Il tempo non è un mero oggetto di speculazione ma una causa di angoscia: la coscienza e le occupazioni degli “affaccendati” non permettono loro di volgersi indietro con grazia e ripercorrere gli avvenimenti di una vita che precipita verso il termine ultimo. In questo senso le metafore con cui il filosofo preferisce ritrarre il soggetto sono tre: il fiume, il punto e l’abisso. Nel primo caso il tempo si configura come un corso d’acqua inarrestabile, una piena o, più precisamente, con un verbo dalla violenza incontrastabile: “rapio” – “tutto è rapina” sosterrà il filosofo in Consolatio ad Marciam X,4 -. Al contrario, tuttavia, e qui forse si comprenderà meglio la contraddizione di cui sopra, può giungere ad un livello di contrazione tale da divenire un punto, la cui durata si vanifica nell’inconsistenza. Ecco allora che, a livello umano, tempo e spazio si identificano e la vita è “meno di un punto rispetto all’eternità”. Infine, l’autore afferma che esso è di una vastità abissale, incontenibile e che ognuno è sospeso tra il passato ed il futuro senza soluzione, soltanto il saggio ne è al di sopra, come Dio. Affiora, a questo punto, uno dei temi più particolari e discussi della filosofia senecana, la capacità di vivere nel tempo ma senza tempo: l’ucronia. Quella cui Seneca, provato dalle vessazioni di una situazione politica paradossale, anela; nella quale è costretto a verificare le ragioni della meditatio mortis platonica come in De brevitate vitae VII, 3: ” ci vuole tutta una vita per imparare a vivere, e, ciò che forse ti stupirà di più, ci vuole tutta una vita per imparare a morire”. La situazione politica contingente, l’apparente pace imperiale, portò come conseguenza, per la classe di Seneca, una precarietà inesorabile, una continua incertezza: le famiglie senatorie vivevano, citando il Traina, “sospese ad un cenno di Cesare”, e di questo abbiamo chiara testimonianza anche in De clementia. Non vi era alcuna garanzia del domani e fu così che si fece strada la necessità di contemplare la morte, non tanto come danno collaterale quanto come elemento connaturato alla vita quotidiana. È in conseguenza di questo contesto che nasce, in particolare in De Brevitate Vitae, la figura di un saggio che celebra un doppio trionfo sul tempo mediante l’ucronia e l’unione delle tre parti del tempo. Di un saggio che ha bandito timore e speranza dal proprio animo ed è capace di spaziare in ogni anfratto della propria vita, sia nel passato ricordando quanto di onesto e meraviglioso hanno prodotto le grandi menti dell’umanità, sia verso il futuro cui non richiede più di accontentare delle aspettative pregresse ma del quale assapora la previsione. Un saggio in antitesi con gli affacendati, che vadimonia e officia distolgono dalla vita contemplativa e dall’apatia e dall’aristocratica solitudine della quiete perpetua.
In De brevitate vitae esso è il soggetto del dialogo ed è definito “incorporalis”. Per questa sua caratteristica peculiare, gli uomini non sono capaci di apprezzarlo e, soprattutto, non gli appartiene. In merito a questo fatto, al decimo capitolo si trova una tripartizione in passato, presente e futuro che ha come scopo quello di dimostrare che nemmeno la parte più certa del tempo, quella che è già trascorsa, è propria dell’immanenza. Il tempo non è un mero oggetto di speculazione ma una causa di angoscia: la coscienza e le occupazioni degli “affaccendati” non permettono loro di volgersi indietro con grazia e ripercorrere gli avvenimenti di una vita che precipita verso il termine ultimo. In questo senso le metafore con cui il filosofo preferisce ritrarre il soggetto sono tre: il fiume, il punto e l’abisso. Nel primo caso il tempo si configura come un corso d’acqua inarrestabile, una piena o, più precisamente, con un verbo dalla violenza incontrastabile: “rapio” – “tutto è rapina” sosterrà il filosofo in Consolatio ad Marciam X,4 -. Al contrario, tuttavia, e qui forse si comprenderà meglio la contraddizione di cui sopra, può giungere ad un livello di contrazione tale da divenire un punto, la cui durata si vanifica nell’inconsistenza. Ecco allora che, a livello umano, tempo e spazio si identificano e la vita è “meno di un punto rispetto all’eternità”. Infine, l’autore afferma che esso è di una vastità abissale, incontenibile e che ognuno è sospeso tra il passato ed il futuro senza soluzione, soltanto il saggio ne è al di sopra, come Dio. Affiora, a questo punto, uno dei temi più particolari e discussi della filosofia senecana, la capacità di vivere nel tempo ma senza tempo: l’ucronia. Quella cui Seneca, provato dalle vessazioni di una situazione politica paradossale, anela; nella quale è costretto a verificare le ragioni della meditatio mortis platonica come in De brevitate vitae VII, 3: ” ci vuole tutta una vita per imparare a vivere, e, ciò che forse ti stupirà di più, ci vuole tutta una vita per imparare a morire”. La situazione politica contingente, l’apparente pace imperiale, portò come conseguenza, per la classe di Seneca, una precarietà inesorabile, una continua incertezza: le famiglie senatorie vivevano, citando il Traina, “sospese ad un cenno di Cesare”, e di questo abbiamo chiara testimonianza anche in De clementia. Non vi era alcuna garanzia del domani e fu così che si fece strada la necessità di contemplare la morte, non tanto come danno collaterale quanto come elemento connaturato alla vita quotidiana. È in conseguenza di questo contesto che nasce, in particolare in De Brevitate Vitae, la figura di un saggio che celebra un doppio trionfo sul tempo mediante l’ucronia e l’unione delle tre parti del tempo. Di un saggio che ha bandito timore e speranza dal proprio animo ed è capace di spaziare in ogni anfratto della propria vita, sia nel passato ricordando quanto di onesto e meraviglioso hanno prodotto le grandi menti dell’umanità, sia verso il futuro cui non richiede più di accontentare delle aspettative pregresse ma del quale assapora la previsione. Un saggio in antitesi con gli affacendati, che vadimonia e officia distolgono dalla vita contemplativa e dall’apatia e dall’aristocratica solitudine della quiete perpetua.
Il respiro di quest’opera, a scapito dell’apparente chiarezza, è intermittente, un gioco continuo di chiaroscuri che risuonano come un monito, come a ricordare che l’otium si può raggiungere soltanto affrontando il faticoso cammino attraverso le passioni, trascendendo i limiti umani, causa prima di sofferenza. Lo stile dell’autore, a questo proposito, permette una più ampia comprensione del messaggio e si confà alla drammaticità dello stesso. Per quanto siano presenti alcuni elementi propri della concinnitas ciceroniana, come l’isocolia, l’anticlassicismo di Seneca, che ha come obiettivo principale quello di raccontare la storia di un uomo che, venuto meno il filtro della partecipazione attiva alla politica, si trova vis a vis con il cosmo e con una nuova specie di libertà, si getta sulla brevitas e si acumina come una cuspide, una punta di lancia, per penetrare nella mente del lettore e fissarvisi. È esemplare l’organizzazione della clausola, che possiede, la maggior parte delle volte, l’elemento più breve in ultima posizione. É quindi un crescendo di pregnanza che si acuisce parallelamente alla brevità dell’elemento, così che questo rimanga quasi lapidariamente isolato e in rilievo rispetto al resto: un fulmen, appunto.
Dunque, per concludere, il tempo, secondo Seneca, fugge come un fiume in piena ma si contrae come un punto sospeso sull’abisso del cosmo; quale che sia la forma assunta, il primato della brevità non può essere scalzato se non da un saggio che sappia mutare la propria mente in direzione dell’ucronia e trascendere, ut deo, i doveri quotidiani, in un’apatia perenne che non teme e non spera.