Da Robert Walser a Charles-Ferdinand Ramuz
una riflessione sulla letteratura svizzera del Novecento
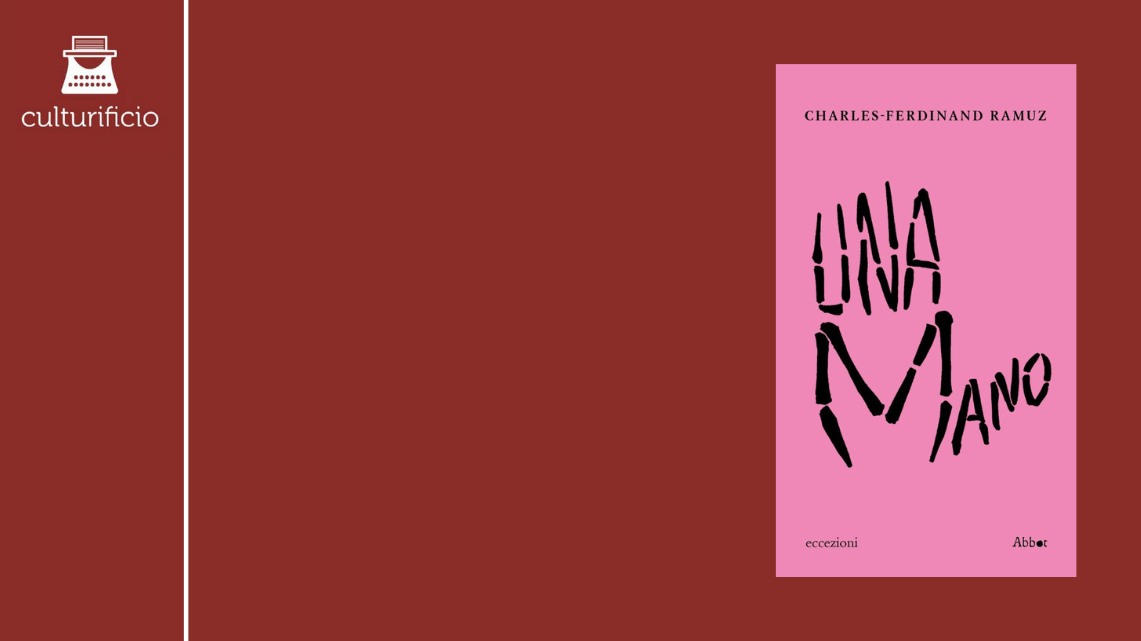
Di cosa parliamo quando parliamo di letteratura svizzera? È una domanda interessante da porre, considerando che si tratta di una letteratura ibrida, spesso di matrice francese o tedesca, ma anche italofona. Pensiamo che l’eroe elvetico per eccellenza, Guglielmo Tell, fu eternato da un celebre dramma del poeta tedesco Friedrich Schiller e, in seguito, celebrato dall’opera lirica dell’italiano Gioacchino Rossini. Difficile dunque tracciare un confine netto. Alcuni scrittori svizzeri in Italia restano un firmamento abbastanza oscuro: su di loro è stato scritto – e pubblicato – troppo poco, nonostante una produzione letteraria ampia e variegata e, soprattutto nel corso del Novecento, un vivace contributo al dibattito saggistico e critico.
La letteratura svizzera novecentesca rappresenta infatti un punto nevralgico tra le tensioni politiche, morali e psichiche del Secolo breve. Tra gli autori più iconici e innovativi per quanto riguarda lo stile troviamo Robert Walser, mente geniale (e incompresa), uomo dal destino tragico: nel 1929 fu ricoverato nella clinica psichiatrica di Waldau, vicino a Berna; morì il giorno di Natale del 1956 durante una delle sue amate passeggiate, il suo corpo senza vita fu ritrovato in mezzo alla neve. Tra le varie opere fu autore di un testo di appena un centinaio di pagine, dalla forte originalità e dall’impatto duraturo sull’immaginario: La passeggiata (pubblicato da Adelphi nella traduzione di Emilio Castellani), un piccolo gioiello letterario che si fa emblema della condizione umana.
Con una scrittura ritmata e poetica Walser trasforma una banale passeggiata in una profonda riflessione sulla vita, intesa come intreccio inestricabile di gioia e dolore, e in un’analisi introspettiva sul tema dell’identità. L’atto del passeggiare traduce l’essenza stessa dello scrivere: un moto che lascia un’impronta, ma anche un analogo percorso di dissolvenza nell’immaginazione. È un libro di riflessioni e di incontri, in cui pare che non accada nulla mentre invece accade tutto. L’intera produzione di Walser si muove in bilico tra questi due estremi: l’essere e lo scomparire, «è lui a essere questa cosa, che è presente eppure sempre fugge via». Una consapevolezza intima che si riverbera persino nella grafia dell’autore: i Microgrammi di Walser, scritti a matita con grafia minutissima, illeggibile a occhio nudo, rappresentano la punta di diamante più sperimentale della sua opera letteraria, in cui addirittura la scrittura giunge a sfidare l’interpretazione.
In un racconto del 1914 scrive:
Voleva vedere la bellezza, e la vide, voleva sondare l’abisso, e lo sondò, conoscere la miseria, e la conobbe.
Bellezza e abisso sono, di fatto, i temi fondanti de La passeggiata (1917), in una correlazione che ricorda la contrapposizione woolfiana nell’incipit di Mrs Dalloway (1925): «Che gioia! Che terrore! Sempre aveva avuto questa impressione quando, con un leggero cigolio dei cardini (…) si tuffava nell’aria aperta». Curiosamente anche il romanzo di Woolf inizia con un movimento: Clarissa Dalloway passeggia per le strade di Londra e la narrazione è fondata su un susseguirsi di impressioni fugaci. Robert Walser in questo testotrasforma l’atto del vagare in un labirinto narrativo e in flusso di coscienza, anticipando così un archetipo della letteratura moderna. La passeggiata avvera l’idea di romanzo auspicata da Virginia Woolf già in Modern Fiction (1919), ovvero la letteratura come tecnica di rappresentazione del mondo interiore. L’attenzione al dettaglio, al particolare, diventa sintesi del tutto: dal minuscolo all’universale.
A quel breve testo sembra fare eco un altro libro, pubblicato ora da Abbot Edizioni e tradotto da Davide Callegaro: si intitola Una mano e l’autore è un altro svizzero, ma di parte francese, coetaneo di Walser (entrambi nacquero nel 1878), il cui nome è Charles-Ferdinand Ramuz.
Proprio come accade per il capolavoro di Robert Walser, anche il libro di Ramuz è di difficile definizione: apparentemente si presenta come una divagazione, ma se letto più in profondità si rivela una disamina sul senso della vita umana e lo scorrere del tempo.
Entrambi gli scritti iniziano presentandoci un viandante solitario che cammina in un villaggio montano delle Alpi: ma se l’azione scatenante nel breve libro di Walser è la passeggiata in sé, ecco che nel libro di Ramuz è invece la caduta. La scrittura di Walser è guidata dal peregrinare inesausto del protagonista: è proprio il suo vagare a metterlo nel mezzo di una verità; mentre, per quanto riguarda Ramuz, è la condanna all’immobilità a innescare la storia. La trama del libro è essenziale, ridotta all’osso – o forse, alla radiografia di una mano – eppure spalanca innumerevoli prospettive e significati allegorici.
In una bella giornata di sole in cui «tutto è tranquillo. Si è contenti. Perché si è contenti?» un uomo scivola rovinosamente, cadendo all’indietro. Dopo un attimo di stordimento, l’uomo si rende conto di aver perso il controllo della propria mano sinistra, che non reagisce più ai comandi del corpo e non è altro che un arto inerte, inutilizzabile. La diagnosi del dottore è rottura dell’omero, di conseguenza la mano dell’uomo viene bloccata, fasciata, ingessata. Dietro l’accadimento – un incidente casuale, in fondo di poco conto – si spalanca una vertigine di malessere che dà adito a una riflessione sulla vita, il senso del nostro essere al mondo, la differenza tra dolore fisico e dolore spirituale. L’incapacità di muovere la mano – indispensabile per uno scrittore «scriviamo con due mani, proprio due: per saperlo bisognerebbe averne solo una» – getta l’uomo nell’umiliazione e nello sconforto, costringendolo suo malgrado ad arrendersi al «temibile invito alla pazienza» imposto dai medici. L’ozio, tuttavia, non è vuoto, anzi, è tempo dilatato in cui l’uomo sente di ritornare «senza gloria alla prima infanzia, ai mesi di balia» perdendo progressivamente l’indipendenza acquisita con l’età adulta. In mancanza (seppur temporanea) di una mano bisogna reimparare a vestirsi, a scrivere: l’ostico esercizio di adattamento diventa in breve una riflessione sull’esistenza. L’incepparsi del meccanismo perfetto del corpo umano suscita una quaestio filosofica:
Non siamo che una piccola rotella di un enorme ingranaggio, che sarebbe potuto non servire, che presto non servirà più.
Anche nel libro di Ramuz, proprio come ne La nausea di Sartre (1938), sono spesso le tre del pomeriggio, ovvero l’ora dell’immobilità forzata: nelle pagine si dipana il tentativo costante di spiegare il concetto di esistenza tramite una rivisitazione metafisica. La frattura in Una mano di Ramuz spalanca il baratro dell’assenza di senso, sprofondando l’uomo nella nebbia dell’angoscia esistenziale, ben rappresentata da Sartre tramite la metafora dell’orologio: «Alle tre del pomeriggio è sempre troppo presto o troppo tardi per qualsiasi cosa tu voglia fare».
È interessante la riflessione sul tempo proposta da Ramuz: l’autore svizzero osserva che nella nostra esistenza convivono in una perfetta indipendenza due tempi, «ciò che pensa in noi» e «ciò che agisce in noi». È davvero necessario il tempo per pensare? Osserva a un certo punto lo scrittore che deduce che «non c’è proprio bisogno di tempo, in assoluto». L’affermazione richiama il ritornello esistenzialista sartriano secondo cui:
L’esistenza è senza memoria, di ciò che scompare non conserva nulla, nemmeno un ricordo.
Se La Nausea di Sartre è un romanzo tutto sommato claustrofobico perché imperniato su motivi ridondanti, Una mano di Charles-Ferdinand Ramuz (1931) è una narrazione ariosa in cui la contrapposizione uomo-natura è fondamentale: all’angoscia del protagonista si contrappone lo spettacolo vivido del mondo naturale, come dimostra l’immagine del lago e delle anatre. Alla staticità della voce narrante si oppone il mondo della campagna: il contadino con la sua falce, il vento che soffia sui campi, l’erba che profuma di timo e l’uccellino che «si muove molto alto nell’aria, da qualche parte, sino alla sua meta».
Bellezza e abisso dunque, proprio come in Walser. C’è una considerazione che, in particolare, accomuna i due scrittori svizzeri: «così la vita è fatta di conclusioni e di inizi o riinizi; di morti, nascite e rinascite, tutto considerato» scrive Charles-Ferdinand Ramuz e gli fa eco un celebre aforisma di Robert Walser che recita «L’inizio e la fine si stringono la mano sorridendo. Apparire e scomparire sono una cosa sola». È qui che i due autori si ricongiungono come due prestigiatori che estraggono un colombo dal cappello magico e sembrano dirci all’unisono: eccola la vita, è inafferrabile, ma c’è. In fondo, siamo tutti incauti viandanti del mondo.