“Giornale dei lavori” di Paolo Barbaro
una contro-storia del progresso umano
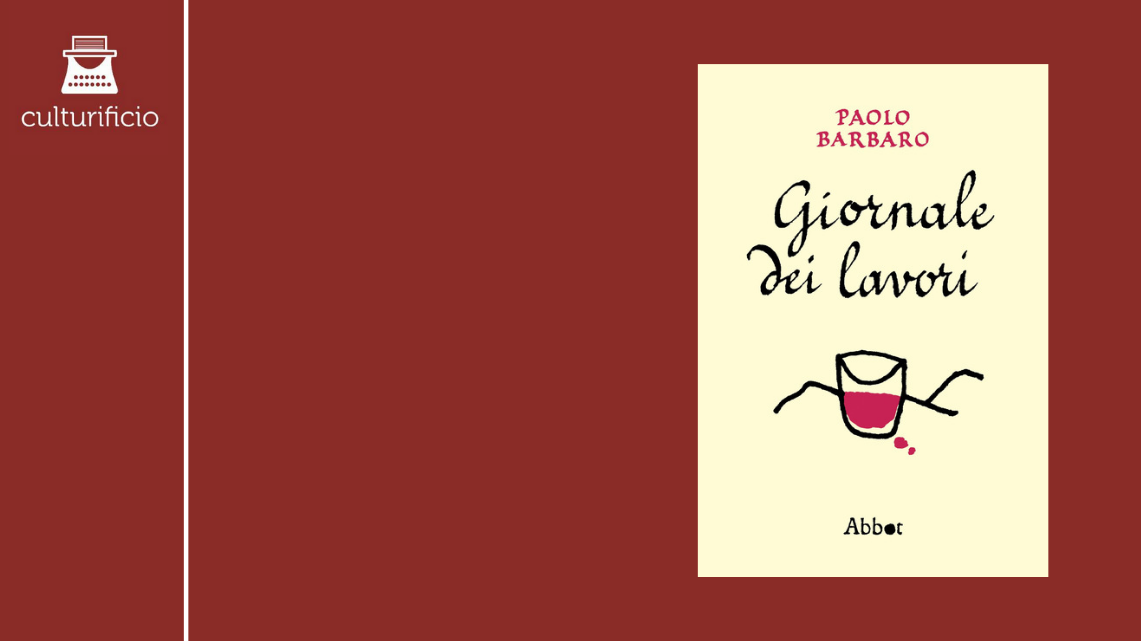
Qualcosa noi portavamo lassù, certo portavamo: una diga, un immenso serbatoio, una centrale per produrre elettricità, nuove forme di vita in quella valle abbandonata da Dio.
È una mitologia all’incontrario quella descritta da Paolo Barbaro. Una disamina del concetto di progresso che prende corpo e voce nel centinaio di pagine di Giornale dei lavori, il libro scoperto da Calvino per Einaudi nel 1966 oggi ripubblicato da una giovane casa editrice romana, Abbot edizioni. Le parole di Barbaro, il cui vero nome era Ennio Gallo e di professione faceva l’ingegnere, sanno raccontare le sfide dell’umanità di oggi forse più di quelle di ieri.
La mission della casa editrice Abbot, fondata da Davide Callegaro e Luigi Petrella, uomini di lettere e di cultura, si propone proprio di ridare vita a «libri ingiustamente abbandonati dai grandi editori che tuttavia parlano ancora ai lettori attuali». L’opera di Paolo Barbaro, l’ingegnere-scrittore finalista al premio Campiello ’76, si inserisce perfettamente in questo solco, spiccando per l’innegabile qualità letteraria.
Il Giornale di Barbaro si presenta al lettore come un taccuino di lavoro, una sorta di “diario di cantiere” in cui l’io narrante di giorno in giorno annota i suoi pensieri, mentre in uno sperduto paesino di montagna sovrintende alla costruzione di una diga. C’è quindi l’uomo, solo al comando, sullo sfondo di luoghi desolati dai nomi quasi mitologici: la grigia Valle del Piombo, la Gola del Diavolo, Riolunato, territori «abbandonati da Dio», ma non dagli uomini. Ci sono delle case in quella valle e degli abitanti che la amano con l’istintività tipica dei figli, facendo ritorno al nido come rondini in inverno. Un amore sconosciuto al protagonista, appartenente alla borghesia cittadina, che si affaccia per la prima volta a una realtà dai ritmi lenti e selvaggi, dove la natura è una nemica capace di ire tanto improvvise quanto imprevedibili.
All’iniziale fretta di concludere il lavoro e far ritorno al più presto al cosiddetto mondo civilizzato si sovrappone una riflessione più ampia e profonda. C’è, innanzitutto, il tentativo di comprendere quell’Italia ancora contadina in cui le donne «hanno volti senza età» e lavorano di fatica al pari dei muli in cambio di un sacco di cemento; e gli uomini, dalle mani di cuoio, che si infilano nell’oscurità delle gallerie sotterranee fino a sparire nella profondità della terra grondando sudore. Per questi uomini e queste donne non esiste che una casa ed è la Valle del Piombo, a quel grappolo di abitazioni abbarbicate sul pendio di una montagna saranno per sempre devoti. E quasi commuovono i loro discorsi all’osteria, annotati con cosciente scrupolo dal narratore.
Barbaro ha lo sguardo peculiare dell’ingegnere-poeta, riesce a descrivere persino i movimenti di una gru meccanica con la grazia che si riserverebbe a una musa: «Prima erano le gru, dalla loro altezza di campanili, a svegliarsi stridendo; i loro bracci cominciavano con l’alba a strisciare e a gemere sopra le mie finestre».
Questi occhi attenti e innamorati Paolo Barbaro li riserva a tutto ciò che lo circonda e, allo stesso modo, li rivolge dentro di sé nello scrutare gli impercettibili moti dell’animo mentre si interroga sul senso del proprio lavoro. Nel libro la perizia dei resoconti di cantiere si alterna ad altrettante minuziose analisi dei torti e delle ingiustizie subite dai lavoratori. Così il paesino di montagna, i suoi abitanti, i minatori che lavorano come formiche assumono un significato umano e universale. Sono infine le loro voci a levarsi per esprimere il giudizio più devastante: «Almeno avreste potuto, cominciando, mettervi d’accordo con noi».
Lo scarto impercettibile tra innovazione e conservazione sta tutto qui. La diga destinata a portare elettricità e approvvigionamento idrico costerà la perdita di numerose vite umane: vite di gente povera e semplice, che avrebbe tranquillamente continuato la propria esistenza nel perimetro ristretto di quelle piccole case, a prendere l’acqua al pozzo e mungere gli animali nella stalla, cercando il lavoro altrove a primavera.
Mentre l’intera valle rimbomba allo scoppio delle mine, come in uno scenario di guerra, è inevitabile interrogarsi sul significato del progresso. Abbattere per ricostruire su nuove fondamenta. L’esigenza dell’uomo di riadattare la natura ai propri scopi ha portato innegabilmente a un avanzamento della civiltà, ma a quale prezzo? Il progresso si affianca stretto stretto alla richiesta di un sacrificio; è quanto sembra suggerirci l’immagine finale della diga, imponente tra i prati, una enorme lastra di marmo e cemento che fa ombra alla piccola lapide, nascosta, sulla quale si stagliano i nomi di coloro che sono morti perché si realizzasse l’impresa nel minor tempo possibile. Barbaro descrive ogni cosa con annotazioni lucide, puntuali, senza fare sconti di sorta: emerge quindi l’assillo dell’uomo moderno per il Dio denaro, la bramosia di potere alla base dell’industria, l’importanza affidata a promozioni transitorie, quale il famigerato premio di produzione.
Attraverso l’abile intreccio delle parole il poeta-ingegnere tratteggia l’epica gloriosa dell’industrializzazione mondiale, con tutte le contraddizioni che essa comporta. Difficile non ritrovare nel punto di vista di Barbaro un’eco delle «magnifiche sorti e progressive» cui Leopardi, ne La ginestra (1836), guardava con malinconico sarcasmo. Paolo Barbaro assume la stessa percezione critica di Leopardi nei confronti del cosiddetto progresso glorificato da tutti i suoi contemporanei, malgrado ne sia l’artefice e, a suo modo, sia parte attiva del processo di innovazione. Il tanto magnificato sviluppo tecnologico non è affatto portatore di speranza e felicità universale; è questa, in fondo, l’amara conclusione di Giornale dei lavori.
Chissà, mi dicevo inoltrandomi nella nuova galleria a pochi metri da loro, forse tra milioni di anni qualcuno li ritroverà, qualcuno per caso, magari alla ricerca di civiltà scomparse; e scriverà che la nostra civiltà, una civiltà di passaggio, pur di finire si costruiva sopra le loro ossa.
Una presa di posizione insolita per un ingegnere, ma proprio per questo necessaria. Un altro uomo avrebbe potuto dirsi soddisfatto a lavoro concluso, una volta ottenuta l’agognata qualifica di “tecnico con esperienza”, finalmente pronto ad andarsene per il mondo a compiere grandi imprese; ma quell’uomo non sarebbe stato Ennio Gallo, «lo scrittore che costruiva le dighe», come i giornali anni dopo lo denominarono. Lo sguardo sensibile di Gallo/Barbaro è in grado di osservare la realtà come attraverso una lente d’ingrandimento che lo conduce a definire quella che sta vivendo «un’età di transizione»: la sua conclusione non è un elogio all’industria né un inno alle potenzialità del moderno homo faber, al contrario, è una riflessione malinconica sul tempo e la transitorietà di tutte le cose.
C’è l’ingegnere e c’è il poeta, le due personalità di Ennio Gallo che convivono nella mente di un uomo intelligente e dalla rara profondità d’animo: queste due vite distinte che lo portano a sdoppiarsi persino nel nome pur di distinguere l’attività di scrittore dalla sua professione reale.
Morirà all’età di novantadue anni nella sua Venezia, dopo una lunga carriera e molti libri scritti. Sarà sempre ricordato come lo scrittore italiano che per primo iniziò a interessarsi ai problemi ambientali mettendo in luce la tragica contraddizione della tecnologia. Gallo/Barbaro lo scrittore-ingegnere se n’è andato nel 2014, ma le sue parole continuano a vivere e risuonano oggi con ancor più veemenza di ieri.
Merita un plauso la decisione di Abbot edizioni di ripubblicare questo autore nel nostro futuristico ventunesimo secolo, perché Giornale dei lavori parla di un’epica del progresso immortale che ora ci troviamo a indagare e, spesso, a contestare con maggiore urgenza e necessità rispetto agli anni passati. Questo breve romanzo, scritto nel novecento industriale, parla soprattutto alla nostra epoca che con la sfrenata evoluzione scientifico-tecnologica è costretta in ogni modo a fare i conti. Siamo i figli del progresso, eppure, a ben vedere, apparteniamo alla stessa età descritta da Barbaro: «un’età di transizione quella in cui contava la velocità di una parte più dello sviluppo del tutto».
Una riflessione che oggi si ripropone forse sotto altre forme, ma rivendica la stessa attenzione inderogabile, come dimostra la drammatica realtà dei cambiamenti climatici. Proprio in virtù di questo, Giornale dei lavori pubblicato per la prima volta nel 1966, appare come un libro di una attualità sconcertante.
«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire» affermava Italo Calvino e, proprio lui che a questo libro aveva creduto da subito con fervido entusiasmo, appoggerebbe incondizionatamente questa felice scelta editoriale.