“La marescialla” di Zora del Buono
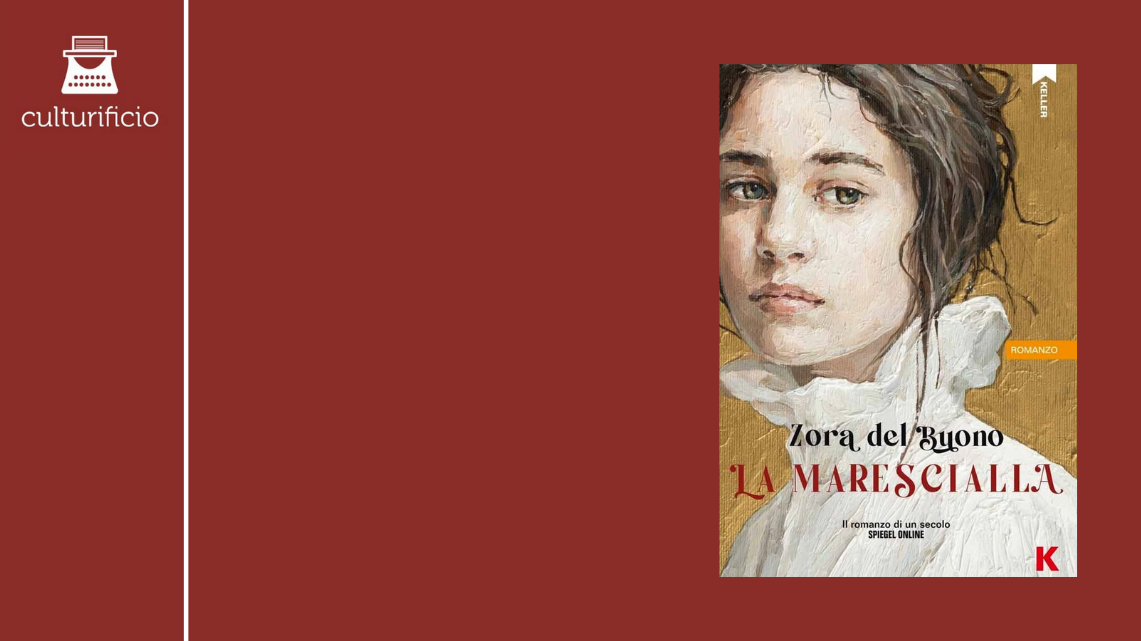
Forse tutti abbiamo avuto in famiglia, se sfogliamo il nostro album dei ricordi, alcune figure, per così dire, ingombranti, che hanno fatto mormorare per le proprie azioni e che ancora oggi suscitano reazioni opposte perché ognuno pensa di leggerle nel modo giusto. Forse tutti abbiamo incontrato personalità talmente magnetiche da non riuscire ad opporre resistenza, anche volendolo, perché fascinati o turbati da quell’incontro. Tuttavia, quale che sia il rapporto con quell’ingombro familiare, è evidente che si tratta di una persona che ha lasciato dentro di noi un segno, la sua inconfondibile firma e che, diciamolo, ci ha rivelato la sua, per quanto personale e a volte discutibile, visione del mondo. La marescialla, romanzo edito da Keller nella traduzione dal tedesco di Domenico Mugnolo, ci conferma la sensazione di aver intercettato una figura che resterà a lungo nel ricordo del lettore.
Perché forse non tutti abbiamo avuto una nonna come Zora Del Buono, l’epicentro di questo testo, una donna che irradia una personalità che acceca, non sopporta le obiezioni ma le provoca, una fiera figlia della Slovenia, temuta e ammirata, ostinata e dispotica, prima sorella-madre di quattro fratelli, poi madre-perturbante di tre figli.
Quando all’indomani della Grande Guerra nella Valle dell’Isonzo, allora territorio sloveno, i poco amati italiani incontrano la popolazione locale c’è anche la giovane Zora. La sua tempra battagliera e il suo acume da aquila delle montagne fanno subito breccia nel tenente medico Giuseppe Del Buono, originario di Ustica, mentre non pochi sono gli sguardi malevoli che sente su di sé.
Zora e Giuseppe, entrambi provenienti dalle periferie dell’Europa, creano un rapporto in cui armonizzano le rispettive patrie e, stabilitisi a Bari, altro centro periferico, attraversano insieme buona parte della storia del Novecento, nella comune appartenenza ideologica e, dati i tempi, nelle sue sacche di resistenza. Sono molti i ritratti in parole di Zora che troviamo in queste pagine ma è il padre di Giuseppe, un vivace ‘Don Giovanni’ in salsa siciliana, a coglierne l’essenza, ancora prima del figlio, con pochi tratti:
Zora non si lamentava mai, si rimboccava le maniche. Sembrava che splendesse un po’ di più delle persone che le stavano intorno; un fulgore costante, brillava persino quando non si sentiva osservata, come se bruciasse dal desiderio di fare qualcosa di immenso. Non era incantevole, né bella, eppure era affascinante nel suo splendore giovanile, una donna che osservava attentamente ciò che le stava intorno e poi diceva la sua, pungente e tagliente, ma senza cattiveria.
A riannodare la singolare biografia di questa donna è la nipote. Zora del Buono, scrittrice svizzera di lingua tedesca, racconta la nonna Zora Del Buono. Non dobbiamo sottovalutare la maiuscola o la minuscola del cognome perché la nonna, oltre a essere una donna a cui è difficile rimanere indifferenti, è una fervente comunista e ogni pretesa aristocratica è per lei un vero abominio, figurarsi firmarsi con un ‘de’ minuscolo, benché i Del Buono abbiano del sangue blu.
Zora non ha fatto studi accademici, non è un intellettuale, si esprime in tedesco, retaggio del collegio femminile frequentato a Vienna, ma crede in Gramsci e nel nascente partito comunista italiano, poi subito messo al bando dal regime. Ha notizia delle scuole, fucine di pensiero nell’incontro tra intellettuali e lavoratori, che Gramsci ha creato nel confino a Ustica, prima di essere trasferito a Milano, inizio di quel mondo che lei crede possibile. Come sa anche di Tito che, datosi alla macchia, sta facendo convergere in Slovenia uomini e armi per contrastare il fiancheggiatore ustascia, l’invasore fascista prima e nazista poi e realizzare altrove quello che Gramsci non ha potuto creare, per forza maggiore, nel suo paese. L’intellettuale italiano da un lato e il maresciallo slavo dall’altro sono così le “stelle polari”, peraltro da lei conosciute personalmente, che guidano la formazione politica di Zora nel momento in cui:
Lei voleva costruire, voleva mettere in moto nuove cose, nuove tecniche, nuove idee, nuovi uomini, per questo il comunismo la eccitava tanto, perché potevano accadere cose che capovolgevano la realtà, d’un balzo, non in maniera strisciante, e tutta una società si sarebbe trasformata. E lei poteva contribuire. Non credeva neppure che volesse atteggiarsi a persona importante, perché ERA importante; per ogni volantino ciclostilato clandestinamente, per ogni conversazione con un podestà del paese, per ogni lira data a chi ne aveva bisogno, diventava più importante, parte di una rivoluzione, sulla via dell’uguaglianza, del benessere per tutti.
Con il passare del tempo e il raggiungimento di un diffuso benessere, Zora si rivela sempre più un animale politico. A modo suo, si sente parte attiva di quel flusso rivoluzionario che attraversa l’Europa.
La frase «Il comunismo è aristocrazia per tutti», spesso ripetuta ad amici e conoscenti, ha una sua intima coerenza se letta come una possibilità, per chi è in basso, di elevare il proprio status, di raggiungere un livello migliore di vita all’interno di una società pienamente socialista. E, se anche la sua splendida casa a più piani, da lei progettata, splende come una gemma incastonata nel paesaggio di Bari, tanto da farla apparire una comunista da salotto a uno sguardo superficiale, è in quell’avamposto dorato che si crea opposizione. Tra quelle mura si rimane indenni dai miasmi del regime, avvengono incontri clandestini, si finanziano sottobanco i partiti messi al bando, si aiutano persone in difficoltà, si gettano ponti tra i partigiani dell’Italia e quelli della Slovenia. E per marcare ulteriormente la propria alterità dal sistema fascista si cucina pasta a dispetto di quel Marinetti che nel suo manifesto vuole abolirla perché infiacchisce il maschio italiano. Pertanto da Zora non si mangia riso, come vorrebbe il celebre futurista.
Di questa comunità indipendente la regista è Zora, a cui nulla sfugge, neanche la piega malfatta dei tovaglioli di cui sono responsabili le domestiche. La marescialla di Bari rivela, al netto del suo comunismo come seconda pelle, una propensione per l’enfasi e un senso di distinzione sociale per alcuni quasi insolente e contraddittorio.
Ma sono elementi che rendono il personaggio ancora più interessante perché in fondo lei è così: prendere o lasciare. Vogliamo poi parlare dell’incisione oraziana che campeggia sopra il camino nell’atrio di casa Del Buono, fortissimamente voluta dalla padrona di casa?
hic murus aeneus esto: nil conscire sibi, nulla pallescere culpa (Sia questo il tuo muro di bronzo: non aver nulla da rimproverarti, nulla da vergognarti).
Tutti quelli che passano si imbattono in parole che sanno di protezione, monito e avvertimento e che confermano la caparbietà, la capacità di resistere come ‘muro di bronzo’, di stare sempre in piedi – e contemporaneamente all’erta – senza mai turbarsi delle proprie azioni, capace di essere esempio per chi la osserva – un qualcosa che pretende anche da chi le sta vicino. E quando il vento del partito cambia e le volta la faccia, quello stesso partito a cui ha donato buona parte delle proprie riserve, non solo mentali, Zora sembra irriducibile:
Quando pensava a Zora, la vedeva in piedi davanti a sé: in piedi dietro la poltrona in cui Pietro era seduto e fumava; in piedi nel vano della porta del salone, senza mai appoggiarsi; in piedi mentre parlava con i suoi figli in giardino; in piedi accanto alla domestica, mentre giudicava la pietanza che la ragazza, più o meno intimorita, stava portando; in piedi sulla sabbia, sotto il suo parasole, che guardava verso il mare, mentre le altre signore si crogiolavano sulle loro sedie a sdraio e sfogliavano riviste e teneva d’occhio il traffico delle navi e non i bambini che giocavano; in piedi al poligono di tiro, dove porgeva cartucce a Davide; in piedi sullo scafo di un’imbarcazione nel porto di Polignano, mentre teneva un comizio. E ogni volta la vedeva in piedi in un vestito di chiffon color crema, lungo fino al pavimento, con le spalle nude, i guanti bianchi di seta fino al gomito, con una mezza dozzina di bracciali d’oro.
E Zora come madre? Anche su questo aspetto mostra la sua singolarità. Davide, Greco e Manfredi, i figli, vengono chiamati nella sua testa 1, 2, 3, come un mero elenco numerico. Il che non significa che sia una madre poco premurosa e apprensiva, anzi, dai figli pretende più che dagli altri uomini, forse anche dal marito. E non può tollerare che si accompagnino con ragazze che spengano quel loro fuoco interiore, la curiosità, la voglia di prendere a morsi la vita.
È tuttavia evidente che dentro di lei c’è – lo nota uno dei fratelli più sensibili e sofferenti – «un piccolo buco nero impossibile da chiudere», anche con la migliore volontà. Le è estraneo infatti un amore materno incondizionato, analizza i figli come fa con i fratelli, quasi che abbia «studiato personalmente con il professor Freud» e che il tutto sia frutto di una sana diffidenza.
Perché Zora diffida di tutti, dunque anche dei figli perché, una volta adulti, le mentiranno come tutti gli uomini. A differenza di quanto accade con le lotte politiche, dove non si risparmia, Zora non si dà per intero ai figli. E forse l’unico uomo che non l’ha mai tradita è quel Tito, un altro diffidente e un comunista non così allineato come lei, che saprà riunire, finita la guerra, le varie anime slave in una Repubblica Socialista, capace di rimanere indenne al controllo e agli attentati di Mosca, per il quale Zora prova un’inguaribile venerazione, sorvolando sul curriculum non del tutto immacolato del Maresciallo.
La struttura del romanzo, nient’affatto lineare, ricorda un mulinello. Dentro ogni capitolo, che sia Zora la protagonista o altri, c’è un andamento vorticoso in cui non è sempre facile capire subito chi parla, dove ci troviamo risucchiati da vicende spesso estreme che attingono al serbatoio della memoria e della fantasia dell’autrice che ama farci calare a picco nelle storie dei suoi personaggi, senza mai farci vedere il fondo, librando la narrazione nella forma dell’aneddoto.
Ma quasi con un coup de théâtre la marescialla, verso la fine del testo, si impadronisce della narrazione (la cosa potrebbe stupirci?). Si passa così dalla terza alla prima persona, e in un lungo monologo, silenziati i tanti protagonisti di questo racconto, ci coinvolge nella sua verità, colmando alcune lacune e aprendone altre…