La silente compagnia dell’uomo in più – “Ultimo parallelo” di Filippo Tuena
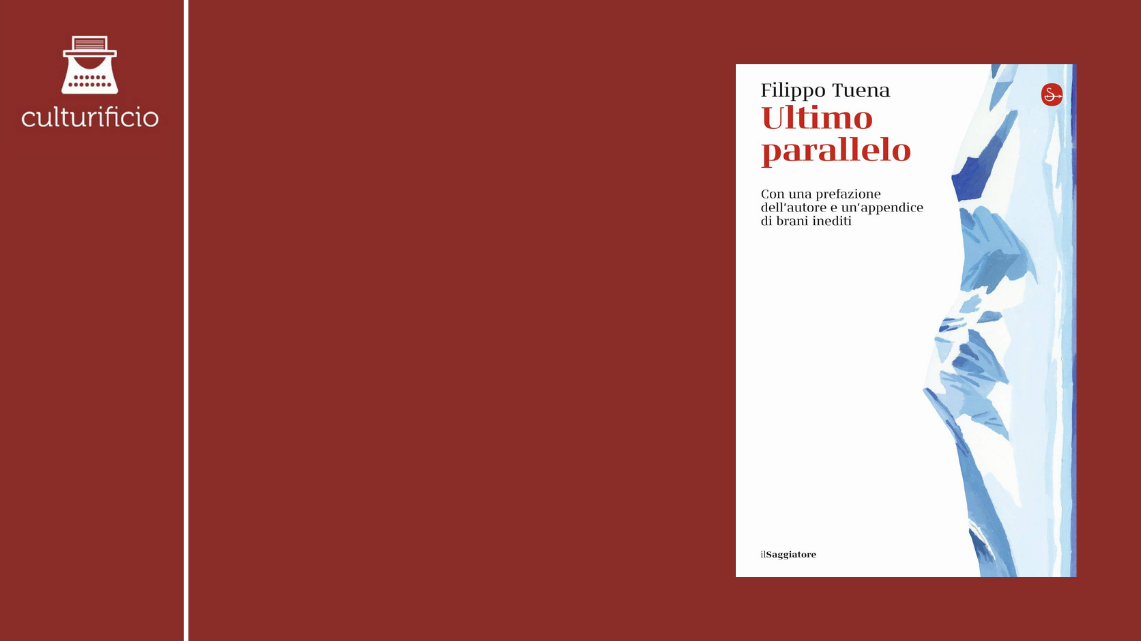
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumanisilenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura.— Giacomo Leopardi, L’infinito
Era il gennaio 1912 quando il Capitano Scott partì per l’Antartico a capo della spedizione Terra Nova. Lo aspettavano 14 milioni di km² di superficie, 1,5 milioni di km² di barriere, un’estensione coperta al 98% da ghiacci con uno spessore medio di 1600 metri.
Sono passati centodieci anni da quella missione, raccontata da Filippo Tuena in Ultimo parallelo, ripubblicato a gennaio 2021 da il Saggiatore in una nuova edizione arricchita con una prefazione dello stesso autore e alcune appendici. In questa schizofrenica aggiunta si scopre la storia editoriale del tomo, figlio prima di Rizzoli – secondogenito di Tuena dopo il successo di Le variazioni Reinach, 2005 –, adottato quindi da Giuseppe Genna e il Saggiatore (2007, 2010, 2021).
Ultimo parallelo è il resoconto romanzato e documentato delle spedizioni verso l’Antartico che a inizio Novecento portavano in seno il sentimento patriottico, nonché imperialista, dell’Inghilterra. Un contesto precedente al Trattato Antartico che nel 1959 sancì che l’Antartide era terra di nessuno, il cui suolo sarebbe stato calpestabile solamente per scopi scientifici, vietando attività militari e minerarie.
Tuena si concentra sul secondo viaggio esplorativo del Capitano Scott. Quella di Ultimo parallelo è la storia di una spedizione – composta da macchinari e pony, da uomini ed esploratori, santi e militari – destinata a fallire, perché nel centro gelido dell’Antartico sventolerà la bandiera di Amundsen, capitano della spedizione norvegese, arrivato a destinazione il 14 dicembre: quasi un mese prima del britannico.
Seguendo una strategia errata erano state percorse invano, attraverso le distese dell’Antartide, ben 750 miglia. Amundsen si servì dei cani, Scott dei pony e delle slitte a motore; il norvegese utilizzò gli scii per tutto il tragitto, mentre Scott e i suoi uomini non erano grandi sciatori e avanzarono a fatica, spingendo le proprie slitte. Solo in quattro arrivarono a destinazione e scoprirono la sconfitta della propria vanità. Durante il viaggio di ritorno la squadra di Scott venne annientata dalle terribili condizioni climatiche. I loro corpi saranno ritrovati soltanto dieci mesi dopo, accanto ai loro diari e a una macchina fotografica.
L’ultimo anelito di imperialismo britannico si disfa tra le bufere antartiche, e Tuena ne raccoglie la testimonianza, dando voce a foto e documenti.
I componenti della spedizione raccontano che tra i ghiacci non erano soli:
Nei ricordi degli esploratori, riferiti a volte a molta distanza di tempo dagli avvenimenti, e paurosamente annebbiati anche se riordinati attraverso il processo della memoria, appare, incappucciata al loro fianco, mentre la fatica della marcia si fa insopportabile e sembra esigere ed esaurire ogni piccola energia residua, l’inquietante figura dell’uomo in più – gliding wrapt in a brown mantle, hooded – colui che procede incappucciato avvolto in un mantello bruno.
Una figura che sarà la voce del racconto di Tuena e che conserva un debito con The Waste Land di Eliot, come racconta lo stesso autore all’inizio del libro. Il poema di Eliot uscì nel 1922, dieci anni dopo la spedizione, e in una delle «poche note esplicative autografe» è specificato che la genesi dei versi riportati di seguito risale alle spedizioni antartiche, probabilmente a quella di Shackleton (terzo ufficiale della prima spedizione, nel 1901, di Scott), nella quale emerge «che ci fosse una persona in più di quante se ne potessero effettivamente contare». Così il poeta decide di tornare sui versi di The Waste Land.
Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
– But who is that on the other side of you?.
Ultimo parallelo è quindi raccontato in prima persona, sfruttando il punto di vista di un accompagnatore esterno che segue la carovana fino a destinazione e ritorno, dell’uomo in più, del “viandante di Emmaus”, dell’ectoplasma glaciale. L’uomo finale della spedizione che guarda dall’esterno il gruppo, lo accompagna lungo le distese diafane e, dalla sua posizione, non solo mostra al lettore il procedere della compagine attraverso i ghiacci, ma riesce anche a sbirciare attraverso i carapaci congelati dei componenti tramite i loro diari e le loro smorfie, riesumando i sentimenti accantonati sotto la neve.
Lo stratagemma narrativo dell’uomo in più è raccontato nella prefazione dallo stesso Tuena. La lunga introduzione abitua già il lettore alla liricità di una terza persona esterna rispetto al punto di vista degli esploratori; voce che allo stesso tempo non si identifica con un semplice narratore extradiegetico. Questa visione imparziale segue lo scrittore anche durante la composizione di Ultimo parallelo in modo da creare un distacco bipolare: lontano e vicino, esterno e interno. La prima apparizione dell’uomo in più, racconta Tuena, è su un biglietto vergato dall’autore che riporta i seguenti versi: «accompagnano gli uomini / senza che questi se ne/ accorgano». Poi quattro segni di inchiostro. Sull’identità della figura Tuena è volutamente enigmatico.
L’uomo in più si configura da subito come una terza persona onnisciente che avvicina lettore ed esploratore. Si tratta di una sutura che colma la distanza tra il punto di vista autoriale e il continente artico — particolarità che mi ricorda Salgari.
Per raccontare in maniera efficace la storia degli esploratori dovevo trovare una voce singolare, autorevole, immersa in quel panorama ghiacciato e non poteva essere la mia, scrittore di città, al massimo di archivi e biblioteche o di qualche scarpinata lungo le colline del Peloponneso in cerca di resti archeologici.
Per un certo periodo, durante le varie stesure, quella voce in più è stata la voce di George Vince che, racconta l’autore, è il primo esploratore morto durante la spedizione, il cui corpo è tuttora conservato tra i ghiacci. Poi, a detta di Tuena, la voce ha perso determinatezza e l’oscillazione su quell’identità enigmatica, tra il marinaio scomparso e l’incertezza, diventa voluta. E infatti nella narrazione lo stesso uomo in più si fa portavoce di tale vaghezza:
Così mi chiedevo in quel momento, mentre i marinai facevano bistecche della carne di jehu, non ero forse anch’io quel che rimaneva di un corpo abbandonato e incorrotto? Non ero anch’io qualcosa che non aveva ancora trovato il suo termine?
A questa domanda non c’è risposta. Il lavoro che compie l’uomo in più sul racconto è un’operazione di salvaguardia della carovana e di orientamento per il lettore. Si tratta di un lavoro gratuito che non comporta una restituzione in termini di identità.
Ciò che alla fine dell’opera sappiamo è che questo viandante slavato esercita l’attività del ricordo e tramite questo può raccontare. Nel suo bagaglio mnemonico sono conservate le gesta degli esploratori.
Credo di ricordare perfettamente – e tuttavia non è come credo – che fosse l’ampiezza dell’altopiano che consideravano smisurata a procurare vertigini anche se adesso nel ricordo mi rendo conto che si trattava di qualcosa d’indeterminato che mi sta mettendo a disagio mentre ricordo quel piccolo drappello di tre esploratori che prendono la via del ritorno ed è questa parola ritorno che mi turba perché improvvisamente mi sono sentito attratto in quella direzione mentale: ritornare da cosa verso dove?
Sono due i punti interessanti. Per prima cosa l’incertezza del ricordo: la sicurezza dell’ipermnesia narrativa dell’uomo in più aveva connaturato il racconto fino a questa pagina, talvolta inserendosi nell’intimità dei pensieri e delle letture dei viaggiatori. Il secondo nodo di interesse è la chiusa: la riflessione sulla parola ritorno e la domanda che ne consegue, la quale sottolinea una mancanza di prospettiva da parte del narratore.
L’insicurezza del ricordo sembra poter essere dovuta al raggiungimento dell’ultimo parallelo, considerato come meta ultima, altrove impossibile. A quel punto pare che l’uomo in più diventi partecipe della delusione degli esploratori e per questo motivo non riesca più a cogliere il senso del tornare, come se l’azione di raggiungere Capo Evans prima e la propria abitazione in Inghilterra dopo, avesse perso di senso. Da questa considerazione si potrebbe spiegare l’ultima frase che chiude la pagina come preghiera interrogativa sul movimento a ritroso che in quel punto della narrazione stanno compiendo gli esploratori: ritornare, sì, ma «ritornare da cosa verso dove?».
Ciò che più di ogni altra cosa fa l’uomo in più nei confronti del lettore, in una configurazione extradiegetica, è distendere la neve prima del suo passaggio. Silente segue la spedizione, ma tra le azioni che caratterizzano la sua opaca silhouette c’è anche l’interazione, seppur solo per brevi tratti. Per la totalità del viaggio, l’uomo in più non fa quasi mai percepire la propria presenza o il peso della sua osservazione, se non qui, a spedizione terminata, quando Atch ritrova i corpi e legge i diari dei compagni morti assiderati:
Ed è stato allora che Atch ha creduto che entrassi in silenzio nella stanza mentre leggeva e mi sedessi vicino e attendessi che fosse lui a parlarmi.
I due, in effetti, parlano per diverse pagine. Si tratta di un dialogo che è una confessione e insieme un conforto. L’interazione, l’unica di tale entità in tutto il libro, è un collegamento delicato. Nella conversazione con Atch si concretizza l’ultimo compito a cui è chiamato l’uomo in più, ovvero ricongiungere i vivi con i morti, l’altrove con il presente.
C’è però una specie di rassegnazione che innerva il dialogo tra Atch e l’uomo in più – in special modo quando il primo chiede al secondo perché non li ha salvati – che mi ricorda un passo de L’Inferno di Henri Barbusse, romanzo pubblicato la prima volta nel 1908 e riedito in Italia nel marzo del 2017 da Atlantide Edizioni. Si tratta di una storia visionaria che sconcerta, percorsa da un furore metafisico e nichilistico, che può fare chiarezza sul punto del rapporto tra lettore-altrove-osservatore:
Ma l’infinito è questo. È così, non posso dubitarne». Questa verità si impone: non esistono cose straordinarie, il sovrannaturale non esiste, o meglio, è ovunque. È nella realtà, nella semplicità, nella pace. È qui, fra queste mura che aspettano con tutto il loro peso. Il reale, il sovrannaturale sono la stessa cosa.
L’uomo della storia arriva a Parigi e nell’alloggio della sua pensione scopre un piccolo foro attraverso il quale è possibile vedere cosa succede nella stanza a fianco.
La spedizione in un tomo, e gli ardori dell’alloggio parigino nell’altro, sono valutati con la freddezza del terzo occhio puntato verso un altrove. Ma come dice l’uomo di Barbusse l’alterità non esiste come concetto esterno perché è tutta qui, all’interno della realtà, è piuttosto un occhio puntato verso il proprio petto a scrutare la sacca nascosta che contiene ogni esplorazione extra-ordinaria.
Vale la pena chiedersi se la letteratura, in un modo o nell’altro, non sia chiamata a porsi sempre come l’uomo in più per il lettore, cercando di spingerlo verso un’evasione metamorfica da sé e allo stesso tempo dentro sé. Un’eccedenza del reale, una fuga che è un ritorno, come quello tra i ghiacci di cui l’uomo in più non riconosce gli estremi: ritornare da cosa verso dove?
Verso l’ultima candida rivoluzione concessa; ecco dove mi pare possa portare questa esplorazione che è la letteratura.
di Antonio Potenza