“L’alba della nostra libertà”
la trama nascosta della Resistenza
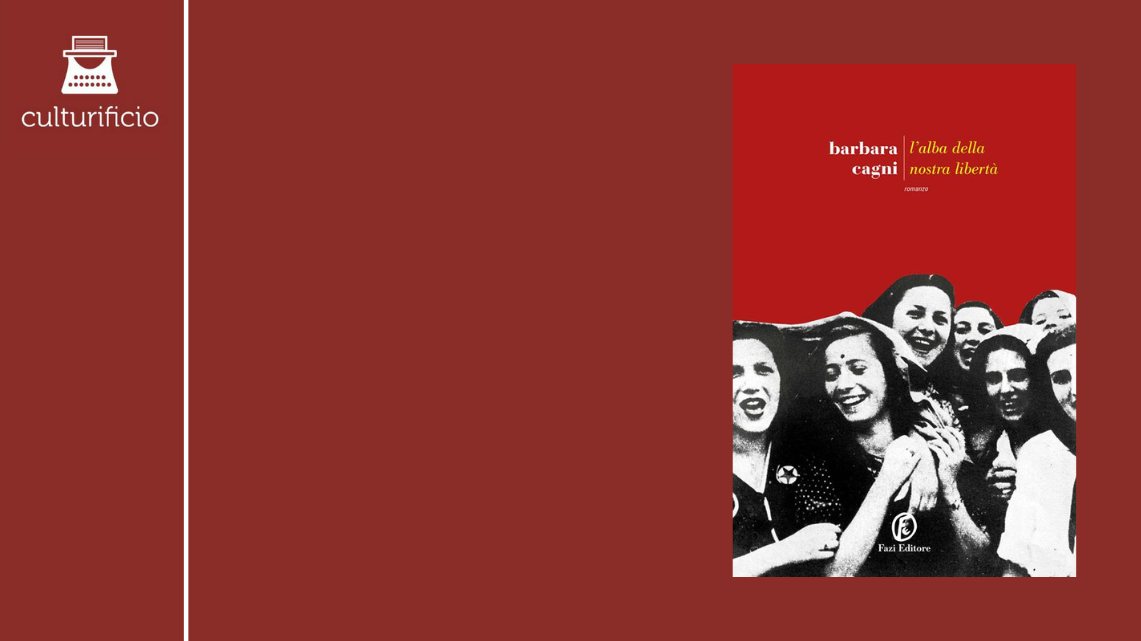
In L’alba della nostra libertà (Fazi, 2025) di Barbara Cagni ci immergiamo, all’indomani dell’8 settembre 1943, in una Milano occupata, città ferita e diffidente ma anche attraversata da correnti sotterranee di coraggio. Non è un romanzo storico tradizionale, bensì un mosaico di storie vere che restituisce dignità a figure rimaste ai margini della narrazione ufficiale: donne comuni, apparentemente invisibili, protagoniste silenziose nella difficile lotta antifascista.
La vicenda di Marilù, tenutaria di una casa di piacere costretta a una doppia esistenza, divisa tra stigma e desiderio di riscatto, diventa emblematica di una condizione femminile sospesa tra necessità economica e aspirazioni di libertà. Accanto a lei si muovono portinaie, studentesse, insegnanti, operaie: vite diverse delle periferie di Milano accomunate dalla fame, una presenza martellante che consuma i corpi e, al tempo stesso, accende nuove e insperate risorse interiori. Tra queste donne c’è anche Lina Merlin, schedata e sorvegliata dalla polizia locale, che continua a insegnare in segreto e, altrettanto in segreto, a coagulare intorno a sé altre dissenzienti.
Il romanzo mostra come la Resistenza urbana non si esprima soltanto nei fucili dei partigiani in montagna, ma anche nei gesti concreti delle donne: trasportare messaggi, organizzare scioperi, sabotare le fabbriche, proteggere i perseguitati, consentire nei loro tinelli riunioni clandestine, procurarsi armi, cibo e medicinali. La città si fa dunque laboratorio di vite che devono ripensarsi, trovare complici, agire nell’oscurità, aggirare i delatori e passare da angeli del focolare domestico, come imposto dalla morale patriarcale e dal regime, a micce incendiarie:
Erano come tanti fili che si intrecciavano, non a formare trine di pizzo per un centrotavola, ma per intessere trame di resistenza più forti dell’acciaio.
L’autrice restituisce la precarietà psicologica di queste figure con la potente metafora delle funambole: donne che camminano ogni giorno su un filo sottilissimo, dove ogni passo falso può significare caduta e, di conseguenza, arresto o morte. Ma a differenza dei funamboli del circo queste non vedono la piattaforma d’arrivo: la fine della guerra resta invisibile, e di conseguenza la loro ostinazione quotidiana acquista un valore più alto.
La partecipazione femminile, spesso ridotta a “supporto” nelle ricostruzioni storiografiche, assume qui una centralità indiscutibile e documentata. Le donne non sono appendici dei partigiani ma staffette, organizzatrici, sabotatrici, parte attiva, partigiane appunto. Come ricorda Ada Gobetti nel Diario partigiano:
Nella Resistenza la donna fu presente ovunque: sul campo di battaglia come sul luogo di lavoro, nel chiuso della prigione come nella piazza o nell’intimità della casa. Non vi fu attività, lotta, organizzazione, collaborazione a cui ella non partecipasse: come una spola in continuo movimento, costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile, il tessuto sotterraneo della guerra partigiana.
Proprio in queste esperienze, che modificano il loro modo di stare al mondo, nasce un passaggio decisivo: dal gestire i doveri quotidiani come mogli e madri allo scoprire i diritti come donne. Le protagoniste del testo, impegnate in fabbrica e nei gruppi clandestini, cominciano a percepirsi come soggetti politici, capaci di partecipare e decidere per loro stesse. Una liberazione doppia, dal nazifascismo e da chi le ha confinate nel silenzio domestico. Nilde Iotti lo ricordava con chiarezza:
La guerra ci ha costretto a uscire di casa, a misurarci con i problemi concreti del mondo, a capire che eravamo in grado di fare quello che fino ad allora ci era stato negato.
Lo stile di Barbara Cagni accompagna questo percorso con sobrietà: una prosa limpida, essenziale, mai retorica, che affida la forza emotiva alla concretezza dei dettagli. Dialoghi intrisi di dialetto milanese restituiscono autenticità, mentre la narrazione, pur evitando qualsiasi enfasi ideologica, lascia emergere una coscienza politica che si matura pagina dopo pagina.
L’alba della nostra libertà è un libro prezioso non perché ambisca alla grande letteratura, ma perché colma una lacuna nella nostra memoria. Fa luce su storie dimenticate e mostra che la libertà non nasce da gesti spettacolari ma da una trama diffusa di coraggio quotidiano. In un mare di passività e paura, furono spesso piccole isole di resistenza femminile a fare la differenza:
Collegamenti che si spezzavano come fili e che si annidavano ad altri fili per dare nuova forma a quella trama nascosta, che percorreva la città attraverso le fabbriche, le abitazioni, le chiese, gli uffici, i negozi. Mille volti, ma tutti somiglianti nell’idea comune di libertà.
Il lettore di oggi, che certo arricchisce grazie a questo libro la propria conoscenza sui fatti della Resistenza, non può non sottrarsi a una domanda: quale parte di quei fili ci riguarda ancora? Forse non siamo chiamati a gesti eroici, semmai a custodire e rinnovare quelle connessioni, a non lasciarle spezzare nell’indifferenza, a non voltarsi dall’altra parte e a coltivare sempre una qualche forma di solidarietà, qualche che sia il momento storico che stiamo vivendo. Perché la libertà è da sempre un tessuto pregiato ma fragile che va difeso e custodito con attenzione, perché basta poco a farlo lacerare, è un filo di Arianna decisivo per orientarci e per guidarci fuori dai nostri labirinti.