L’infelicità semplice de “I pipistrelli” di Inès Cagnati
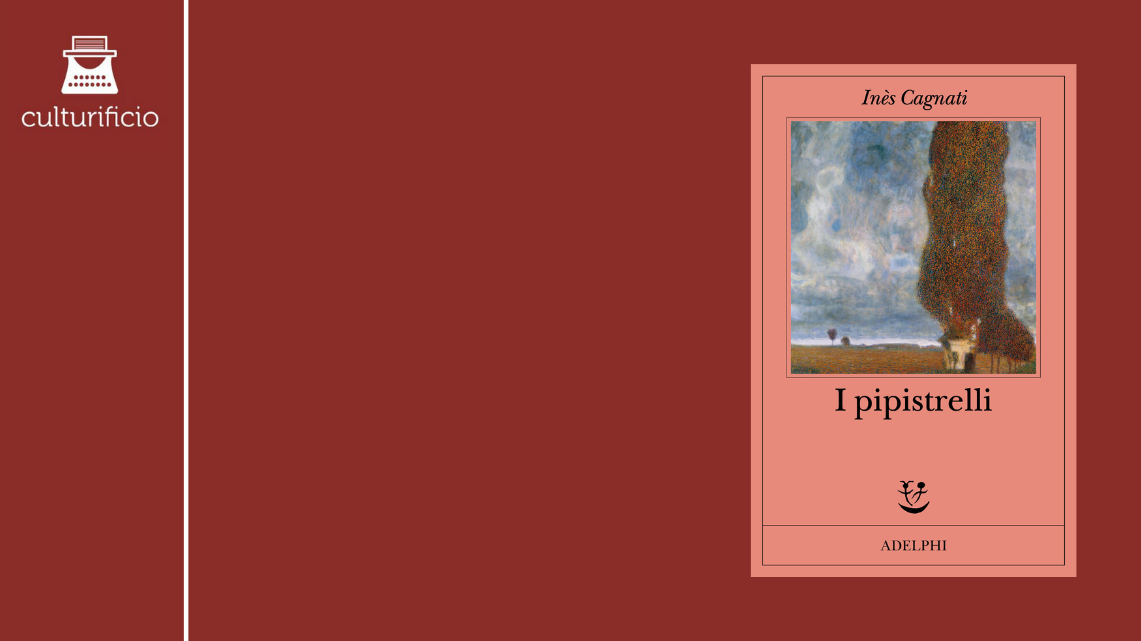
Dalla sintesi di qualche parola e di qualche aggettivo, Inès Cagnati ricava il tutto.
Lo fa quando parla di quel niente che, in uno spaccato di campagna, sta tra una casa e i suoi campi. In I pipistrelli, edito da Adelphi nella traduzione italiana di Lorenza Di Lella e Francesca Scala, ci sono sempre le paludi dalle acque immobili, le macchie gialle di iris sull’argine, i filari delle vigne. Le voci narranti si muovono in una terra secca e sterile, una terra «dove non vien voglia né di nascere né di vivere». Ci sono i profumi portati dal vento, il cane, le mucche, i maiali, le erbe e i fiori selvatici, perché Inès Cagnati, figlia di contadini, sa dei lavori di cui scrive, conosce i tempi della terra e il contesto è sempre quello della società rurale francese. E poi ci sono le bambine a fare da protagoniste, come in Giorno di vacanza e Génie la matta (qui sempre editi Adelphi), i due romanzi che sono stati scritti circa quindici anni prima di questi racconti del 1989.
Questa raccolta colpisce per la sua cruda bellezza. Con la sua prosa asciutta e vivida si materializzano i linguaggi silenziosi della Natura; gli aggettivi sono essenziali, accurati, la scrittura è fatta di parole tattili, ed è sempre sinestesica: «La sua cagna, Folette, tutta d’oro brunito, mi fa pensare al vento che parla con gli alberi, alle farfalle setose, alle piogge di petali della primavera».
«Una terra di sassi»; «con il cuore che faceva il matto» sono frasi ricorrenti sparse ovunque nella scrittura di Cagnati, nei romanzi e in questi racconti; sono gli indizi che fanno riconoscere la sua mano dietro lo scrivere. Così come gli esergo sono sempre posti a fine capitolo e mai all’inizio, come a chiudere il discorso con un commento finale, qualcosa che si vuole dire oltre il narrato. C’è un motivo: il suo indugiare per forza su tutto, sulla morte brutta, sul brutto umano, è un tentativo, come confessato in un’intervista comparsa nell’edizione italiana di Génie la matta, di dare un senso a certe esistenze di miseria che in vita non l’hanno avuto. In qualsiasi prosa di Cagnati aleggia un senso di ineluttabile, si ha l’impressione che qualcosa di tremendo dovrà accadere, e di norma accade.
E poi non ho più pensato, perché la tacchinella sanguinava dal naso e dal becco e il sangue mi gocciolava sul vestito. Ho dovuto fermarmi, pulire la testa della piccola tacchinella nell’erba del terrapieno, asciugare con delle foglie il sangue sul vestito, ed è venuta fuori una macchia nerastra ancora più brutta. Mi sono tolta le scarpe e le ho pulite un po’ con un bastoncino, e pure i piedi, le mani, le guance, ma non è servito a molto. All’improvviso mi è sembrato tutto così terribile che mi è passata la voglia.
In Cagnati sono i folli, i bambini, i vecchi e in un certo senso l’animale a dire la verità. Diventano il capro espiatorio, l’elemento innocente che viene immolato per consentire alla società il suo normale svolgimento. Il loro sacrificio va a sporcare le varie voci narranti: sono sempre le protagoniste a dover ammazzare i conigli malati, spennare le oche, gettare in un sacco i piccoli della cagna o della gatta per annegarli nel fiume.
Torna il tema della follia di Génie la matta nella protagonista dell’ultimo racconto, La donna senza nome. Se Génie la matta, che matta non è, sceglie lei stessa la sua follia, qui si legge di una coscienza che per davvero è eclissata dal mondo e dagli altri – e che forse è più felice così, perché questa esclusione diventa un modo di vivere l’insopportabile. Nel suo personaggio c’è tutto ciò che Cagnati aveva espresso in un’intervista: il matto è matto in quanto tutti gli altri sono normali, è garante della loro normalità. Viene rispettato finché non tenta di scardinare il posto in cui la società lo ha inchiodato: non appena questo schema s’infrange, con atti di ribellione anche minuscoli – la donna senza nome che di nascosto ruba dolci, si riempie le tasche di quello che può, indossa stoffe magnifiche non sue che poi ripone male – la società, l’altro, risponderanno duramente; si vendicheranno.
Leggendo questo terzo lavoro di Cagnati, si intuisce perché le voci narranti appartengano quasi sempre a una bambina: i bambini sono quel soggetto che, più di tutti, possono sapere cosa sia l’abbandono. La loro è l’età in cui si forma il modo di amare in base a come si è stati amati. Le bambine di Cagnati nascono nel disinteresse o nella violenza, sanno che nessuno le ha volute, per loro il legame naturale d’amore tra una madre e una figlia non è qualcosa di già dato, ma va ogni volta ricercato. La scuola non è migliore: compare come un organo sterile, fatta da figure aliene e granitiche che, anziché costituire una prima via di fuga, respingono le domande delle bambine, ne accentuano la differenza, lo sporco sul grembiule scolastico, la degenza, come se questa diversità fosse colpa loro. La bambina protagonista nel racconto La tacchinella non riesce bene a scuola, non capisce i problemi matematici della maestra che parlano di tubi che perdono e vasche da bagno rotte. A casa si angoscia di non riuscire a prendere la licenza. E qui Cagnati introduce una certa ironia nel suo scrivere: il padre della bambina, mancando della capacità di astrazione, pensa che la vasca da bagno della maestra sia realmente guasta e si propone di andare a riparagliela. Nel frattempo, manda la bambina a scuola con una tacchinella il giorno dell’esame, per cominciare a rabbonirla. Nella lettura si arriva anche a sorriderne, ma con una morsa allo stomaco: non si può non pensare che quel pensiero sprovveduto sia frutto dell’ignoranza, che in certi contesti è inseparabile dalla miseria.
In questa raccolta la persona compare di più, anche rispetto all’animale che Cagnati di norma preferisce, e la sua presenza non necessariamente è negativa. L’essere con l’Altro apre a quello spazio di incontro che è il parlato, la lingua usata per scambiarsi significati, per conoscersi creando un legame. Non sempre però ci si capisce. Di frequente le protagoniste di Cagnati sono italiane e parlano italiano in famiglia, all’esterno non capiscono e non vengono capite perché la lingua corrente è il francese. E talvolta il senso d’estranierà diventa totale: il secondo scritto della raccolta, La ragazza in azzurro, preme molto sull’essere degli stranieri in una terra per sé stessi straniera. Qui l’io narrante appartiene a una bambina italiana e dall’altra parte ce n’è una un po’ più grande, polacca; nessuna delle due parla la lingua del paese in cui si trovano. Il loro universo comunicativo si apre con gesti e suoni nitidissimi, le immagini della natura sono i loro nuovi significati – lotus è la prima parola che si dicono e capiscono insieme, guardando allo stagno davanti a sé. Fa pensare alla storia di Cagnati, che è stata una non francese in Francia e in un secondo momento una francese naturalizzata, che ha quindi scritto in una lingua non madre che per lei è stata un punto d’arrivo. È una lingua che alla fine torna sempre alla terra, a quello spaccato di campagna che sta tra una casa e i suoi campi.
Non voglio più ascoltare, me ne vado dietro la casa, dove c’è il grande pezzo di terra. Quando fa freddo, la terra è nuda. Appena torna il sole, mi danno una zappa, e io zappo, zappo, per giorni e giorni. Dicono:
«Ti fa bene».
Poi mettono i semi, e le piante crescono. È bello. Me ne vado dietro la casa per non sentire più. Mi tolgo le ciabatte di gomma e corro intorno al campo che è grande. Resto ai bordi per non schiacciare niente. Faccio molti giri. Corro male perché la terra mi attira a sé e sono costretta a stare sempre più curva. Quando non ne posso più e la terra mi attira troppo, cado. Mi ci stendo su, chiudo gli occhi.