“Portugal” di Cyril Pedrosa ovvero l’arte delle piccole cose
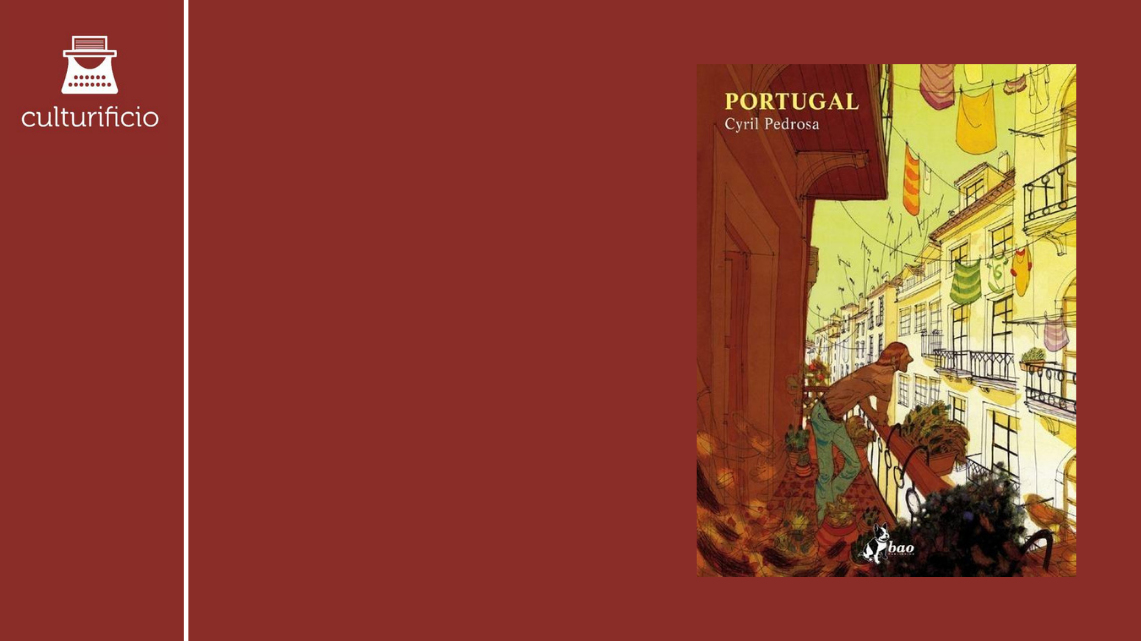
Tre capitoli, tre uomini, tre fermate durante un viaggio a ritroso alla ricerca di sé stessi e delle proprie radici.
Nella canicola dell’estate del 1976 in una stazione di servizio Antar, dall’altoparlante un motivetto pubblicitario annuncia che il calciatore Michel Platini beve Fruité. Su un lato del bancone c’è un espositore di Chupa Chups e in un angolo, fra le riviste, spuntano il quotidiano France Soir, il fumetto di Tex e il giornalino di Mickey-Parade. Un bambino, estasiato davanti a un distributore di palline premio, pesca un Goldorak di plastica.
Un balzo all’indietro per il lettore che ricorda la Francia degli anni Settanta: luoghi e atmosfere rivivono grazie alla mano attenta di Pedrosa che, memore dell’infanzia, restituisce con minuzia di particolari il passato, anche fosse solo attraverso una scritta leggibile per metà. Esperienza personale e libertà creativa si fondono nel dar vita a Portugal (Bao Publishing, trad. M. Foschini), graphic novel di straordinaria bellezza sullo sradicamento e sui cammini tortuosi che, dai misteri di antiche e polverose storie di famiglie migranti, conducono verso la riconquista di un frammento della propria identità.
La cura per le piccole cose non si esaurisce nel disegno, è anche nell’evanescenza di un’oralità evocata da stralci di canzoni e melodie di vecchi spot pubblicitari. Così, le note del pentagramma invadono i baloon e persino il nostro orecchio sembra percepire il diffondersi dall’autoradio di Education sentimentale di Maxime Le Forestier, mentre i chilometri si accumulano uno dopo l’altro insieme al crescendo di tensione. I colori terrei del viaggio attraverso la Francia, da Parigi fino alle vicinanze di Albi, là dove vive quella nonna portoghese semisconosciuta, rivelano vecchi problemi familiari, litigi e fratture insanabili. Contro il grigiore del mondo dei grandi si staglia l’innocenza dell’infanzia di Simon: felpa, t-shirt a righe e jeans slavati, i colori allegri delle tavole successive.
I primi anni Duemila, tuttavia, sono nelle varietà di verde pera, giallo Napoli e seppia, declinazione di una monotonia affine a quel passato privo di colore. Simon galleggia inerte, quasi un tronco alla deriva, nel mare dei problemi adulti. C’è la prospettiva di un mutuo, l’idea rimandata di una stabilità contro ogni possibilità di chiamare casa tanti luoghi, senza mai sentirne tale alcuno. Ci sono la mancanza d’ispirazione e il senso di inutilità di un lavoro artistico ben diverso dalle litografie art nouveau di quel Mucha con cui confondono l’ortografia del suo cognome: Muchat. Ci sono il disorientamento, le incomprensioni, le domande di Claire e i mutismi ostinati. C’è, infine, il tuffo nel verde acquamarina della solitudine e dell’ansia della ricerca di un senso delle cose contro il vuoto interiore.
Poi, inatteso, fra la posta fa capolino il cuore rosso di una bustina, unico tocco di colore nelle monocromie delle prime pagine: l’invito, presto abbandonato sul tavolo da disegno ingombro, al matrimonio di una cugina a giugno.
La cesura, però, l’innesco di un meccanismo a orologeria nel primo capitolo è un viaggio in Portogallo, una manciata di giorni nella terra degli avi per una fiera del fumetto. Costa da Caparica suggerisce un quadro appeso nell’albergo dove Simon alloggia. Perché sì, leggere Portugal significa anche questo: soffermarsi sulle tavole, sfogliare le pagine all’indietro per ritrovare un dettaglio sfuggito. Ogni rilettura è una scoperta, tanto sono arricchiti di particolari i disegni. L’attenzione al piccolo, al nascosto negli sfondi, l’informazione sottesa alla narrazione restituisce qualche grammo di chiarezza al lettore.
Il sole del Portogallo illumina il grigiore delle pagine. Il calore e la spensieratezza dei gialli e degli aranci, i colori di Simon bambino, tingono un passo dopo l’altro le tavole mentre l’adulto si perde fra i vicoletti seguendo una vecchina o lasciandosi trasportare dal suono «tanto dolce, tanto tenero» di una lingua vagamente familiare. Ai colori caldi si aggiungono la luminosità dei bianchi e la freschezza degli azzurri e dei celesti della riva del mare dove Simon giunge mentre si innamora di un popolo e di una cultura che sente risuonare attorno e dentro di sé, quasi li conoscesse da sempre.
Il girovagare in quei luoghi reca dolcezza inattesa, malinconia e una strana sensazione di benessere mentre l’onda verde acquamarina torna a sommergerlo portando, almeno stavolta, una pacifica solitudine.
In queste pagine, il tratto sottile di Pedrosa sembra scomparire nelle silhouette delle persone per strada che sfumano in trasparenza, quasi impalpabili, e si sovrappongono, fino a confondersi con gli edifici e l’ambiente circostante.
La vitalità e la confusa allegria del Portogallo, rese attraverso l’affastellarsi di linee e voci, ci trasmettono le vivide sensazioni di straniamento e meraviglia di Simon nell’ascoltare per la prima volta da adulto il suono di una lingua in un paese sconosciuto. Cogliamo anche noi qua e là schegge di discorsi, qualche não, sim e muito bom carpito a caso: la melodia del portoghese è il sottofondo di ogni scena. I baloon gialli rimpiccioliscono e si moltiplicano nel tentativo vano di contenere un ciarlare talora ridotto a semplici la la la, note musicali, puntini di sospensione.
Nei pochi giorni della fiera, aprire il taccuino e prendere in mano una penna per ritrarre una sconosciuta torna spontaneo, mentre l’incanto verso quella terra cresce. I goffi tentativi di comunicazione in una strana mistura di francese, portoghese e inglese, accompagnata da gesti e sorrisi, conducono Simon a contatto con le persone e con le loro storie: così Maria gli insegna come mangiare le sardine con le mani e gli racconta degli orrori della dittatura di Salazar, la fuga, come tanti, in Francia alla ricerca di una vita migliore. Quei racconti, quelle parole traballanti portano Simon a una presa di coscienza importante:
Riesco a malapena a farmi capire […]. Questo linguaggio sommario, volto all’essenziale, per quanto sia frustrante, permette di mostrare solo il meglio di noi. […]. Li ascolto con l’illusione di trovarmi in un luogo familiare, di conoscerli da sempre. Li guardo e segretamente li amo. Ritrovo nei loro volti figure della mia infanzia.
Mentre ascolta e si innamora, Simon riconosce un antico legame con quella terra e con quelle storie. Tornano alla luce figure ora sbiadite dell’infanzia, memorie sepolte nel passato, insieme a un vago senso di nostalgia:
Tutte queste schegge di ricordi sparsi…
ricoperti dalle erbacce del tempo…
Erano lì. Dentro di me.
E me n’ero dimenticato.
Nel rispolverare il passato Simon ripensa alla nonna, alla sensazione di estraneità e all’imbarazzo per il suo forte accento portoghese: l’amore e la vergogna, la valuta delle famiglie migranti. Il congedo dal Portogallo ha un sapore dolceamaro, mentre un interesse nuovo si desta, ancora silenzioso.
Tornare a Parigi è lo stingersi dei colori, una sensazione di affogamento nel verde acquamarina dell’incomprensione, fino all’inevitabile rottura con Claire in un grigio giorno di pioggia.
Intanto, il taccuino Portugal. Maggio 2001 attende, anche lui dimenticato in mezzo al disordine. Attende il momento, attende le cose da dire che ancora mancano, attende le storie da scoprire, forse da inventare. Una domanda rimane sospesa nell’aria: «Seriamente, Simon… Di che cosa hai voglia?».
Un capitolo si chiude e, voltata la pagina, si apre una nuova tappa del viaggio: l’auto è ferma alla stazione di servizio Total, Jean esce dall’Autogrill litigando al telefono. Chiusa la chiamata, lascia che a guidare sia suo figlio Simon in un percorso di più di 500 km da Parigi fino ai pressi di Beaune, in Borgogna, per quel matrimonio il cui invito era stato la nota dissonante nella monotonia delle prime scene ambientate in Francia.
Il tratto graffiato, a volte nervoso di Pedrosa lascia qui il posto a uno stile più pulito e controllato. Nel primo capitolo gli acquerelli segnano i confini di Francia e Portogallo; nella seconda parte i colori, realizzati al computer da Ruby, divengono più classici e formali in accordo con il clima generato dai pochi giorni di una riunione di famiglia che, rimandata da almeno una quindicina d’anni, rivelerà segreti e storie conservati a lungo nel silenzio delle memorie personali.
La gioia delle nozze si trasforma a sera nell’ebbrezza di un banchetto in cui aneddoti e ricordi rivivono sulle labbra e attraverso gli occhi dei tre fratelli: le ribellioni giovanili di Yvette, le relazioni fallimentari di Jean e a notte fonda la curiosa scoperta di Jacques, l’unico nato “al paese”. Dal Portogallo, le carte per il rinnovo dei documenti testimoniano un’ortografia in realtà scorretta: la pronuncia del cognome trascritta secondo le regole della grafia francese. Una tessera alla volta, si ricostruisce parte del lacunoso mosaico della famiglia «Mucha senza t».
Il passato traluce fra le fessure mentre le ore scorrono lente, talvolta assaporate in silenzio insieme a un calice di buon vino. La rievocazione di antichi giochi, il muggire delle vacche nei pascoli mentre Jean racconta al figlio qualche episodio della sua infanzia, la paura della vecchiaia di Jacques. Nottetempo, la fuga dell’anziana suocera che si perde confusa fra i meandri dei ricordi e le illusioni della mente: il monito sulla caducità umana e sull’importanza della conservazione della memoria contro l’ineluttabile logorio del tempo.
Una consapevolezza che genera due moti opposti: alla stazione padre e figlio si salutano, al bivio. L’insofferenza di Jean, a più di cinquant’anni ancora assediato dalle ombre del passato, si traduce in fuga, una partenza anticipata per mettere più chilometri possibili fra sé e i fratelli. In direzione contraria, a colmare vuoti e ridurre distanze, alla ricerca delle radici e delle storie che in fondo gli appartengono, si muove Simon mentre arriva all’incrocio fra Gralens e Albi. Rievocate, le parole della lunga lettera del padre – confessioni che al lettore non è dato conoscere – lo accompagnano mentre l’auto solitaria attraversa i campi di grano. Pur consapevole di «voler guardare solo davanti a sé», lasciando indietro tutto il resto, Jean gli dona pochi preziosi frammenti del passato. Fra i fogli della lettera anche una vecchia foto in bianco e nero di un giovanotto. Sul retro: Abel-1936? Suo nonno. Spoglio e libero, Simon si tuffa. Stavolta sono le acque reali del fiume Tarn, le stesse dove suo padre giocava da bambino. Il verde acquamarina tinge le scene finali; mille domande affiorano su cosa fare di tutte quelle cose che forse sono finalmente da dire. Per raccontarle, però, bisogna spingersi un po’ più in là, tornare alle origini.
L’ultimo capitolo, l’ultimo viaggio attraverso tre stati, ripercorrendo in senso inverso le orme di Abel, inizia in un giorno di pioggia, nell’attesa dell’autobus Eurolines. La frontiera e la Guardia Civil sono alle spalle, il mattino inizia inondato di giallo e arancio con Satisfaction dei Rolling Stones in sottofondo mentre sulla A 25 i cartelli profilano gli svincoli del Portogallo.
In un balcone del Bairro Alto di Lisbona Simon si affaccia pensieroso, ma sorridente: i vestiti asciugano al sole stesi sui fili sopra i vicoletti della città. La voce di suo cugino giunge dall’interno della casa mentre gli porge una birra. Scanzonato e a tratti malinconico, Alessandro, professore di filosofia, ma anche responsabile del videoclub, allevatore amatoriale di uccellini e “contadino da balcone”, è una delle tante e più pure facce del Portogallo. Spirito semplice e ridanciano, a tratti venato di saudade, offre il suo aiuto a Simon. Alessandro è il portavoce di storie e tradizioni, talvolta fino al limite della credulità popolare, raccontate in un francese venato di interferenze portoghesi. Si improvvisa traduttore dei ricordi di sua madre Teresa e accoglie Simon con calorosa familiarità: sopa da pedra e il miglior vino portoghese mentre si sfogliano insieme vecchie foto.
La genuina ospitalità e la gentilezza smaniosa riempiono il bagagliaio della macchina di contenitori, vino, verdure, giusto un po’ di minestra e chi più ne ha più ne metta mentre Alessandro accompagna Simon al villaggio da dove Abel era partito senza farvi mai più ritorno: Marinha da Costa. La brevità del viaggio dilatata fino all’imbrunire da mille deviazioni di «solo due minuti»: dal cimitero alla panetteria di un amico che fa i pastéis de nata migliori del mondo per salutare e presentare quel cugino venuto da lontano a tutti quanti.
Nella casetta degli avi, il fluire delle cose rallenta in accordo con i ritmi della natura. Il pc del lavoro è presto dimenticato sul tavolo assieme a un sacchetto di patate, omaggio della premura della vecchia Amélia che gli lascia ogni sera una busta di prodotti dell’orto davanti alla porta.
Di nuovo, Simon si perde camminando per le placide stradine del villaggio, incantato dalla vegetazione rigogliosa. Tenta qualche saluto in portoghese quando incrocia uno sconosciuto, mentre la voce del suo arrivo si sparge. Così incontra «la figlia del fratello della madre di suo marito» e scopre che tutti sono un po’ parenti, tutti sono felici di aiutarlo e raccontargli qualcosa.
La vita più spontanea e sincera traspare dalla piccola e variegata moltitudine che popola Marinha da Costa: un vecchio che gli dà un passaggio e annuisce senza capire mentre gli racconta della guerra, il cugino Eugenio che gli offre da bere e gli parla di com’era stare al villaggio, Amélia che gli insegna i nomi in portoghese delle piante nell’orto.
Si dispiega il ventaglio di sfumature con cui Pedrosa esplora il concetto di petite mécanique, parole semplici e gesti quotidiani, in apparenza insignificanti, ma che raccontano la vita vera e ci toccano nel profondo. Talvolta sono momenti solitari, altre volte condivisi in silenzio come fa Simon mentre ritrae Amélia lavorare nell’orto. Raccontare il quotidiano, «affilare e lucidare le piccole cose» della vita. È così che Pedrosa costruisce una storia di uomini e donne, di relazioni che si deteriorano, di altre che rifioriscono. La piccola ritualità della vita di tutti i giorni è indagata nel suo dettaglio più minuto in questo capitolo così caro all’autore, la cui mano si muove ancora più rapida, disegnando di getto sulla scia di un’intuizione in una corsa a perdifiato contro le scadenze editoriali imminenti.
Una corsa simile a quella di Simon in sella a una vecchia bici del ’36 fino al cemitério dove legge parte della storia della famiglia «Mucha senza t» incisa sulle lapidi insieme all’eterna saudade.
Ricordi sbiaditi, vecchie foto e memorie dimenticate per ricostruire il canovaccio di una storia incerta e lacunosa. Sfogliando vecchi album, Teresa pazientemente spiega e risponde alle sue domande in portoghese, mentre Simon prende appunti sul taccuino nero e cerca di interpretare le sue parole.
Il mio portoghese era traballante, ma cominciavo ad abituarmi a quelle conversazioni tortuose nelle quali il mistero di una frase si svelava alla comprensione di una sola parola come per incanto.
Le ombre si addensano sulle vicende dei fratelli Mucha, che un giorno lasciarono il Portogallo per la Francia; Simon scruta a fondo la vecchia foto del nonno e del fratello Manuel, sempre più vicino, incapace di coglierne il mistero: un pugno di nulla in una mano, un nuovo benessere nell’altra.
E se la notte di São João le persone si colpiscono a suon di martellate in testa per fare ammenda e risvegliarsi dal torpore, anche Simon si ridesta. Quando prova a incastrare qualche frase in portoghese per parlare con Amélia, inaspettatamente la donna gli risponde in francese perfetto e gli dona un ultimo sibillino tassello: la storia di un muchacho spagnolo che incrociò le proprie sorti con quelle dei Mucha. Alle domande che si moltiplicano senza soluzione, Simon risponde con la decisione di far pace con il passato: seppellire accanto alle tombe di famiglia la foto di quel giovanotto di nome Abel che era partito e non era più riuscito a tornare.
La fantasia per sopperire ai dubbi, la necessità tuttavia di continuare a esplorare quel paese:
Caro papà, resterò in Portogallo un po’ più del previsto…ho voglia di disegnare questo Paese. Vedremo dove mi porterà.
La voliera degli uccelli si spalanca, qualcuno spicca il volo. Il taccuino nero pian piano si schiude: Simon Mucha, Marinha da Costa. Appunti in francese e bozzetti ne fuoriescono. E poi quella vecchia cartolina, con una domanda che risuona in Simon e probabilmente nel padre Jean, scritta da Abel:
«Sai, a volte, la gente di qui, per via del mio accento mi chiede “Ma tu cosa sei? Portoghese o italiano?” […] E io rispondo sempre: “Io sono Abel Mucha, tutto qui”. Ovunque io vada sono sempre lo stesso».
E infine la dedica di Pedrosa a “tutti quelli che partono, talvolta senza mai fare ritorno”.
Bibliografia:
Anspach N., Cyril Pedrosa (“Portugal”): «L’autobiographie a une contrainte de taille: la vérité!», in ActuaBD, 2011
Kruk A., Między Portugalią a Francją, między słowem a obrazem – odbiór wielojęzyczności oryginału w przekładzie komiksu Portugal Cyrila Pedrosy, in «Applied Linguistics Papers», vol. 25, 2018, pp. 53–64
Pasetti T., Intervista a Cyril Pedrosa: «Con il fumetto cerco di capire il senso della mia vita», in Lo spazio bianco, 2013 e poi 2018.
di Elisa Centinari