Riflessioni su “Fahrenheit 451”
il monito letterario di Ray Bradbury
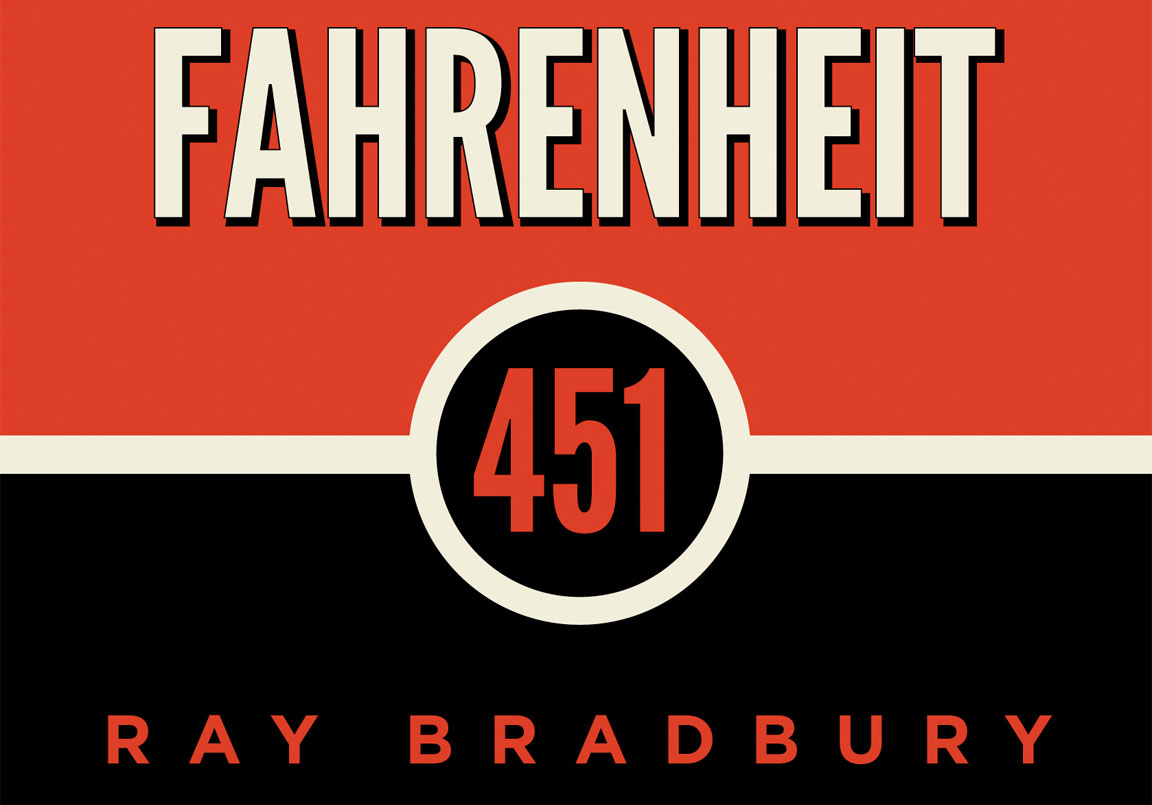
Lessi Fahrenheit 451 per la prima volta a diciassette anni, ma non lo capii. Da brava studentessa liceale alternavo capitoli del libro in lingua originale a una mole spropositata di compiti pomeridiani; in breve, vedevo in quel romanzo un dovere da assolvere, la classica lettura scolastica dal significato allegorico, il libro-metafora che era necessario leggere per poi sviscerarne tutti i potenziali o presunti significati alla professoressa durante l’interrogazione.
Probabilmente lo lessi con distrazione, forse saltai pure qualche pagina per arrivare più velocemente al finale; di certo non lo considerai una pietra miliare della mia formazione letteraria. Ma mi sbagliavo; avrei dovuto rileggerlo a dieci anni di distanza per rendermene conto.
È strano notare come il nostro punto di vista si modifichi nel tempo, condizionato in parte da contesti e situazioni, sicuramente alterato dal vissuto trascorso. Ora considero l’opera di Ray Bradbury un tassello imprescindibile della letteratura universale, un libro che sprigiona forza perché in grado di innescare una rete di pensieri divergenti, di parlare di umanesimo a una società che sembra aver dimenticato il significato di questo termine. È stata la curiosità degli ultimi giorni di lockdown a farmi riprendere in mano quel vecchio libro; da un po’ di tempo mi sembrava venisse citato ovunque, quindi mi sono concessa il lusso di una seconda lettura e, con mio stupore, quelle pagine hanno assunto tutt’altro significato.
La demonizzazione della cultura genera mostri – ecco in un assunto la morale insita in Fahrenheit 451. Nella società futuristica immaginata da Bradbury la cultura ha perso ogni significato, la lettura viene concepita come un demone che deve essere debellato. I libri vengono materialmente bruciati, inceneriti da un esercito di pompieri il cui compito non è spegnere le fiamme, ma attizzarle, in veri e propri roghi di libri che ricordano quelli aizzati dai nazisti nel maggio del 1933.
È stupefacente il modo in cui in cui un romanzo edito quasi mezzo secolo fa riesca ancora a parlare al nostro presente. Forse leggere Fahrenheit 451 accompagnava l’immaginazione dei lettori novecenteschi in un futuro possibile, mentre oggi si ha la strana sensazione – venata d’inquietudine – di essere catapultati in un universo non poi molto lontano dal nostro.
Non è certo necessario uno sforzo di immaginazione per attualizzare quanto scritto da Bradbury: soprattutto oggi, nel catastrofico 2020, dove ci ritroviamo a trascorrere la maggior parte delle giornate di fronte ad uno schermo – novelli paladini della modalità smartworking, ed intanto assistiamo impotenti alla crisi inesorabile dell’industria editoriale.
«È in atto una crisi culturale/ La crisi della cultura oggi è più di una crisi politica», tuonano i giornali con i loro titoli in grassetto, denunciando un sistema che non dà più valore all’istruzione scolastica, alla ricerca, alle lettere classiche e alla filosofia; in generale all’approfondimento colto ed analitico. L’emergenza Covid-19 ha esasperato tensioni già in atto: scuola online, lavoro sempre più digital, meno fondi per le attività di ricerca, infine la chiusura prolungata delle librerie ha rappresentato il culmine di una crisi già in spaventosa ascesa dal 2008.
Il significato di Fahrenheit 451 nel contesto attuale risuona con la gravità di un campanello d’allarme, mostrandoci le tenebre di una società iper-tecnologica che sembra aver del tutto assoggettato l’uomo, ormai ridotto alla passività, alla più becera incoscienza. L’umanità descritta da Bradbury marcia al ritmo degli slogan pubblicitari, trascorre le giornate dialogando con i personaggi della tv, ha fatto dell’intrattenimento un autentico stile di vita, oltre che la ragione cardine della propria esistenza. Leggendo queste pagine viene spontaneo riflettere, porsi domande: lo schermo su quattro pareti descritto da Bradbury ora esiste?
Inevitabile pensare ai social network, a quell’artificioso mondo-bolla che ci mostra solo ciò che vogliamo vedere, cullandoci in una realtà fatta perlopiù di apparenze e opinioni contraffatte. In Fahrenheit 451 la società appare dominata da contenuti privi di significato profondo, ideati con l’unico scopo di intrattenere, divertire, e di conseguenza impedire alla gente di pensare con la propria testa.
Nel romanzo di Bradbury la diciassettenne Clarisse McClellan passeggia in un mondo in cui nessuno ormai cammina più; tutti seguono il moderno mito della velocità, sfrecciano su auto supersoniche in grado di portarli il più rapidamente possibile alla meta prefissa. Ciò che conta è arrivare, velocizzarsi, si è perso il gusto del viaggio, della scoperta.
Nessuno si guarda nemmeno più attorno: «A volte penso che i guidatori non sappiamo cosa sono l’erba e i fiori, perché non li guardano mai lentamente» dice Clarisse. Ed è proprio il suo personaggio a fare la differenza: appare e scompare nell’arco di un capitolo, eppure le sue parole si incuneano nella mente del lettore e non se ne vanno più via, restano indelebili. Perché Clarisse pensa, riflette: sembra essere la sola a vedere il lato profondo della vita, oltre la superficie.
Sono un po’ asociale, non mi piace mescolarmi. È strano perché in fondo la società mi interessa, ma tutto dipende da cosa s’intende per stare insieme, non credi? Per me significa parlare con persone come te di certe cose. […]
Per me questa non è società: è una serie di tubi dove l’acqua entra da una parte ed esce dall’altra.
Nessuno fa domande, o almeno la maggior parte non ne fa; ci danno soltanto le risposte, bing, bing, bing, e noi ci sorbiamo quattro ore di tele-insegnamento.
«Lei pensa troppe cose», afferma il pompiere Guy Montag troncando il monologo di Clarisse; ma ormai il dado è tratto. L’incontro di Montag con la ragazzina è il punto cardine attorno a cui ruota tutto il libro. È proprio Clarisse a svelare l’inganno creato da una società omologata, mostrando il proprio punto di vista e originando la spinta necessaria per il cambiamento.
A una prima lettura non mi ero resa conto di quanto il personaggio di Clarisse McClellan fosse prezioso; sono proprio la sua diversità, la sua apparente stranezza, a renderlo straordinario. Il mondo visto attraverso i suoi occhi acquisisce un altro significato, diventa migliore. Apparentemente lei divaga, dice cose semplici, che però nascondono verità complesse. È la sola a chiedere a Montag con leggerezza «Lei è felice?», la domanda che nessuno pone mai.
L’opera di Bradbury si presta a molteplici chiavi di lettura; non ultima, quella biblica: non passano inosservati i riferimenti al Libro di Giobbe e all’Apocalisse, alle pagine dell’Ecclesiaste. Infine l’unica via di trasmissione della cultura è quella orale, non a caso la stessa adottata dai profeti dell’Antico Testamento. Ci immaginiamo questi uomini in cammino, impegnati a tramandare storie, nella ricerca di una nuova Terra Promessa. Su tutto incombe l’imminenza della catastrofe nucleare, la possibile fine del mondo conosciuto. Non si risparmia nulla Bradbury, riesce a condensare in meno di duecento pagine l’essenza della condizione umana, regalandoci una commovente riflessione sulla dicotomia morte/vita.
Un romanzo scritto nel lontano 1953, considerato il capolavoro della letteratura distopica, sembra profetizzare con sconcertante precisione le tendenze attuali. Quando lo scrisse, Bradbury era un uomo della sua epoca, inquietato dall’avvento delle televisioni, considerate acerrime rivali dei libri; si era appena agli albori della società dei mass media, quelle scatole parlanti che chiacchieravano a profusione nei salotti delle case erano guardate ancora con un certo sospetto. Inoltre l’America entrava nell’atmosfera tesa della Guerra Fredda, iniziavano le prime retate contro i comunisti o presunti tali. Da qui l’idea di narrare un futuro distopico dove vengono censurati i pensieri, si è costretti a guardare la televisione a tutte le ore del giorno e i libri vengono bruciati. Bradbury intendeva estremizzare la società del proprio tempo, racchiudendo nella sua opera tutti i timori, le angosce e le previsioni catastrofiche concepibili nella delicata fase storica da lui vissuta; forse ne scrisse nel tentativo di esorcizzarli.
La storia editoriale di Fahrenheit 451 è alquanto bizzarra e merita un breve accenno: il romanzo nacque come espansione di un breve racconto, The Fireman, pubblicato originariamente sulla rivista Galaxy Science Fiction nel febbraio del 1951, in seguito una forma più estesa della storia apparve in più puntate sulla nascente rivista Playboy. In Italia arrivò a dicembre dello stesso anno, edito in sordina sul mensile Urania sotto il titolo poco felice “Gli anni del rogo.” Il titolo inglese poteva non essere chiaro al grande pubblico, così si optò per un’interpretazione, decisamente poco riuscita. Con Fahrenheit 451 Bradbury intendeva indicare la temperatura a cui la carta brucia, anche se la spiegazione non è presente nel romanzo.
Fortunatamente il libro ottenne maggior successo con il proprio titolo originale, con il quale tuttora viene osannato dal pubblico di tutto il mondo. Di recente ha riscontrato larga diffusione in Turchia, dove il popolo turco ha ritrovato in esso un baluardo da ergere contro il regime dittatoriale vigente.
Alla fine cosa narrava Fahrenheit 451 se non una storia contro la censura, un monito contro il lavaggio del cervello fatto all’umanità? Non è certo un caso che al termine del romanzo gli uomini si tramutino metaforicamente in libri, facendosi veicoli di trasmissione del sapere: «Siamo pezzi e bocconi di storia, letteratura, diritto internazionale».
La demonizzazione della cultura genera mostri, oggi più che mai è doveroso ricordarlo.