Rivoluzionarie, eretiche, indomite: le donne di Soledad Acosta Kemble
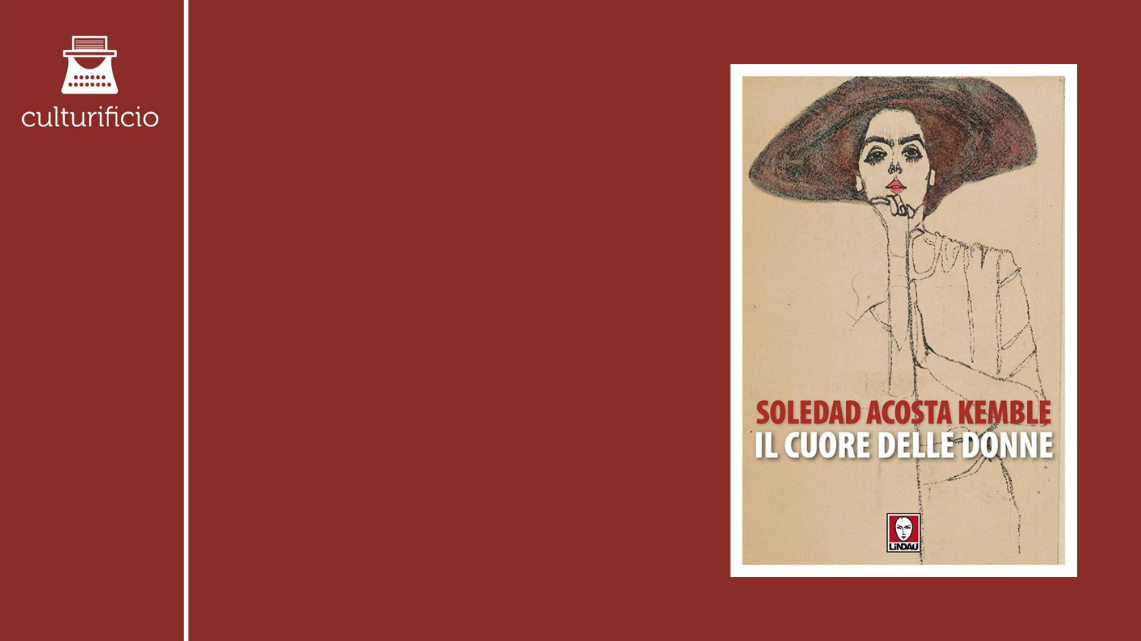
Il cuore delle donne è un mistero perché «scorge l’amore ancora prima di comprenderlo».
A scriverlo è la scrittrice e giornalista colombiana Soledad Acosta Kemble, una delle pioniere del femminismo moderno. Ancora poco conosciuta in Italia, Kemble è stata una grande intellettuale di formazione multiculturale che si è battuta a lungo perché le donne avessero diritto all’istruzione e potessero partecipare attivamente alla vita politica.
Nata a Bogotà il 5 maggio 1833, Soledad Acosta scrisse in un’epoca in cui le donne ancora non avevano voce, impugnando la penna alla stregua di un’arma rivoluzionaria perché, attraverso la scrittura, restituiva quella capacità di dire negata a ogni donna, non istruita o colta, nobile o popolare, parlando indiscriminatamente a tutte.
Figlia di Joaquín de Acosta, un ingegnere militare, diplomatico ed esperto naturalista e di Caroline Kemble Rowe, fine intellettuale di origini britanniche, Soledad crebbe in un contesto culturale vivace e cosmopolita e si batté tutta la vita per l’educazione delle bambine. L’istruzione femminile infatti, in quegli anni, non era contemplata – l’analfabetismo regnava sovrano – Soledad Acosta fece della sua scrittura una sfida politica: scrivere delle donne e per le donne. Nei suoi ottant’anni di vita firmò oltre una ventina di romanzi e saggi, sperimentando tutti i generi letterari, dalla narrativa alla saggistica, dalla forma diaristica al reportage giornalistico, trasformando la propria parola in uno strumento di riscatto e di istruzione. Leggendo i suoi articoli, i suoi racconti e i suoi libri, le donne acquisivano conoscenza e, soprattutto, una più profonda consapevolezza. Nel 1867, dopo il matrimonio con il giornalista e critico José de Samper che fu sempre il suo principale sostenitore e con il quale coltivò un rapporto all’insegna della parità, Soledad pubblicò il suo primo romanzo: Dolores. Cuadros de la vida di una mujer. Già in quella prova romanzesca, ancora acerba, poneva l’elemento femminile al centro affrontando temi che avrebbe poi sviluppato in Novelas y cuadros de la vida sur-americana (1869). Seguirono gli anni tumultuosi della guerra civile, Soledad visse con il marito tra Parigi e Lima, per poi tornare in Colombia nel 1878 dove fondò «La Mujer», la prima rivista sudamericana diretta e scritta interamente da donne.
Ora la casa editrice Lindau ci restituisce la figura di Soledad Acosta Kemble attraverso una delle sue opere più celebri, Il cuore delle donne, proposta nella traduzione italiana di Monica Rita Bedana ed Elena Ramazzina. Dal libro, una raccolta di sei racconti scritti in uno stile ibrido tra romanzo e saggio, di recente è stata tratta anche una fortunata miniserie per la tv dal titolo El corazón de la mujer y otras desventuras.
La struttura è decameroniana: i racconti sono inseriti in una precisa cornice, narrati da donne e da uomini che si alternano tra loro nell’intrattenere l’uditorio, proprio come nelle giornate boccacciane.
Ogni storia, come si addiceva alla convenzione letteraria dell’epoca, ha un preciso risvolto morale e custodisce un insegnamento. La trama si apre con Matilde che, in seguito a un malore, viene accolta nella piccola canonica dove vivono due sorelle insieme allo zio parroco. Il marito riprende il viaggio e lascia Matilde in compagnia degli sconosciuti perché si rimetta in forze; quella sarà l’occasione per la donna di raccontare la propria storia in cui progressivamente si viene a scoprire che l’uomo che ha sposato non era, in realtà, l’uomo che amava: «Ormai avete visto in che modo un carattere debole come il mio sia riuscito a costruirsi la sventura».
Dalla vicenda di Matilde si diramano poi altre storie di donne, tutte concatenate tra loro, che la vivace combriccola si racconta per intrattenersi chiacchierando sul portico della casa.
Non lasciatevi tuttavia ingannare dal titolo, Il cuore delle donne di Soledad Acosta Kemble non parla di donne innamorate, ma di donne rivoluzionarie, anticonformiste, ribelli, persino eretiche, capaci di votare completamente la propria esistenza a Dio per espiare una colpa, oppure di rinnegare del tutto ogni divinità dopo averla sfidata a compiere l’impossibile miracolo. Forse il vero filo conduttore della raccolta non è l’amore, ma il dolore: tutte le personagge dei racconti di Acosta Kemble soffrono, e sono accomunate da una sorta di «vocazione al trionfo e al pianto». Si parla molto di sentimenti, ma raramente si avvera un auspicabile lieto fine, perché sono storie incentrate sui limiti e la fallibilità dell’umano.
Giovani, vecchie, sane o malate, povere o ricche, le protagoniste de Il cuore delle donne sperimentano la purezza dei sogni che si infrange contro il vero volto, spietato, della realtà: alcune vivono di cucito o di ricamo mantenendosi con i proventi del proprio lavoro, altre subiscono le angherie di un marito prepotente e violento, altre ancora accettano di rinunciare all’amore della propria giovinezza con apatica rassegnazione. C’è chi si ribella con coraggio e chi, invece, si vota a un’esistenza di abnegazione. Tutte sono imprevedibili e fanno qualcosa di inatteso; nessuna di loro è vittoriosa e, al contempo, nessuna è davvero vittima. Ci sono le sommerse e le salvate; ma qualcosa, in fondo, le unisce ed è quel momento di purezza assoluta che ciascuna ha provato almeno una volta nel corso della propria vita, lo sbocciare di un amore totalizzante, la vertigine inattesa del desiderio e del sogno, «il sentimento del bello e una tale disposizione alla tenerezza» che in fondo è racchiuso, intatto e delicato come un fiore, nel cuore di ogni donna.
Gli amori narrati in queste pagine corrono sul filo della rivoluzione e si combinano necessariamente col dolore, la malattia, la caducità della vita. Il romanticismo si intesse stretto con la disperazione, ha tinte incendiarie, assume il tono di una ballata triste: «Lì cerca Manuelita e dille che sono morto mentre lei ballava. Sono sicuro che se le dici questa frase non mi dimenticherà mai». Difficile stabilire dove finisca l’amore e dove invece inizi la volontà di possesso, mascherata dietro il velo sottile del ricatto; come nel caso di Manuelita che porterà con sé per sempre una compassione infinita per lo sventurato giovane che diceva di amarla.
«La donna è la persona che meglio conosce le donne» scrive con cognizione di causa Soledad Acosta Kemble nel prologo dell’opera, intrecciando introspezione psicologica e analisi sociale. Era il lontano 1869 e la scrittrice colombiana stava anticipando posizioni e tematiche del femminismo moderno con un’indagine sulla sorellanza che appare progenitrice di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf (1929).
Nell’esplorare il cuore delle donne l’autrice ci dimostra che non è uno ma molteplice, che il femminile è plurale e ogni vita, infine, rimane un mistero persino per sé stessa.
Nel cuore delle donne esiste un mistero, e quel mistero, che gli uomini si affannano inutilmente a comprendere, a sua volta non riesce ad analizzarsi in profondità e in ogni dettaglio.
Forse queste narrazioni di tenacia potrebbero apparire in parte desuete alle lettrici di oggi – certi temi, quali il matrimonio combinato o la scelta del noviziato, risultano antiquati o, se non altro, superati – tuttavia a una lettura più profonda si comprende che non è così, perché ciascuna di queste donne ha aiutato ad aprire una strada per il nostro cammino verso l’emancipazione e l’indipendenza.
Le donne di Soledad Acosta Kemble, dissidenti e rivoluzionarie, sono in fondo le nostre sorelle, le nostre madri, le nostre nonne, avvertiamo con loro un legame quasi sanguigno, un’affinità di destino, nell’intima certezza di un comune sentire. Perché, se accettiamo che il cuore femminile rimanga un mistero, dobbiamo riconoscere che solo una donna può raccontare le donne.