Storia di un tramonto viennese: “La cripta dei Cappuccini” di Joseph Roth
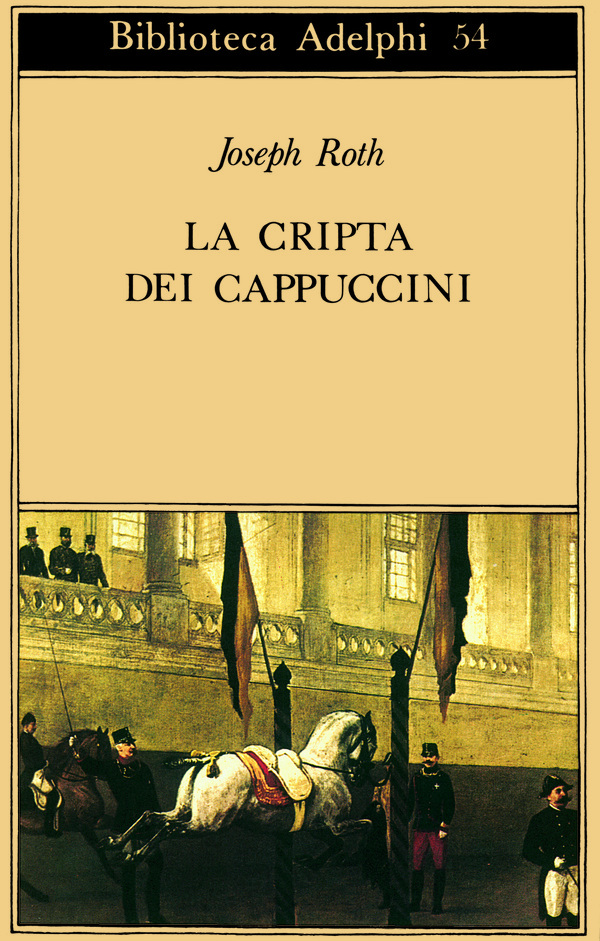
Leggere La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth è come visitare una cristalleria: è impossibile non ammirare la grazia fragile del mondo circostante; ma, allo stesso tempo, inevitabile percepirne lo statico anacronismo. Attraverso lo sguardo disilluso e romantico del protagonista-narratore, Roth consegna al lettore un grande affresco della Vienna primo novecentesca. Il punto di vista è quello del barone Trotta, un giovane aristocratico acuto, eppure docile: un rampollo disavvezzo alla fatica e curioso, orfano di un padre che emerge qua e là come figura di statura per lui irraggiungibile e figlio devoto di un’anziana dama severa. La figura materna, nel suo rigore reazionario, acquisisce nel corso del romanzo un evidente valore simbolico: incarna i valori del sogno dorato che, per il protagonista e la sua cerchia di nobili amici – e forse solo per loro, nella parzialità del loro sguardo –, ha costituito l’impero austro-ungarico.
Un mondo cosmopolita che faceva capo alla gloriosa magnificenza di Vienna, la sua capitale altera, circoscritta nella sua grandezza, morta, in fondo, sotto il prezioso manto delle consuetudini. Per ucciderla, e con essa non solo la decadente, annoiata e spensierata compagnia di aristocratici che la popola nell’arco dell’intero romanzo, ma anche il sogno cosmopolita di cui rappresentava la superba guida, bastano tre parole: «Ai miei popoli!». È l’incipit del «proclama del nostro vecchio imperatore Francesco Giuseppe»”: corre l’anno 1914 e l’Austria-Ungheria sancisce la propria fine con l’inizio della Prima Guerra Mondiale. Si rivela allora il duplice pregio letterario del romanzo: da una parte, l’introspezione psicologica e la finezza della storia individuale; dall’altra, la vividezza delle tappe della storia collettiva.
Il narratore-protagonista Trotta trova nella chiamata alle armi una scintilla che fa divampare un incendio nella noiosa paralisi della sua giovinezza. Lo assale allora l’improvvisa convinzione di dover sposare l’amata Elisabeth. Lo consuma il desiderio di combattere al fianco del suo povero cugino Joseph Branco, un caldarrostaio sloveno, e del vetturino ebreo galiziano Manes Reisiger – non tanto per ardore bellico, quanto per l’irresistibile fascino di quelle esistenze periferiche in cui lo stesso Roth, anch’egli ebreo galiziano, doveva riconoscersi. I due, le cui visite scandiscono la prima parte del testo, sono gli unici popolani che svolgono un ruolo importante nella trama; non a caso, del resto, provengono da aree diverse di un impero tanto vasto quanto scricchiolante. La loro semplicità, ritratta dall’autore nei toni chiaroscurali delle anime che uniscono al fiuto per gli affari un’ingenuità provinciale, li rende agli occhi del protagonista importanti, unici, diversi dalla noia decadente delle sue amicizie viennesi, e gli forniscono un ritratto grandioso del sogno di cosmopolitismo dell’impero.
Ma l’esaltazione e il divampare improvviso degli eventi si accompagnano presto alla crudezza della storia: la sonora sconfitta delle truppe patrie, le vicissitudini di un uomo lontano per anni dai propri affetti, la povertà diffusa di quella Vienna che, devastata dalle gravi conseguenze economiche della guerra, deve fare i conti con un nuovo tempo. Nessun manuale di storia spiegherà mai con altrettanta verosimiglianza l’atmosfera in cui la società mitteleuropea sprofondò nel periodo interbellico. Emerge qui lo spettro dell’antisemitismo, come uno sfogo rabbioso, nelle parole della madre del protagonista e nella commovente fuga finale del barista ebreo Franz, consapevole di non avere più, nel suo Paese, una patria. In questo passaggio è palese il riferimento autobiografico: Joseph Roth, ebreo, era fuggito nel 1933, in occasione della nomina di Hitler a cancelliere tedesco, dalla Germania. La vita dell’impero s’è ormai conclusa: le luci sfavillanti della Vienna imperiale s’incantano, vacillano, e tutta la sua manierata aristocrazia appare all’improvviso così ottocentesca, antica, superata: morta. Il bisogno di occuparsi delle faccende economiche e il tentativo di destreggiarsi in una nuova realtà sociale pare siano destinati a scontrarsi con la sua chiara inadeguatezza, se non con il suo orgoglio. Si delinea, così, il ritratto di una generazione travolta dalla storia.
«Io appartengo ancora oggi – nell’imminenza della mia probabile ultima ora, io, un uomo, posso dire la verità – a un mondo palesemente tramontato» afferma il protagonista, sconsolato, in preda alla consapevolezza di essere un «escluso», «un escluso in mezzo ai vivi», ossia – poiché tutto torna al retaggio culturale dell’impero, nella sfranta terra di Francesco Giuseppe – un «extraterritoriale in mezzo ai vivi».
È la grande fase dell’abbandono: vita personale e storia, ancora una volta, s’intrecciano fino a confondersi: fili della stessa, fittissima trama del tempo che, inesorabile, scorre.
La Cripta dei Cappuccini, perciò, non è soltanto il ritratto di un fragile sogno infranto, né solo un’elegia in nome della figura che lo ha incarnato, l’imperatore Francesco Giuseppe, ma anche una grandiosa favola di solitudine, isolamento, ritiro, appartenenza a un tempo e a un luogo. Il nazionalismo che fin dal principio pervade le pagine del testo è quanto di più lontano si possa immaginare dalle grida finali «Compatrioti! Il governo è caduto. Abbiamo un nuovo governo popolare tedesco!» che, come la storia insegna, avrebbero drammaticamente attecchito in un mondo povero, bisognoso di orgoglio e ricco di rabbia. Grida di cui, ancora una volta, il barone Trotta non si capacita e, insieme, non si compiace:
Da quando ero rimpatriato dalla guerra mondiale, rimpatriato in un paese pieno di rughe, mai avevo avuto fiducia in un governo; figuriamoci poi, in un governo popolare.
La Cripta dei Cappuccini è l’eloquente affresco di un passato fantastico, spensierato, sopito; è la prova del fatto che cosmopolitismo e apolidia non sono sinonimi. Soprattutto, è un inno alla bellezza dell’umanità più disparata, alla sua debolezza, al suo conservatorismo ottuso e al masochistico rifiuto all’adattamento. Un inno, insomma, all’incapacità di rinnegarsi, anche sotto la frusta di una dolorosa storia collettiva.
di Carlo Danelon