Il Bene e il Male:
il problema dell’altro, lo sterminio, la «zona grigia» e noi

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre
La tendenza a suddividere la realtà in Bene e Male, a individuare buoni e cattivi, eroi e mostri, e ad ignorare qualsiasi altra classificazione morale più indefinita è caratteristica dell’uomo.
In effetti, tale divisione binaria ha anche un’evidente (e forse cronologicamente anteriore) accezione geografica e sociale. Ad esempio, secondo gli antichi Greci – che pure non formavano una nazione unitaria – chiunque non parlasse greco e fosse straniero era un barbaro; e se tale definizione in un primo momento fu soltanto differenziale, ossia indicativa di una certa diversità (consentendo tra l’altro al popolo greco di assumere coscienza di sé e della propria peculiare cultura), assunse poi una sfumatura dispregiativa: chi è simile a me – cioè vive vicino e in maniera pressoché identica a me, in senso geografico, sociale, linguistico e culturale – è un uomo; chi invece è diverso, diventa un subumano, e può essere fatto schiavo. Lo spregio chiaramente ha una direzione anche morale: da una parte i buoni, dall’altra i cattivi; in mezzo il vuoto. I Greci sono temerari e coraggiosi eroi, i Persiani perfidi e malvagi assassini. Nessuna sfumatura di sorta. Mi rendo conto di aver semplificato molto, occorre dunque una precisazione. La società greca era anche al suo interno fortemente differenziata: la stessa democrazia ateniese era tale – almeno in senso moderno – solo a livello elitario, in quanto soltanto gli uomini (quelli ateniesi) potevano partecipare al governo della polis.
Ma lo schema è indicativo: spesso (o sempre?) un insieme di uomini, per diventare cosciente e convinto protagonista delle proprie vicende, ha bisogno di un nemico, cioè di un antagonista; tale nemesi può essere concreta – ad esempio un popolo straniero, una determinata etnia –, astratta – un’ideologia antitetica alla propria – o, ancora, tutt’e due le cose insieme: pensiamo all’Unione Sovietica e agli Stati Uniti nel secondo Novecento, oppure ai musulmani e ai cristiani nel Medioevo. Tutti questi esempi ci confermano che per definirsi e assumere coscienza di sé un gruppo ha bisogno di confrontarsi con un altro gruppo, così come un essere umano per realizzare il proprio Io necessita della vicinanza di altri esseri umani coi quali rapportarsi. L’Io assume forma propria in relazione all’Altro, in un incontro-scontro che può avere effetti o positivi o negativi. Adesso, io posso propormi di conoscere realmente l’altro oppure no: nel secondo caso, di esso avrò un’immagine falsa e pregiudicata, perché sarò io stesso a rappresentarlo secondo i miei gusti, i miei valori e i miei interessi; e comunemente, se non comprendo l’altro, lo reputo a me inferiore e vi entro in conflitto: ogni azione mirata a difendere e preservare il mio gruppo sarà positiva. Il solipsismo di tante comunità umane è insieme causa e conseguenza di questa infausta tendenza.
 Ne La Conquista dell’America (1982) di Tzvetan Todorov il «problema dell’altro» rappresenta proprio il fulcro della discussione, e qui l’urto con l’altro, con il diverso è ancora più radicale ed esemplare. Todorov pone tutta la sua attenzione sull’evento cruciale della storia moderna, la conquista dell’America, scegliendo un periodo storico limitato, compreso tra il 1492 e il 1600 circa, e una zona geografica ben definita, la cosiddetta Mesoamerica, che più o meno coincide con i Caraibi e l’attuale Messico. L’incontro tra Europei e Indios viene ricostruito attraverso le parole dei principali protagonisti (europei) coinvolti: Colombo, Cortés, il domenicano Las Casas, gli storici Duràn e Sahagùn. Gli Europei non riescono a comprendere gli indiani: Colombo è troppo miope e disinteressato per farlo; Cortés si sforza di farlo, e in parte ci riesce, ma solo per poterli conquistare meglio; Las Casas, che pure li ama, non ne è in grado, accecato com’è dal suo cristianesimo; Duràn e Sahagùn vi si avvicinano, ma solo lievemente. In generale assistiamo anche qui a una continua rappresentazione dell’altro da parte (e negli interessi) di un Io più forte ed egocentrico, fino a eccessi quantomeno ridicoli: per esempio, secondo Duràn gli indiani sarebbero una delle tribù perdute di Israele; per Las Casas invece sono il più bello dei popoli, sicuramente il più «cristiano» – loro, che il Cristianesimo non l’hanno mai conosciuto!
Ne La Conquista dell’America (1982) di Tzvetan Todorov il «problema dell’altro» rappresenta proprio il fulcro della discussione, e qui l’urto con l’altro, con il diverso è ancora più radicale ed esemplare. Todorov pone tutta la sua attenzione sull’evento cruciale della storia moderna, la conquista dell’America, scegliendo un periodo storico limitato, compreso tra il 1492 e il 1600 circa, e una zona geografica ben definita, la cosiddetta Mesoamerica, che più o meno coincide con i Caraibi e l’attuale Messico. L’incontro tra Europei e Indios viene ricostruito attraverso le parole dei principali protagonisti (europei) coinvolti: Colombo, Cortés, il domenicano Las Casas, gli storici Duràn e Sahagùn. Gli Europei non riescono a comprendere gli indiani: Colombo è troppo miope e disinteressato per farlo; Cortés si sforza di farlo, e in parte ci riesce, ma solo per poterli conquistare meglio; Las Casas, che pure li ama, non ne è in grado, accecato com’è dal suo cristianesimo; Duràn e Sahagùn vi si avvicinano, ma solo lievemente. In generale assistiamo anche qui a una continua rappresentazione dell’altro da parte (e negli interessi) di un Io più forte ed egocentrico, fino a eccessi quantomeno ridicoli: per esempio, secondo Duràn gli indiani sarebbero una delle tribù perdute di Israele; per Las Casas invece sono il più bello dei popoli, sicuramente il più «cristiano» – loro, che il Cristianesimo non l’hanno mai conosciuto!
L’incomprensione si coniuga a (e trae origine da) un desiderio di ricchezza e conquista che sfocia infine in un’assimilazione pressoché totale dell’altro e finanche nella sua distruzione.
In tutto questo, i confini tra Bene e Male non sono mai sfumati, o quasi: in un certo senso perdono valore, in un altro lo acquistano. I sacrifici umani sono un crimine, il massacro di tanti uomini e donne no. Nell’ottica dei conquistadores è fondamentalmente giusto far sbranare un’indiana dai cani, compiere stupri di gruppo nei villaggi, lanciare bambini inermi contro le rocce, torturare i prigionieri con carboni ardenti o schiavizzare interi popoli: l’altro è un essere inferiore, un subumano; se alzerò la mano contro di lui, non potrò essere perseguito: il Bene diventa semplicemente ciò che è legittimo o consentito. Secondo alcuni missionari cristiani questi invece sono atti abominevoli, ma le loro proteste contano poco: nella frenesia della conquista, e in generale nel caos della guerra, sono i forti a ergersi quali padroni assoluti e dissoluti. In ogni caso, di là degli eventi più particolari, la conquista è un atto benefico, compiuto nel segno di Dio e della civiltà: su questo sono d’accordo tutti. Il Bene ha trionfato.
Ma se Bene e Male sono due categorie che intervengono nei rapporti interpersonali e sociali, possono anche essere due caratteristiche interne all’uomo, due metà di esso che emergono quando ciascuno interroga se stesso o viene giudicato dagli altri. Il sosia, lo specchio, il doppio, il ritratto; sono innumerevoli gli espedienti letterari utilizzati per rappresentare artificiosamente questa presunta biforcazione dell’anima. Stevenson immagina addirittura che il suo personaggio, grazie ad una miracolosa pozione, si possa scindere in due diverse persone: il Dottor Jekyll, dopo aver assunto la bevanda, può trasformarsi nella sua controparte maligna, Mr. Hyde – e va detto che il messaggio dello scrittore inglese è indubbiamente pessimistico: chi cede al male poi non può più liberarsene. Calvino invece si spinge ancora più in là, e lo fa ironicamente. Il visconte Medardo di Terralba dopo che rimane ferito in battaglia riesce a tornare a casa, solo che è dimezzato, diviso in due da un colpo di cannone: una metà è smisuratamente buona, l’altra esageratamente malvagia. Potrei fare numerosi altri esempi, ma il punto qui è un altro: Bene e Male coesistono dentro qualsiasi uomo, ed è evidente che nella realtà è assai più difficile che in letteratura trovare individui (interi o a metà) totalmente buoni o cattivi, classificare gli eroi e i malvagi. Ognuno possiede un «cuore di tenebra» nascosto dentro di sé.
Ciò è tanto più vero se ci poniamo di fronte alla strage che ha segnato il Novecento, allo sterminio scientifico e calcolato di milioni di individui portato avanti dalla Germania nazista nei lager di tutta Europa durante la II Guerra Mondiale. Davanti al fenomeno dei lager, le categorie di Bene e Male entrano radicalmente in crisi: un prigioniero che è sopravvissuto grazie al suo ingegno, a scapito degli altri e macchiandosi di colpe gravissime può essere incluso nella schiera dei «buoni»? Può bastare la definizione di «mostri» per gli assassini dei lager, che pure erano convinti di fare il bene della propria patria e del proprio popolo, in una morale rovesciata? O è troppo semplice?
 Primo Levi è di certo un testimone d’eccezione, soprattutto per l’acutezza delle sue riflessioni, valide ben oltre la singola esperienza dei lager. Ne I Sommersi e i Salvati (1986), vera e propria summa del suo pensiero attorno alla strage nazista, Levi approfondisce un tema già trattato in Se questo è un uomo: come ci si poteva salvare? chi era destinato a soccombere? come porsi, moralmente, nei confronti dei lager?
Primo Levi è di certo un testimone d’eccezione, soprattutto per l’acutezza delle sue riflessioni, valide ben oltre la singola esperienza dei lager. Ne I Sommersi e i Salvati (1986), vera e propria summa del suo pensiero attorno alla strage nazista, Levi approfondisce un tema già trattato in Se questo è un uomo: come ci si poteva salvare? chi era destinato a soccombere? come porsi, moralmente, nei confronti dei lager?
Prende così forma la cosiddetta zona grigia, un concetto che l’autore elabora per riempire quello spazio tra Bene e Male che solitamente viene lasciato vuoto nell’immaginario collettivo. Ne fanno parte coloro che per debolezza, bisogno, frustrazione, avidità e indifferenza hanno collaborato con un sistema iniquo e infero oppure hanno taciuto, credendo così di potere ottenere qualche privilegio o di avere salva la vita: in lager, erano i Kapos, i funzionari e tutti i prigionieri in un certo senso «privilegiati»; fuori dai campi, tutti i civili che sapevano e non parlarono, o i grandi industriali che dallo sterminio dei prigionieri ebbero perfino da guadagnare – come i dirigenti della ditta Topf di Wiesbaden, che rifornivano i lager dei forni crematori, e ancora quelli che si servivano della manodopera dei lager o addirittura trasformavano le tonnellate di capelli tagliati alle vittime gasate in manufatti industriali. Va detto che ci sono casi più comprensibili di altri: i prigionieri, spesso, non avevano alcuna scelta e, prostrati, dovevano collaborare.
Nella zona grigia vi è per esempio anche Chaim Rumkowski, un piccolo industriale polacco di religione ebraica che, dopo un passato di fallimenti, riuscì a farsi nominare responsabile del ghetto di Łódź d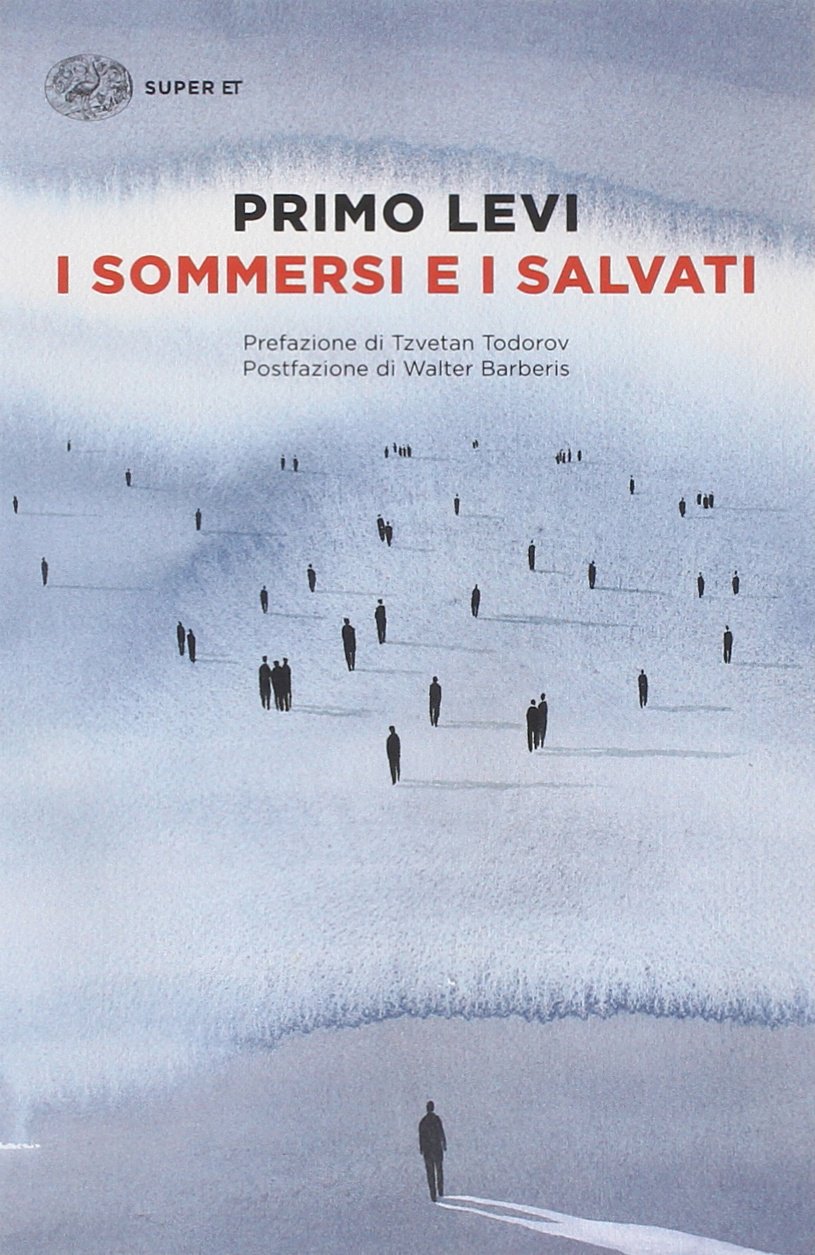 ai nazisti e si comportò come un piccolo monarca fino alla deportazione, collaborando con i tedeschi in cambio del potere assegnatogli e trattando gli altri ebrei come sudditi. Rumkowski aveva un carro trainato da un cavallo scheletrico, una schiera di consiglieri e un corpo di guardia formato da seicento uomini armati di bastone; fece comporre inni in suo onore e tenne discorsi pubblici sullo stile dei grandi dittatori; riuscì persino a far coniare monete con la propria effige. La sua storia è particolare e incredibile: un esempio di quanto potere possa esercitare un sistema tanto forte sulle sue vittime mentalmente più deboli.
ai nazisti e si comportò come un piccolo monarca fino alla deportazione, collaborando con i tedeschi in cambio del potere assegnatogli e trattando gli altri ebrei come sudditi. Rumkowski aveva un carro trainato da un cavallo scheletrico, una schiera di consiglieri e un corpo di guardia formato da seicento uomini armati di bastone; fece comporre inni in suo onore e tenne discorsi pubblici sullo stile dei grandi dittatori; riuscì persino a far coniare monete con la propria effige. La sua storia è particolare e incredibile: un esempio di quanto potere possa esercitare un sistema tanto forte sulle sue vittime mentalmente più deboli.
Un altro caso è particolarmente paralizzante: quello dei Sonderkommandos, «squadre speciali» – e si noti l’ironia del termine – formate da 400-600 prigionieri e preposte all’accompagnamento dei nuovi arrivati alle camere a gas, alla raccolta dei cadaveri e infine alla spoliazione e alla cremazione dei corpi. Trascinati sul fondo di un crimine indicibile, gli uomini dei Sonderkommandos condivisero la colpa dei loro assassini: secondo Levi, è questo il crimine più infame dei nazisti. Dopo due o tre mesi, i componenti di un Sonderkommando venivano eliminati e poi sostituiti, perché non potessero raccontare. Come giudicare questi uomini? Perché accettarono l’incarico? Una razione di pane in più valeva un simile orribile compito? La nostra sensibilità di uomini liberi ci impedisce di comprendere appieno non solo questo caso particolare ma l’intero universo concentrazionario, un mondo dove quasi sempre i confini tra Bene e Male non esistevano più o non erano più contemplati: la necessità di sopravvivere, anche solo per qualche mese di più, era troppo ingente per farsi degli scrupoli. I salvati sono i più forti; i sommersi, i più deboli. La morale muore dinanzi alla realtà. Lo sapeva bene Jean Améry (pseudonimo di Hans Mayer), altro sopravvissuto alla strage nazista, che nel Nazismo e nella Shoah vide il trionfo del nichilismo e il rifiuto di ogni valore etico. Secondo Améry la caratteristica principale del Nazismo fu il sadismo, la tortura: la violenza inutile e gratuita, il desiderio di possedere l’altro in senso totale e di potergli causare impunemente qualsiasi sofferenza.
 Se la testimonianza da parte degli offesi e delle vittime è vitale, lo è anche quella dei carnefici e degli aguzzini. Rudolf Höss, ufficiale delle SS, fu comandante del lager di Auschwitz per più di tre anni, dal Maggio 1940 al Novembre 1943. Arrestato nel 1946 dagli inglesi, fu poi trasferito in Polonia, dove venne condannato a morte dal Tribunale supremo di Varsavia il 2 Aprile 1947 e infine impiccato due settimane dopo, davanti al forno crematorio del campo Auschwitz-I. Durante la prigionia scrisse la propria autobiografia.
Se la testimonianza da parte degli offesi e delle vittime è vitale, lo è anche quella dei carnefici e degli aguzzini. Rudolf Höss, ufficiale delle SS, fu comandante del lager di Auschwitz per più di tre anni, dal Maggio 1940 al Novembre 1943. Arrestato nel 1946 dagli inglesi, fu poi trasferito in Polonia, dove venne condannato a morte dal Tribunale supremo di Varsavia il 2 Aprile 1947 e infine impiccato due settimane dopo, davanti al forno crematorio del campo Auschwitz-I. Durante la prigionia scrisse la propria autobiografia.
Nelle pagine riferite ad Auschwitz, Hoss oscilla tra un sentimentalismo ipocrita e rivoltante, e la descrizione freddamente precisa della costruzione del campo (e qui ci dice quanto è stato difficile, con tutti contro!), e dello sterminio programmato di centinaia di migliaia di persone. Riesce persino a scrivere che le scene che era costretto (si badi, questo verbo non è scelto a caso: Hoss tenta più volte di passare per una vittima) a vedere lo spingevano a vergognarsi e a porsi delle domande, che la vista di tanti bambini, uomini e donne destinati alla morte lo sconvolgeva nel profondo. Dai toni che usa sembra quasi che lui sia stato un attore passivo, una comparsa senza alcun potere nella grande tragedia della soluzione finale: dimentica di dire che era lui stesso a controllare, giorno dopo giorno, che la gasazione dei prigionieri e la loro cremazione avvenissero coi maggiori ritmi (e risparmi) possibili; eppure più e più volte ritorna sulla sua impossibilità a rifiutarsi di eseguire un ordine, sul suo timore nei confronti di Himmler, sul suo senso del dovere. Dice di sentirsi «sollevato» quando il suo sottoposto scopre che il gas Zyklon B (fino ad allora utilizzato per eliminare pidocchi e altri insetti) è una soluzione rapida ed economica per sterminare i prigionieri, ma si permette di condannare le azioni degli internati facenti parte dei Sonderkommandos, da lui considerati dei veri e propri mostri di insensibilità. La sua intera testimonianza è pervasa di omissioni, falsificazioni e invenzioni, nonché di segni evidenti del suo falso pentimento: omette di raccontare della relazione che intrattenne con una prigioniera ebrea (che poi tentò di far sparire) o dei due carri ferroviari stipati di beni sottratti ai prigionieri che portò con sé quando lasciò Auschwitz insieme alla famiglia; e ad un certo punto dice che sterminare gli Ebrei è stato un «errore», perché non ha fatto altro che accrescere il potere giudaico nel mondo. Appare quindi cristallino che molte (o più probabilmente tutte) le parole di sensibilità da lui usate sono una costruzione a posteriori di un senso di colpa che evidentemente non è mai esistito. Quel che più lascia sbigottiti, infine, è la dissociazione schizofrenica che egli opera fra le mostruosità che compie e la sua vita quotidiana: il Male non esiste; c’è solo il Bene: i bambini che lo aspettano a casa per il bagnetto, sua moglie, i suoi cavalli, la sua missione per il Reich. La prima persona a cui mente è se stesso. È uno schema, questo della schizofrenia, ben presente anche nel nostro mondo. Hoss accetta la rappresentazione dell’altro fornitagli da un sistema totalitario e sanguinario, e anzi la fa sua. Gli Ebrei, nonostante vi siano anche altre «categorie» da perseguire, sono i colpevoli per eccellenza: sono i responsabili della sconfitta tedesca nella I Guerra Mondiale, della crisi economica e delle sollevazioni comuniste; sono capitalisti avidi e spietati, esseri impuri da eliminare prima che possano infettare il sangue tedesco, maestri dell’inganno e della truffa; stanno cospirando per sottomettere tutto il mondo. Anche così si entra a far parte di un «gruppo» di cui poi bisogna fare il “bene”, e ad ogni costo: l’individuo si annulla nella collettività, credendo così di poter delegare ad altri la responsabilità delle proprie azioni.
Come dice bene Primo Levi:
Questa autobiografia del Comandante di Auschwitz è uno dei libri più istruttivi che mai siano stati pubblicati, perché descrive con precisione un itinerario umano che è, a suo modo, esemplare: in un clima diverso da quello in cui gli è toccato crescere, secondo ogni previsione sarebbe diventato un grigio funzionario qualunque, ligio alla disciplina ed amante dell’ordine. […] Höss non era un mostro, né lo è diventato, neppure al culmine della sua carriera quando per suo ordine si uccidevano ad Auschwitz migliaia di innocenti ogni giorno. […] È stato uno dei massimi criminali mai esistiti, ma non era fatto di una sostanza diversa da quella di qualsiasi altro borghese di qualsiasi altro paese; la sua colpa, non scritta nel suo patrimonio genetico né nel suo esser nato tedesco, sta tutta nel non aver saputo resistere alla pressione che un ambiente violento aveva esercitato su di lui, già prima della salita di Hitler al potere.
Dalla banalità alla malvagità: un Male più inquietante di questo, forse, non c’è. E se alcune cose possono essere spiegate, altri nodi rimangono invece impossibili da sciogliere.
Lo affermiamo con forza, un «Bene» ed un «Male» esistono: negarlo significherebbe fare un favore a tutti quei malvagi che (come Höss a suo tempo) cercano una giustificazione ai loro crimini. Nostro compito è non perdere mai di vista queste categorie etiche, non piegarci ad allettanti soluzioni e auto-assoluzioni. La domanda che dobbiamo porci dunque è questa: ci conosciamo davvero? Con quale sicurezza possiamo affermare che avremmo agito in un certo modo o magari in un altro? Quali mostruosità potrebbero annidarsi nel nostro cuore, pronte a saltare fuori in determinate circostanze? Siamo vittime o carnefici? Chi siamo?