Inventariarsi: “Diario d’inverno” di Paul Auster
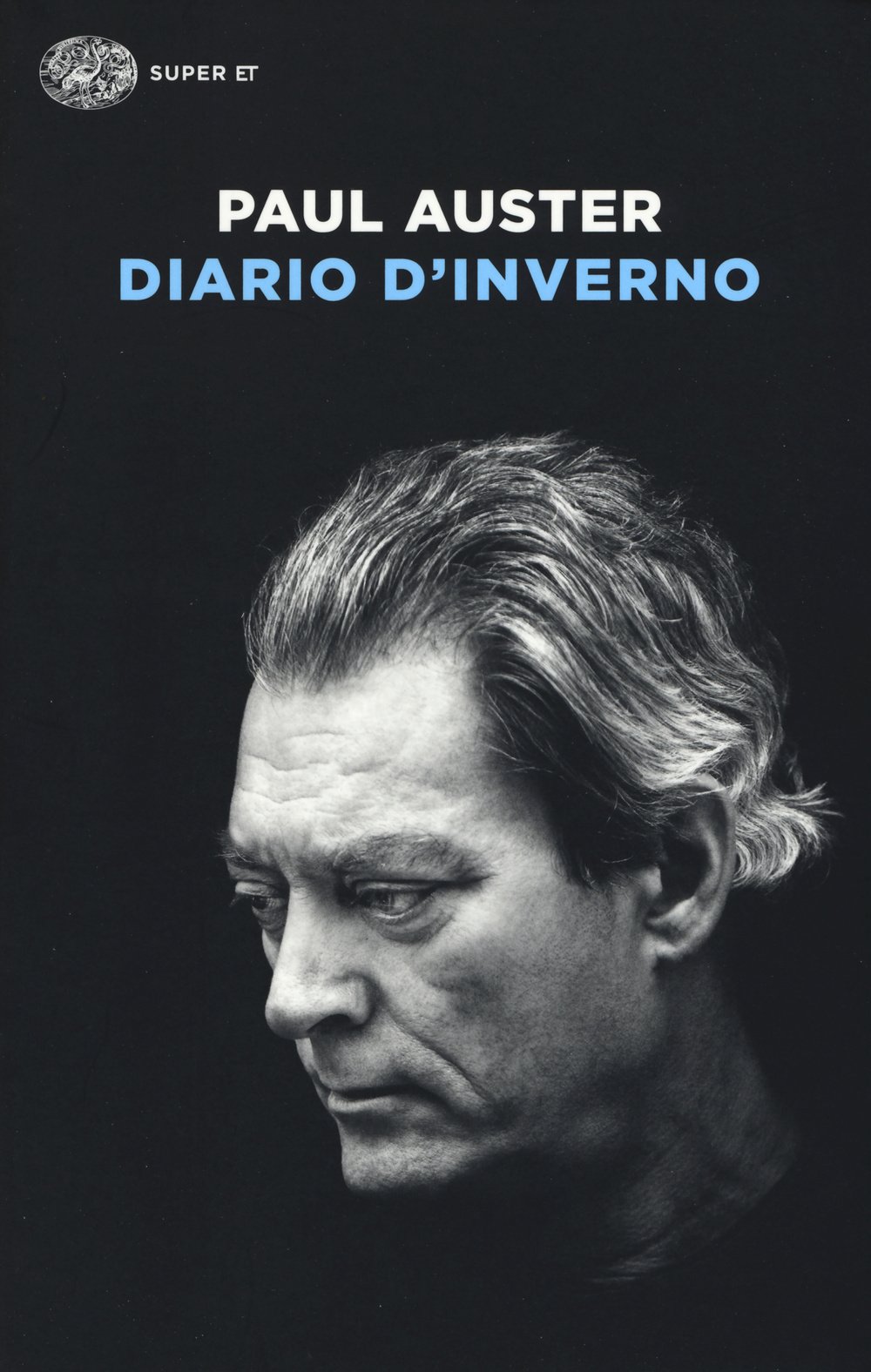
La domanda dalla quale partire è: cosa ti aspetti, quando decidi di leggere un’autobiografia? Dipende. Non leggo autobiografie di uomini che ce l’hanno fatta, non so che cosa si provi, se veramente siano libri in grado di dare una scossa per uscire dal torpore della vita di tutti i giorni. Ma dall’autobiografia di uno scrittore da me amatissimo mi aspettavo onestà, nessuna remora a sviscerare il proprio essere, una capacità sopra le righe di guardarsi dentro, ma anche di leggere il proprio corpo come mero involucro, di ripercorrere a ritroso una crescita di uomo e di scrittore con grande lucidità.
Da Paul Auster, che per quanto affermato, famoso, è pur sempre un autore piantato nel New Jersey, non mi aspetto nulla di eroico. Fareste bene anche voi a non farlo. E comunque, di eroismo, non ce n’è.
C’è invece la sola intenzione di essere sincero con se stesso, prima che con il lettore, ed è per questo che per tutto il libro martella il tu, un lungo, lunghissimo dialogo tra Paul e l’altro Paul. Sincero anche quando normalmente non lo si vorrebbe essere, comunque: non nasconde nulla e, sì, anche gli scrittori si sturano le orecchie con il mignolo. Tutto il libro si regge su un precario equilibrio tra stile elevatissimo, un’eleganza innata delle parole di Paul Auster e scivolate nel mondo del corporeo che però sono la vita vera.
Diario d’inverno mi immagino che nasca con la volontà di inventariare, catalogare tre stagioni della vita prima di entrare nell’ultima. Fa un giro gigante, abbraccia più di sessant’anni di vita, solo per mettere ordine e raccontare da dove viene Paul Auster, non tanto per dire dove sta andando.
Viene da dire che anche questo libro sia un romanzo, non tanto un memoir: Auster non rinuncia a fare il narratore, in questo dialogo sfrontato con sé stesso. Come inizia, così il diario finisce, ma non si segue una linea continua. Si procede per aree tematiche, ogni paragrafo prende le mosse da quello precedente, ed è la vita a trecentosessanta gradi: il cibo che ha ingurgitato in sessant’anni – tutte le merendine che avrebbero dovuto farlo ingrassare e invece no –, le case nelle quali ha abitato, ha vissuto, ha passato anche solo pochissimo tempo, “l’inventario delle cicatrici”, passando per il rapporto con la morte, grandissimo tema che attraverso come un filo rosso tutto il diario, sempre sereno ma mai risolto.
C’è un aneddoto nel libro, anche dovesse non essere vero, che dà un po’ la chiave di lettura di tutte le centottanta pagine (pochissime, ma davvero, davvero dense): James Joyce, a Parigi, lì in piedi a una festa fino a che una donna gli si avvicinò e gli chiese se poteva stringere la mano che aveva scritto l’Ulisse. E lui le rispose che la sua mano aveva fatto anche molte altre cose.
Con gli scrittori che amiamo molto il pericolo è questo. Mitizzarli, allontanarli dalla vita reale, immaginarli solo nelle circostanze in cui a noi è dato conoscerli: nell’atto creativo, insomma, intenti a darci le pagine per le quali noi smaniamo, e al di fuori di quelle pagine, di quella stesura, non possono essere nessuno.
La mano di Paul Auster è, sì, quella che tiene la stilografica nera con la quale scarabocchia le parole di Diario d’inverno, ma è anche quella mano destra che apre le porte, compone numeri telefonici, apre scatole di tè, accende luci, spegne luci, si pulisce il sedere, anche. Non c’è niente a separare la sua esistenza dalla mia, la rivelazione dell’inverno della sua vita è questa.
“Starnutire e ridere, sbadigliare e piangere, ruttare e tossire, grattarti le orecchie, stropicciarti gli occhi, soffiarti il naso, schiarirti la gola, succhiarti le labbra, far passare la lingua dietro i denti inferiori”: quante volte hai fatto queste cose?
Quando lessi Storia di un corpo (Pennac), rimasi entusiasta di fronte all’idea di tenere un diario accuratissimo solo delle sensazioni corporee. Di fronte all’idea, meno davanti alla realizzazione, ma adesso capisco che stavo aspettando qualcuno come Paul Auster: qualcuno mitizzato, poi avvicinato miracolosamente e adesso ancora più fortemente stimato. La differenza sta nel diverso livello sul quale si pongono le riflessioni. Per Paul Auster è un avere coscienza della propria corporeità attraverso le tappe salienti della vita, per Pennac una divagazione sulle fasi della prestanza di un corpo non reale, e quindi lontano.
Detto questo, Diario d’inverno (Einaudi, 2012) può risultare ombelicale, ossessivo. Come a volte viene rimproverato anche a Philip Roth, i libri di Paul Auster spesso ricalcano la stessa trama, contengono tanto dell’autore, che incombe su di essi come un tiranno. Non li avvicinerei, non basta essere del New Jersey ed entrambi ebrei per risultare affini (nel rapporto con le donne sono agli antipodi: le pagine che Auster dedica alla moglie sono a mio avviso tra le più belle della letteratura americana), ma c’è qualcosa nel loro continuo analizzare e analizzarsi nella propria produzione che ha dello straziante e del convincente. Non è interessante leggere pagine di elenco delle case nelle quali Paul Auster ha vissuto, forse, se lo si fa con l’intento enciclopedico dell’inventario a tutti i costi. Ma il corpo è l’involucro che ci sostiene nel cammino intrapreso e nello spazio che si è attraversato, che ci ha dato da mangiare, da bere, il corpo nel quale ci siamo formati (quello della madre), che ci fa sentire il dolore, ma anche il piacere, e quanti piaceri diversi. Letto così, ha senso sapere di tutte le venti e passa abitazioni che hanno ospitato i suoi centimetri e i suoi chili.
Io non lo so se sia così per tutti, se per tutti ci sia un frangente nel quale si sente il bisogno di guardarsi indietro e trovare un senso, catalogare quello che si è stati e quello che ci ha portato ad esserlo, ma nel 2011 per Paul Auster era così. Il suo lavoro è certosino, certo, più analitico forse di quanto possa esserlo quello di chiunque altro, ma doveva essere fatto e doveva essere fatto così, per poter andare avanti senza che nulla sia stato rivisto e riletto alla luce obliqua di una consapevolezza nuova. Questo è Diario d’inverno. Si chiude una porta e un’altra si apre.