Attraverso i linguaggi della cura: “Ombra mai più” di Stefano Redaelli
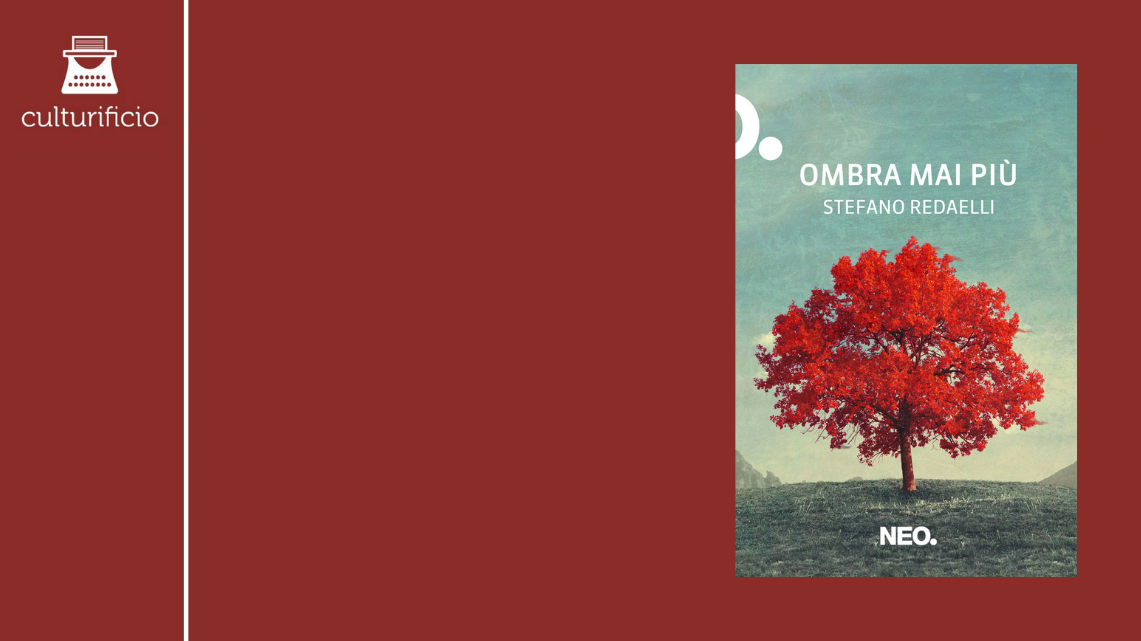
«Ma non avete scritto tutto. Manca l’altra metà della verità».
«Quale sarebbe?»
«Che il mondo, al contrario, è socialmente pericoloso. Costituisce un pericolo costante per quelli come me: le colombe, i cerbiatti, i folli. Lei questo non me l’ha detto, non lo ha messo per iscritto. Doveva passare agli atti. Come una deposizione, una denuncia. Capisce quale grave omissione?»
Non so dove ho trovato le parole, ma ho usato quelle giuste.
Angelantonio Poloni, protagonista di Ombra mai più (Neo Edizioni), secondo romanzo di Stefano Redaelli, è appena uscito da «lì», il luogo riferibile solo in astratto e richiamante un passato ingombrante, che non riesce a essere confinato in una cronologia conclusa. Quel «lì» è la Casa delle Farfalle, il Centro di Riabilitazione Psichiatrica in cui si svolge il peculiare percorso attraverso la follia di Beati gli inquieti, il primo capitolo del racconto dell’ex paziente.
I due romanzi sembrano dialogare e far parte di un progetto coerente, a partire dalla loro precisa geometria, esplicitata dallo stesso paratesto e dalla suddivisione in capitoli (tre macro-sequenze, un prologo, un epilogo), fino a quel “diario” della permanenza alla Casa delle Farfalle, fulcro anche di questa nuova storia, che ora Angelantonio sente la necessità di far pubblicare e che costringe a volgere lo sguardo costantemente indietro. Convergenze, queste, che non premettono però a una narrazione speculare o a una lettura necessariamente vincolata.
Se Beati gli inquieti è il tempo frammentato del ricovero, del linguaggio della follia e di una Guida alla creatività per geni, che rimane intrisa della sua cifra veritiera e da interpretare, Ombra mai più è il “dopo” della malattia, il “fuori” dalle mura, e si svolge in un tempo lineare, da ritrovare insieme ad Angelantonio, l’“impaziente psichiatrico”. Un’impazienza, la sua, propria di chi per anni il tempo lo ha vissuto in modo individuale e in confini spaziali limitati.
Il recupero del contatto con la società fuori dalla Casa delle Farfalle avviene all’insegna della cura, imparata dal lettore insieme ad Angelantonio: è questo il tentativo, non senza battute d’arresto, per un ritorno nel mondo. Il protagonista ci rende partecipi della sua (ri)scoperta dei contorni delle figure familiari, un tempo note, ora da tracciare con occhi nuovi, e il suo percorso è un’incessante ricerca dell’equilibrio tra vecchie e nuove dimensioni, misurate grazie al corretto uso delle parole, nel dialogo con gli altri e con sé stesso. A partire dalle descrizioni tramite elenchi, tipiche di Angelantonio, che il lettore impara subito ad accogliere, e che divengono uno dei modi di riprendere possesso della contingenza, la voce narrante inizia un’accurata analisi sulla possibilità e sul modo più preciso di giustificare, tramite il linguaggio, l’eccezionale storia di cui è testimone.
Tra riflessioni “tridimensionali” e una spiritualità personale, in questa nuova educazione all’altro, la cura è quella da e verso il padre e la madre, sui quali il tempo ha mostrato la sua implacabilità, da e verso Marta, Angelo, la dottoressa, il barista Claudio, e ora anche Rami, lo “scuro”, un bambino egiziano membro di una banda di teppisti che parla il gergo dei “grossi”, parte di una comunità con cui Angelantonio dovrà confrontarsi.
Mentre assistiamo alla costruzione di un contatto reciproco con Rami, anche grazie a un costruttivo scambio lessicale, facciamo lo stesso per la consapevolezza verso l’altro snodo del testo, via via sempre più complesso: il rapporto del protagonista con la scrittura, nel suo nuovo valore sociale (il romanzo già scritto) e progettuale (il romanzo da scrivere), che assume infine i contorni stessi di Marta, faro dell’affannosa ricerca. Da mezzo di guarigione a «mostro famelico», la scrittura, quindi la letteratura e il loro rapporto con questa inedita dimensione della “dedizione” sono le colonne portanti intorno alle quali si sviluppa la storia di Angelantonio, che a un tratto osserviamo nel ripensamento di tutta la sua operazione di “scrittore-paziente” (o “paziente-scrittore”): «Sono tornato al dubbio di prima: ho scritto un romanzo o una cartella clinica letteraria? Ho scritto un romanzo. Basta. Assodiamolo una volta per tutte».
A volte penso – devo essere onesto – di aver scritto qualche pagina ispirata. Altre mi pare che nel complesso sia tutto troppo… non so come spiegare: terapeutico? Scritto per un fine (più che per una necessità)? Nell’ambito di una cura? Sotto prescrizione medica? Che sia stato utile scriverlo è certo: utile per me (anche per gli altri pazienti, sostiene la dottoressa). Ma è proprio questa utilità che rimanda a un piano altro da quello puramente letterario. Non lo so. Forse non si dovrebbe scrivere solo perché qualcuno (tanto più se si tratta del tuo psichiatra) ha detto che ti fa bene.
Su questo orizzonte di riflessione (e di studio, per Redaelli), le nuove concezioni di tempo e comunicazione si muovono sotto l’ombra di un platano amico d’infanzia, idealmente il cuore propulsore della vicenda di Angelantonio e il centro spaziale del romanzo. Su questa relazione si intraprenderà la via piena di insidie di un ritorno a una “sanità” che continua a rapportarsi con la follia solo per opposizioni. Le radici del platano, come le rughe della madre (una “madre-bonsai”), non possono più dare vita all’ombra rassicurante di un tempo, quel riparo la cui complessità, fatta allo stesso modo di malattia e guarigione, di caduta e di nido, deve essere condiviso anche con tutti gli altri, una società che sembra invece insistere su una comprensione piatta e polarizzata di “quelli” come Angelantonio.
Tra le sempre più numerose e consapevoli storie che riguardano o lambiscono la malattia e l’assistenza psichiatrica, sulla scia dei primi, grandi testimoni del Novecento come Mario Tobino, la narrazione di Stefano Redaelli emerge per guardare alla questione in modo organico, coinvolgendo numerosi volti di cui si compone la “guarigione” e mettendo in grado il lettore di leggerle nella loro profondità.
Attraverso una prosa limpida e un’orchestrazione narrativa precisa, a quasi quarantacinque anni dalla legge Basaglia Redaelli pone dunque, una fitta rete di questioni su cui riflettere, chiamate con i loro nomi, indispensabili per “dire” la malattia e l’universo complesso, spesso maldestramente metaforizzato e generalizzato, dei problemi irrisolti che vi ruotano intorno. Le direzioni intraprese dal romanzo aprono a ombre il cui spessore ci chiede di essere indagato a partire dalla conoscenza del loro linguaggio.
di Matilde Cioni