I popcorn di Shakespeare
le opere del Bardo nella storia del cinema
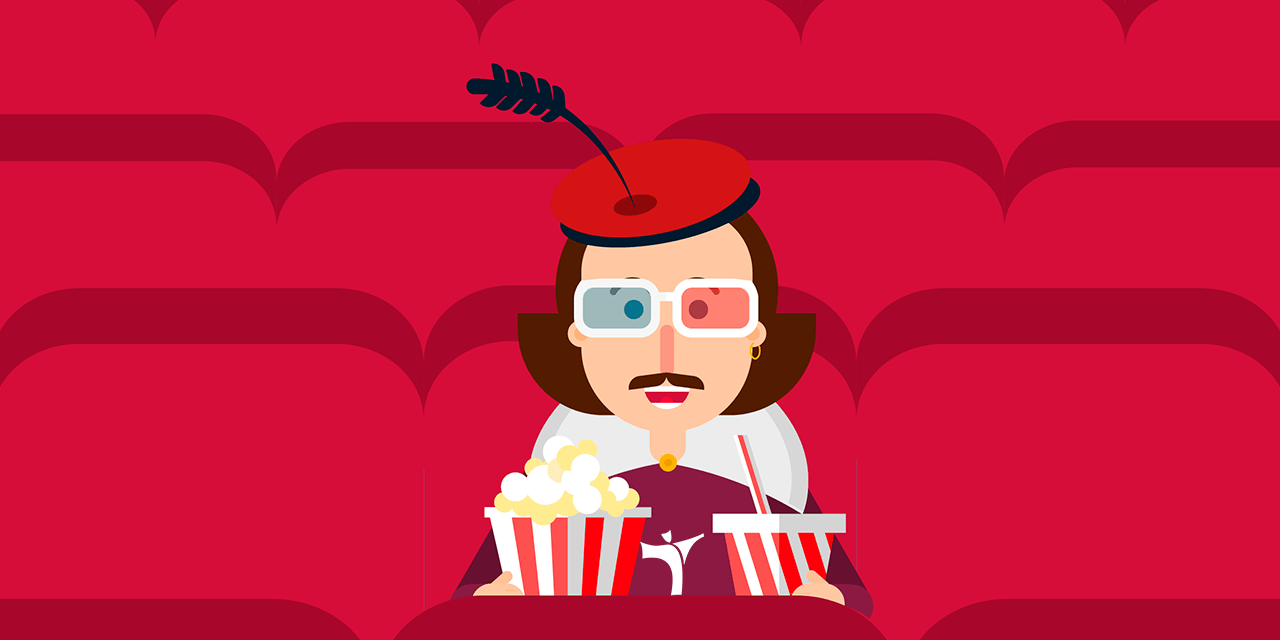
L’odore del popcorn, le luci che si spengono, il chiacchiericcio pieno di speranze, lo spettatore che si è appena accomodato al posto davanti e che è sempre, categoricamente, più alto.
Immagini note, pezzi di quotidianità che costellano la vita di tutti noi da quando la settima arte, il cinema, è diventata una delle voci più influenti della cultura odierna.
A conferirgli questo appellativo – a tratti fascinoso, a tratti ambiguo – fu Ricciotto Canudo, nel lontano 1921, con la pubblicazione del manifesto La settima arte.
Perché settima? È presto detto: per Canudo il cinema era l’astro nascente delle arti, fusione finita di ognuna di esse, la pittura, la scultura, la musica, il teatro. Proprio quel teatro, mondo fatto di belletto e sipario, di copione e improvvisazione che, del cinema, pare essere alleato carnefice.
Pensare al teatro vuol dire pensare, quasi immediatamente, a William Shakespeare. Forse perché le tragedie e le commedie del Bardo di Stratford-upon-Avon risultano essere, ad oggi, ancora le più rappresentate, oppure perché si prestano con infinita malleabilità a riletture e riscritture, o probabilmente perché ci basta rivolgerci alla folla e pronunciare “Essere o non essere?” per sentirci automaticamente rispondere “Questo è il problema”.
La fama di Shakespeare, insomma, è incontrovertibilmente legata al teatro ed al teatro, come si sa, è legato il cinema e la sua genesi.
L’opera omnia shakespeariana ha giocato sempre con una moltitudine di espressioni artistiche, dalla pittura alla musica, fino alla scultura e al balletto. Era, dunque, cosa annunciata che il Bardo approdasse tra i sedili numerati e polverosi e lasciasse le sue trame, ora tragiche, ora giocose, tra le mani di un ventaglio di registi che, col procedere del tempo, si è allargato sempre più.
Se esiste una linea di demarcazione tra l’arte alta e quella bassa, popolare, il cinema rischia certamente di debordare nella seconda, almeno seguendo il giudizio di una moltitudine di autori. Fortunatamente non è d’accordo Romàn Jakobsòn che, con il saggio del 1933 La fine del cinema? prende le difese del nascente cinema sonoro, contro ogni possibile detrattore.
In un mondo che sta vedendo il sorpasso di capolavori muti, infiniti e immortali, come quelli di Fritz Lang e Robert Wiene, sentire la voce degli attori pare quasi un affronto. Eppure anche questa è, agli occhi e alle orecchie di Jakobsòn, parte fondante della comunicazione. La personale battaglia del linguista russo è visibilmente incarnata dalla produzione su pellicola che ha fatto in modo che il Bardo si accomodasse, imbracciasse i suoi popcorn e si gustasse, come noi, i lavori di scrittura e riscrittura che la sua Opera ha ispirato.
Quale Shakespeare? Domandare è lecito.
Le rappresentazioni cinematografiche dell’Opera del Bardo non mancano mai di stridore, violenza, abbondanza di armi, non manca mai neppure la mollezza, l’amore deteologizzato e carnale, i banchetti e i giullari. Un’azione serrata e potente, almeno quanto lo sono i dialoghi (Jan Kott, Shakespeare nostro contemporaneo, Feltrinelli Editore, Milano 2002, p. 239), elemento linguistico che si fa garante della riuscita o meno di una pellicola shakespeariana.
Quale Shakespeare, dunque? La fedele messinscena o la reinterpretazione ardimentosa?
Non mancano esempi validi, che si parli del primo o del secondo tipo.
L’inevitabile trampolino di lancio è riscontabile nel sontuoso cinema di Franco Zeffirelli che, nel 1968, porta in scena uno dei migliori Romeo e Giulietta che la storia del cinema ricordi. Merito della colonna sonora, curata da un eccezionale Nino Rota, e dell’età dei protagonisti scelti per interpretare i giovani e sventurati amanti: Leonard Whiting e Olivia Hussey avevano, all’epoca delle riprese, un’età molto vicina a quella dei fanciulli immaginati dal Bardo, ossia diciassette e sedici anni. Scelti tra una moltitudine di aspiranti, hanno contribuito ad elevare qualitativamente una pellicola che, ancora oggi, si erge in rappresentanza del genere e non manca di emozionare anche i giovani spettatori, abituati ad esempi di love story ben diversi da quello proposto da Zeffirelli.
Nel 1996 la medesima tragedia è stata fiduciosamente rimaneggiata da Baz Lhurmann. La trasposizione cinematografica del registra australiano, candidata al Premio Oscar per la miglior scenografia, è una temeraria rilettura della sfortunata sorte dei due amanti e come tale va a affrontata. Non ci si può, infatti, immaginare fedeltà eccessiva al testo primigenio, quanto un attaccamento ben riuscito al canovaccio, ben seguito e argomentato con espedienti in grado di caricare di modernità e freschezza una storia che non ha mai mancato di far, letteralmente, innamorare.
Un esempio? Ovviamente non ci sono armi bianche e se questo da un certo punto di vista potrebbe privare di fascino lo svolgimento, dall’altro lo rende perfettamente in armonia con l’idea postmodernista di Lhurmann. Romeo Montecchi, stando così le cose, non si uccide con una pugnalata ma si spara alla tempia. È meno eroico? Forse non ha la stessa presa della versione classica ma, è lecito pensare, che riadattamento sarebbe, altrimenti?
Lasciando al canto la fortunata/sfortunata tragedia di Romeo e Giulietta, ripresa in tutte le salse e tutti i media possibili, finanche alla musica dei Dire Straits e alla serie animata in ventiquattro puntate dello studio Gonzo, Shakespeare avrebbe di che gioire se sapesse la portata del lascito delle sue opere, anche quelle tradizionalmente discosti dal successo e considerate per lo più di nicchia.
Certo, è difficile parlare di “opere minori” quando si ha a che fare con autori del calibro del Bardo, sarebbe meglio parlare di indici di gradimento senza, per questo, voler commisurare la fortuna delle opere al numero di trasposizioni transmediali. Tuttavia, se decidessimo di abbracciare questa tesi non ci sarebbe difficile imbatterci in Cimbelino. Dalla trama intricata quanto basta per non essere agilmente compresa dai più, sfiorato dalla critica in maniera per lo più superficiale, il romanzo – così com’è stato classificato – vanta anch’esso una trasposizione cinematografica, per di più presentata durante la 71^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Anche in questo caso la chiave di lettura è postmoderna eppure discoste dall’idea di Lhurmann: la regia di Michael Almereyda è cupa e ben si adatta alla natura dell’opera, violenta e appassionata. Senz’altro difficile, per coloro che guardano il film senza conoscere l’antefatto shakespeariano, immaginarne le radici seicentesche.
Ben diversa è, invece, la sorte di Otello. Tragedia dell’amore e della gelosia per antonomasia, la storia che ha per protagonista il moro di Venezia e la sua bella Desdemona, ingiustamente accusata di tradimento, si è duttilmente prestata alle versioni cinematografiche più disparate.
Dall’ambientazione di All night long (1961) che si sposta nella Londra anni Sessanta, per la regia di Basil Dearden, sino al dramma razziale vissuto da Odin, sventurato Otello dei giorni nostri, nella versione statunitense di O come Otello diretta da Tim Blake Nelson, concludendo con un titolo tutto italiano, Iago. Nel 2009, infatti, Volfango De Biasi dirige una scarna trasposizione dell’opera shakespeariana, lo fa tentando il gran salto del rimaneggiamento: nella pellicola l’antagonista veste i panni del protagonista e viceversa, lo sventurato Otello è qui uno studente francese bennato e manipolatore laddove Iago, storicamente perfido e bugiardo, impersona un aspirante architetto di belle speranze. Forse le idee c’erano, la critica e la maggioranza degli spettatori non le hanno notate e non hanno mancato di stroncare la pellicola.
Di diversa concezione è la trasposizione, o meglio le trasposizioni, di Macbeth.
Tra le migliori, e contestualmente di più difficile comprensione, rientra senz’altro quella di Orson Welles, datata 1948. Che il regista e drammaturgo statunitense fosse un amante appassionato dell’opera omnia shakespeariana non è un segreto, Welles era fermamente convinto che le tragedie del Bardo di Stratfor-upon-Avon fossero molto di più, era certo che fossero da considerarsi come veri e propri melodrammi (Fabio Fulfaro, The other side of genius. Il cinema di Orson Welles, goWare Editore, Firenze 2017, p. 40). Il Macbeth di Welles risulta complesso, sfolgorante e primitivo, eppure fumoso, talmente tanto da aver costretto lo stesso regista all’inserimento di una voce fuori campo atta a fornire le debite spiegazioni.
Lungi dall’essere poco frequentata, la tragedia di Macbeth è stata ripresa negli ultimi anni dalla regia d’azione di Justin Kurzel.
Coinvolgendo i patinati Michael Fassbender e Marion Cotillard, Kurzel presenta al Festival di Cannes del 2015 un Macbeth dai contorni cremisi, rabbiosi e drammatici come nella migliore tradizione.
Ciclicamente, pare, il cinema ritorna ad amare e praticare le trasposizioni fedeli all’opera originale. Per la felicità degli appassionati e, perché no, per avvicinare i praticanti più accaniti del popcorn ai testi d’autore.
Se Henry Jenkins era fermamente convinto dell’importanza della collaborazione tra media differenti (Henry Jenkins, Cultura convergente, Maggioli Editore, Rimini 2014, XXV) e di un intero universo in grado di staccarsi dalla carta stampata e di viaggiare, espandersi, evolvere in una moltitudine di rappresentazioni fruibili ad un pubblico variegato, è altresì vero che il cinema rappresenta il mezzo di approccio privilegiato per coloro che, per una ragione o per l’altra, ai libri sono poco avvezzi.
Lungi dal prendere troppo le distanze dall’opera primigenia, la pellicola ha il potere di raggiungere una moltitudine di donne e di uomini con esperienze e bagagli culturali diversi e, magari, di spingerli a chiedersi: da dove deriva tutto ciò? Di lì al reperire il testo originario il passo si fa davvero breve, quel tanto che basta a spronare la critica a far leva sul cinema, anziché bocciarlo come “scorciatoia”.
È chiaro che un film non potrà mai sostituirsi al libro – e non deve farlo – ha tutt’al più il compito di farsi da tramite, di avvicinare lo spettatore alle pagine e al loro profumo.
Per questo Shakespeare, ben lontano dall’essere immobile cerae effigies, è ancora seduto tra di noi spettatori, con i suoi popcorn e magari, perché no, con un paio fiammante di occhiali 3D.
L’immagine in evidenza proviene da: https://www.teatropertutti.it/2018/06/13/shakespeare-film/