“Monster”, la ricerca della propria storia e della propria verità attraverso il cinema
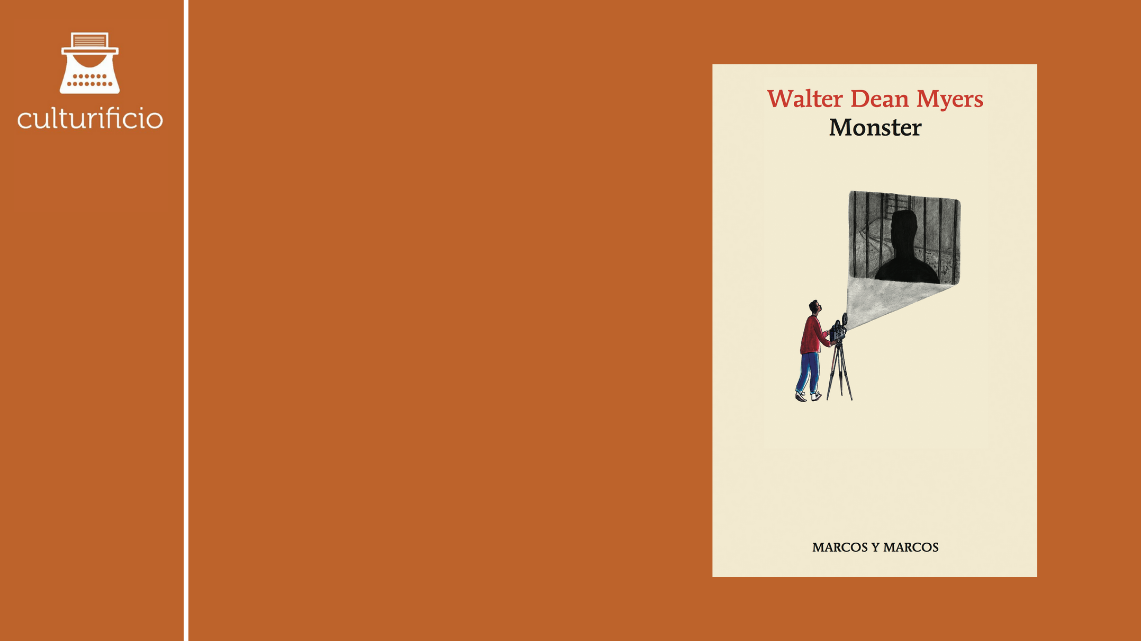
Metà dei giurati, malgrado quello che hanno detto quando li abbiamo interrogati nella fase di selezione, ha creduto che tu fossi colpevole nel momento in cui ha posato gli occhi su di te. Sei giovane, sei nero, e sei sotto processo. Che altro hanno bisogno di sapere?
Pubblicato alla fine degli anni Novanta, dopo una trasposizione a fumetti, Monster, romanzo di Walter Dean Myers (marcos y marcos, traduzione di Paolo Ippedico), è diventato anche un film, presentato in anteprima al Sundance del 2018 e adesso disponibile su Netflix.
L’adattamento diretto da Anthony Mandler sembra la sua naturale evoluzione, dato che Myers, prolifico autore di libri per ragazzi, ha scritto l’opera sotto forma di sceneggiatura, con indicazioni sui movimenti di macchina e sulle inquadrature, utilizzando la struttura dei dialoghi tipica dei copioni cinematografici. A intervallare alcune pagine di riflessioni, in cui il giovane protagonista dà libero sfogo ai suoi pensieri, alle sue sensazioni e soprattutto alle sue paure.
Si tratta di Steve, aspirante videomaker la cui vita viene sconvolta dall’accusa di aver preso parte a una rapina finita in omicidio. In quel momento oltre che della libertà, il ragazzo si sente privato della propria identità. I suoi genitori sembrano guardarlo in modo diverso e nemmeno lui sa più chi è. Per la giuria invece è l’ennesimo afroamericano che ha commesso un crimine, nulla di più.
Agli occhi degli altri la sua è una pellicola in bianco e nero; da una parte i buoni, dall’altra i cattivi. Steve però decide di mostrarci le sue sfumature immaginando la storia come se fosse un film, che intitola con il nome utilizzato dall’accusa per attaccarlo: mostro.
Per la maggior parte del romanzo rivive la propria vita da spettatore, parlando di sé in terza persona. In questi momenti lascia che siano la storia e i personaggi a raccontarsi, attraverso le deposizioni in tribunale o descrizioni minuziose e distaccate. A questi momenti si alternano alcune pagine redatte sotto forma di diario in cui invece Steve riprende in mano la narrazione mostrando non più cosa si vede dall’esterno, ma quello che prova e che non può rivelare per non apparire debole in prigione.
Come se fosse davvero un manoscritto, nel testo sono presenti anche alcune note a margine e con un font diverso, così da riprodurre una sorta di commento fatto dal giovane autore mentre sta raccontando la sua storia. Si tratta di brevi frasi o parole che sottolineano il suo stato d’animo e servono a fissare pensieri che gli ritornano alla mente, interrogativi che rivolge a sé stesso, a volte amari rimpianti. Nella pellicola è la voce fuori campo del protagonista a illustrare gli eventi. Le fasi del processo si intrecciano a numerosi flashback, scene in famiglia e a scuola, ma anche l’incontro con coloro che hanno commesso il furto.
Sia nella trasposizione cinematografica che nel romanzo il passato irrompe in maniera quasi brusca durante il processo, interrompendo il racconto per tornare indietro e mostrare alcuni personaggi fuori dal tribunale, sotto una luce diversa. Si tratta di piccoli squarci nella narrazione, a volte anche molto brevi, ma che se uniti e confrontati al presente possono offrire una panoramica più ampia, seppur non esaustiva, delle vicende.
Nel film questo contrasto viene esaltato dalla fotografia: quella relativa al presente è fredda, il bianco, il nero e il grigio caratterizzano il tribunale e la prigione – a eccezione dell’arancione delle divise carcerarie –, mentre quella legata ai ricordi del passato è calda e dalle tinte più sgargianti. La varietà cromatica della vita prima del carcere si contrappone al dopo, in cui tutto sembra essersi appiattito a due soli colori.
La spensieratezza delle serate trascorse con gli amici e la fidanzata, una famiglia benestante e la passione per la settima arte: l’immagine di una vita tranquilla viene offuscata quando Steve comincia a fare amicizia con tipi poco raccomandabili.
Il motivo di questo avvicinamento è legato proprio al corso di cinema che frequenta. Durante una delle lezioni, infatti, il professore gli dice di trovare qualcosa da raccontare e così comincia a cercarlo nel proprio quartiere, fotografando e filmando attimi di quotidianità.
Non avrebbe mai immaginato però che alla fine la sua storia sarebbe diventata quella di un ragazzo di diciassette anni in attesa che il verdetto di una giura decida come trascorrerà i prossimi anni della sua vita: coltivando il suo sogno di diventare regista o tra le mura di una prigione.
Scrivere una sceneggiatura gli serve, prima di tutto, per capire cosa lo ha portato in quell’aula di tribunale. Nei flashback viene spesso mostrato mentre è alla ricerca dell’angolazione e della luce giusta per cogliere la realtà che lo circonda. Adesso deve imparare a farlo anche con sé stesso.
Il film si compone come un mosaico, tanti scatti, pezzi della vita di Steve, che vanno messi insieme per avere un’immagine completa, ma che non restituisce necessariamente qualcosa di armonico.
Riscrivere la propria storia gli permette di estraniarsi da sé stesso, provando a guardare le cose in maniera distaccata e comprendere come lo percepiscono gli altri.
A volte mi sembra di essere finito nel bel mezzo di un film […]. Ne ho visti di film sulle prigioni, ma nessuno come questo. Questo non è un film su sbarre e porte chiuse. È un film sull’essere solo quando non sei davvero solo e sull’avere paura tutto il tempo.
Nel cinema Steve trova uno strumento per affrontare una situazione a cui sente di non appartenere, come se stesse vivendo dentro un incubo e quella non fosse la sua vera vita, forse rovinata per sempre da una scelta fatta in pochi secondi.
Il procuratore però cerca di utilizzare la sua passione come arma contro di lui e lo accusa di inventarsi una storia anche in tribunale, per dipingersi in maniera diversa da come è realmente, puntando sull’empatia e non su fatti veri, proprio come in un film.
Una differenza dell’adattamento rispetto al libro è che l’opera originale lascia il dubbio sul fatto che il protagonista abbia commesso il crimine, facendo da palo per la rapina. La pellicola invece decide negli ultimi minuti, dopo che il processo si è già concluso, di svelare la verità.
Nella sua diversità questa scelta narrativa in realtà sottolinea che ciò che interessa veramente, sia nella versione letteraria che cinematografica, non è indagare il rapporto tra Steve e la sua colpevolezza, ma mostrare che non può essere ridotto a quello che si dice di lui in tribunale o al suo ruolo durante il crimine.
L’esordio alla regia di un lungometraggio di Anthony Mandler, contando su un testo di partenza dallo stile particolare, avrebbe potuto puntare alla ricerca di un approccio altrettanto originale nella trasposizione, che in parte manca: la trasposizione non risulta infatti particolarmente incisiva, anche a causa di alcune scene in tribunale che ricordano qualcosa di già visto e di certi messaggi troppo ripetuti. Si tratta di un buon film, che però non emerge abbastanza rispetto ad altri dello stesso genere.
Nel cast è presente in un ruolo minore l’attore Jharrel Jerome, protagonista della serie tv When They See Us (2019), che affrontava una tematica simile raccontando la storia di quattro ragazzi neri e uno ispanico: per l’immaginario collettivo considerati colpevoli di un crimine prima ancora della sentenza.
Anche se il razzismo riveste sicuramente una certa importanza, quello su cui Monster si concentra maggiormente è la ricerca della verità. Ognuno cerca la propria, l’idea di obiettività sembra fuggire e tutto diventa questione di punti di vista.
Quando la sentenza è stata emessa, i dubbi su chi sia Steve restano. Non è detto che tutti rispondano allo stesso modo alla domanda finale che la voce narrante pone rivolgendosi direttamente allo spettatore, mentre una luce accecante riempie lo schermo prima che diventi nero:
Ragazzo, uomo, essere umano, mostro. Cosa vedi quando mi guardi?