Cronache di un indegno sognatore
"Un cuore debole" di Fëdor Dostoevskij
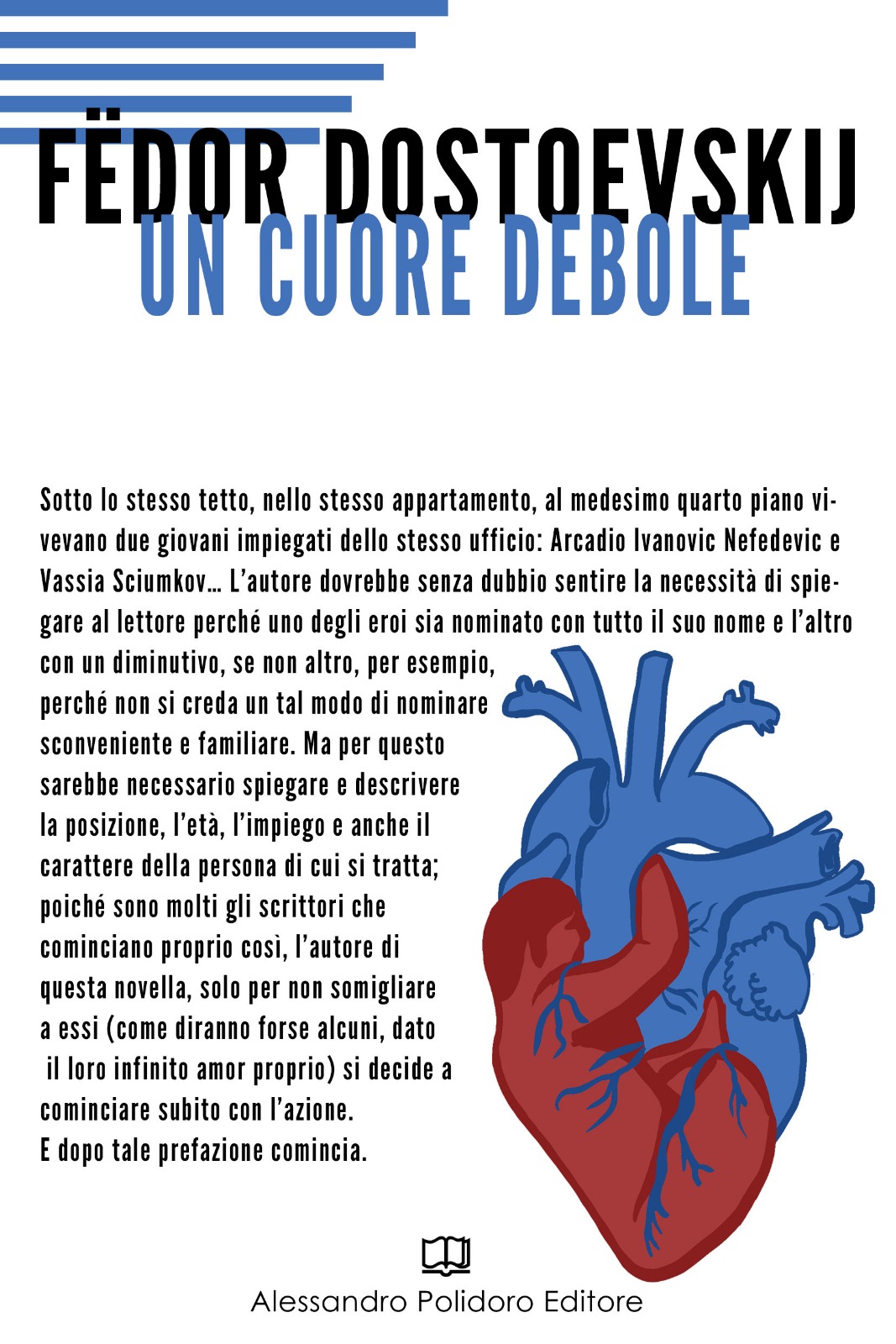
Vassia si sentiva colpevole dinanzi a se stesso; si sentiva indegno della sorte; era oppresso, scosso dalla felicità […]. Ecco che cos’è, pensò Arcadio Ivanovič – bisogna salvarlo; bisogna riconciliarlo con se stesso.
È un Dostoevskij gogoliano l’autore di Un cuore debole (Slaboe serdce), breve racconto apparso nel 1848 sulla rivista letteraria Otečestvennye zapiski e pubblicato in Italia lo scorso maggio dalla Alessandro Polidoro Editore in una nuova edizione a cura di Antonio Esposito. Compendio del pensiero dostoevskijano, quest’opera mostra l’efferatezza con cui l’obbligo di rispondere alle soffocanti richieste di una società estremamente rigida invade gli spazi privati sino a esalare l’ultimo sospiro di lucidità e concretezza di un’anima tormentata dal timore di deludere. Non è un caso che, in queste pagine redatte dalla mano febbrile di un prosatore bisognoso di denaro e affamato di riabilitazione, sia proprio la scrittura – intesa qui non come momento creatore, bensì come sterile atto di copiatura – a condannare la contagiosa felicità di un tenero sognatore.
Non è una chimera la nostra felicità. Non è scritto in un libro. Saremo felici nella realtà!
La commedia ha inizio: il sipario si alza e un ideale pubblico si ritrova «sotto lo stesso tetto, nello stesso appartamento, al medesimo quarto piano» in cui vivono Vasja e Arkadij (nel testo italianizzati come Vassia e Arcadio), uniti da un’amicizia viscerale e protagonisti di una felicità smisurata, decantata allo stremo, tanto da dissolversi nella sua stessa formulazione. Un brusco cambiamento di rotta scioglie le trame di una smodata allegria e disorienta il lettore che, stordito dalla stucchevolezza del racconto, riteneva ormai di essere al giro di boa, vicino all’epilogo. Unico sostegno contro lo smarrimento è la sicura voce intermittente di un ironico narratore, il quale, attraverso commenti e indicazioni, aggiusta il tiro e fornisce una sempre aggiornata chiave di lettura.
E detto questo, Vassia, che durante tutto questo tempo aveva sorriso, ora aveva cercato di interrompere con esclamazioni di contentezza lo sfogo dei sentimenti amichevoli, e, in una parola, si era mostrato pieno di brio, d’un tratto si quietò, ammutolì e si mise quasi a correre per la strada. Sembrava che un pensiero grave avesse agghiacciato d’un tratto la sua testa bollente; sembrava che tutto il suo cuore si stringesse.
Veramente stavolta mi sento mortificato per la troppa espansione di Vassia; di certo significa buon cuore, ma non sta bene!
Il «caro, ottimo Vassia» muta d’improvviso senza alcuna apparente spiegazione. Rattristatosi e fattosi fastidioso e insopportabile, colmo di irritazione, lascia l’incuriosito lettore in balìa degli interrogativi e alla ricerca di un movente drammatico, cagione dell’inquietudine e della debolezza di quel medesimo cuore. Ma se a ribaltare l’azione fosse, invece, una gioia incontrollata, vissuta come immeritata e sostenuta a fatica, quasi come una croce?
Sono indegno di questa felicità! Lo sento, direi quasi che lo sento! Perché a me questo?
In un’epoca in cui il regime autocratico e l’ipertrofia burocratica non fanno che aggravare il senso di alienazione di una società in cui non è consentito frenare neppure un istante per vivere individualmente, quello tra sonno e veglia risulta essere l’unico intervallo spazio-temporale ritagliabile, immune da impellenti costrizioni. Il giovane protagonista è un vero sognatore e come tale, suggerisce nella prefazione al libro Giuseppe Andrea Liberti, non può credere che quanto accade attorno a lui non sia soltanto frutto di un delizioso sogno, tanto da giungere ad annientare ciò che di più reale governa il suo presente. Innamorato e prossimo alle nozze, ostacola il proprio piacere, non permette a se stesso di goderne, ritenendo di essere investito da una felicità di cui non è degno e per questo, ancora tutta da guadagnare.
Mi sembra come se prima di ieri io non conoscessi me stesso, e anche altri ho imparato a conoscere soltanto ieri. Io, fratello, non sentivo, non apprezzavo; il cuore in me era insensibile… senti, come sarà accaduto questo, che non ho potuto fare del bene a nessuno al mondo, perché non ho potuto? Perfino il mio aspetto è sgradevole… eppure ognuno mi ha fatto del bene!
Per quanto questo breve racconto sia a tutti gli effetti una storia di fratellanza ed empatia, Un cuore debole è soprattutto la cronaca di un repentino delirio dai toni inaspettatamente tragici, dietro la quale si annidano caparbietà ed eccesso di zelo. Proprio quest’ultimo contribuirà a tramutare la felicità in disgrazia, la speranza in disperazione e, paradossalmente, a rendere un diligentissimo lavoratore incapace di adempiere ai propri compiti. Come nelle migliori tragedie classiche, l’intreccio si estende in un lasso di tempo ristretto, ma sufficiente affinché la follia, immancabile protagonista delle opere pietroburghesi dell’Ottocento, bussi alla porta dei due amici, in nulla aiutati dall’alterno stato di dormiveglia.
Il suo sonno era agitato e strano. Gli sembrava di essere sveglio e che Vassia dormisse come prima sul letto. Ma, cosa strana, gli sembrava che Vassia fingesse, che persino lo ingannasse, che si alzasse pian pianino e guardandolo con la coda dell’occhio si avvicinasse cautamente alla scrivania. Un cocente dolore afferrava il cuore di Arcadio […] il suo cuore batteva terribilmente: aprì gli occhi e si svegliò. Vassia era seduto davanti a lui al tavolo e scriveva.
Pietroburgo si erge ancora una volta ad «assurda città di incantesimi», immagine proposta da Angelo Maria Ripellino in «Pietroburgo»: un poema d’ombre, saggio introduttivo all’opera di Andrej Belyj. Se lì tutto è inganno, se realtà e illusione si confondono tra i canali, attraverso gli spietati giochi d’acqua del fiume, Dostoevskij dipinge una Pietroburgo in cui la perdita della ragione sembra attendere dietro l’angolo, in un sanguigno presagio di morte che riemerge al crepuscolo dal riflesso purpureo della Neva.
Avvicinandosi alla Neva si fermò un istante e lanciò uno sguardo penetrante lungo il fiume, nella lontananza nebbiosa e gelidamente torbida che improvvisamente si indorò per l’ultimo purpureo bagliore del tramonto sanguigno che si spegneva nell’orizzonte caliginoso […]. Sembrava infine che tutto questo mondo, con tutti i suoi abitatori forti e deboli, con tutte le loro abitazioni, dimore di poveri e palazzi dorati – gioia dei forti di questo mondo – in quest’ora del crepuscolo, somigliasse a una fantastica e incantata visione, a un sogno che a sua volta scompariva e sarebbe svanito come vapore verso il cielo blu scuro.
Seguendo passo passo il povero Arcadio, il lettore partecipa alla sua lenta presa di coscienza rispetto alla condizione dell’amico, vacilla assieme a lui e ne penetra l’angoscia. Come spesso accade nei romanzi dostoevskijani, il racconto raggiunge il proprio apice in una dolorosa manifestazione di pietà e compassione al cospetto di uno spirito precipitato nell’abisso di un fallo mai commesso e ormai condannato al supplizio. Solo allora, proprio come Arcadio, il lettore percepisce la sofferenza intrisa nella rinuncia all’umanità, schiacciata da un Potere che sembra imporsi anche quando non si impone…
Ma a un tratto in mezzo al discorso i suoi occhi si riempirono di lacrime, abbassò la voce, si voltò e si chinò sull’inginocchiatoio per nascondere alla gente il proprio dolore.