“Il sosia” di Fёdor Dostoevskij
storia di una follia
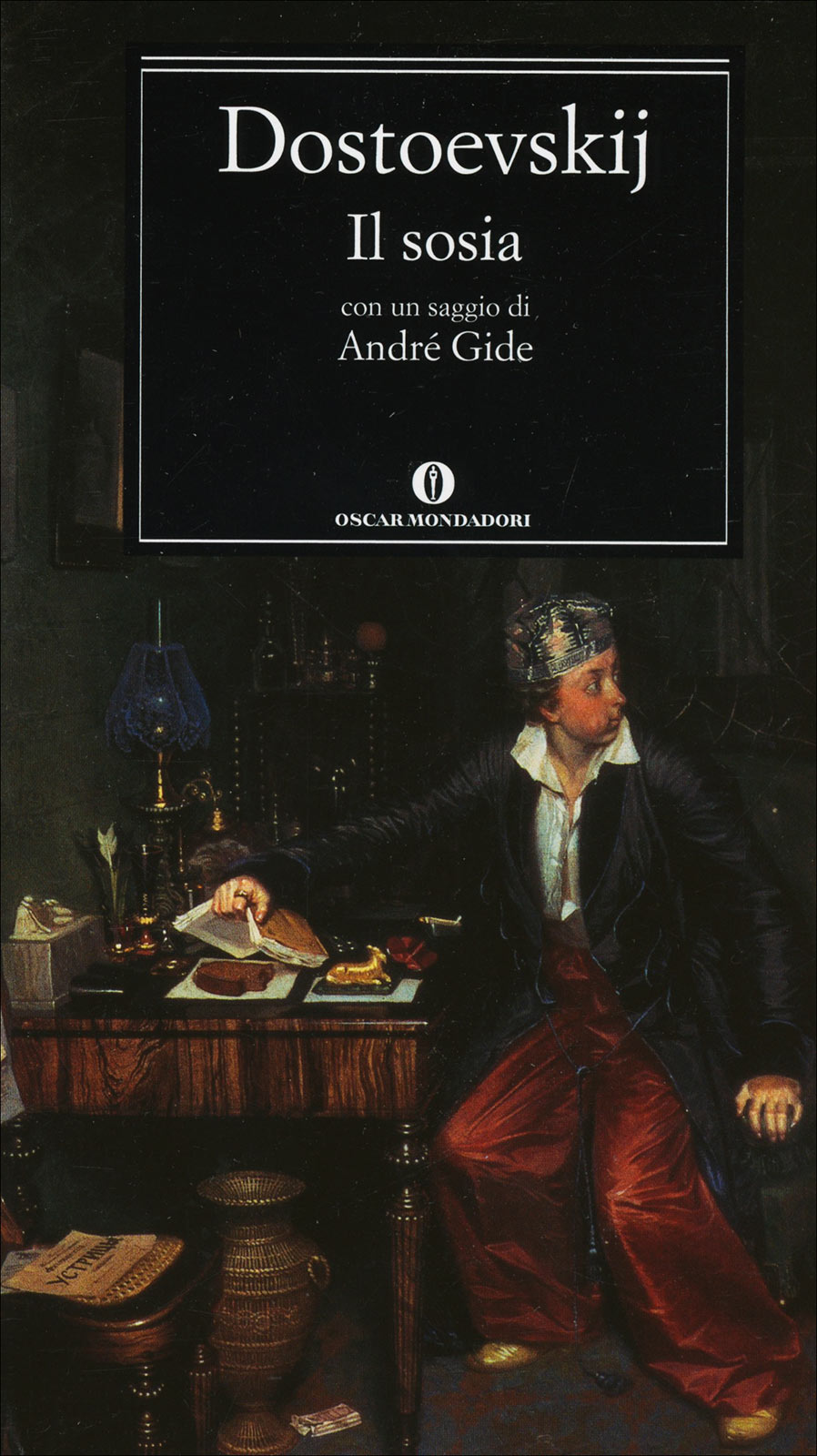
Il cuore gemeva sordamente nel petto del signor Goljadkin; il sangue gli martellava il capo come una polla ardente; egli si sentiva soffocare, aveva voglia di sbottonarsi, di denudare il suo petto, cospargerlo di neve e irrorarlo di acqua fredda. Cadde infine in deliquio…
Il sosia è la storia di un uomo o forse due che, attraverso una sapiente messa in scena di quella che la più asciutta formula matematica indicherebbe con “+1 –1 = 0”, giunge ad annientarsi. Jakov Petrovič Goljadkin è “lui” e “l’altro”, i due estremi tra i quali – secondo quanto asserisce Giovanna Spendel nell’introduzione al libro – «oscillano l’autocoscienza stessa e gli opposti comportamentali del personaggio».
L’amico notturno non era altri che lui stesso – lo stesso signor Goljadkin, un altro signor Goljadkin, ma assolutamente tal quale come lui – in una parola, come si dice, il suo doppio, sotto tutti gli aspetti.
I due Goljadkin sono gli incalzanti interlocutori, mittenti-destinatari del paradossale dialogo – e scambio epistolare – di una consapevole discesa verso la nullificazione. Allora mi correggo: quest’opera, come dichiarò il critico Apollon Grigor’ev in una recensione, null’altro può essere se non «la storia di una follia».
Era il signor Goljadkin in persona: non quel signor Goljadkin che stava ora sulla sedia con la bocca aperta e la penna sospesa in mano; non quello che prestava servizio come aiuto del suo capoufficio; non quello a cui piaceva sparire e sprofondarsi nella folla; non quello infine la cui andatura chiaramente diceva “non toccatemi, e io non vi toccherò”, o “non toccatemi, io non vi tocco mica” – no, era un altro signor Goljadkin, tutt’un altro, ma, al tempo stesso, anche perfettamente simile al primo – […] insomma nulla, proprio nulla era stato trascurato per una perfetta rassomiglianza.
Romanzo dalla gestazione complessa e stratificata, Dvojnik (pubblicato nel 1985 nella traduzione di Alfredo Polledro da Oscar Mondadori) vide la luce nel 1846 sugli Otečestvennye Zapiski (Annali patrii). Ciò nondimeno a lungo continuò a tormentare il giovane Dostoevskij che ne «Le avventure del signor Goljadkin» – tale era il primissimo sottotitolo dell’opera poi mutato in «Poema Pietroburghese» – non trovò mai veramente pace. Proprio con Il sosia, lo stesso autore di Povera gente (1845), osannato e accolto come scrittore sociale dalla critica realista capeggiata dall’influente Vissarion Belinskij – stendardo della “scuola naturale” russa –, incomincia pian piano a proclamarsi paesaggista dell’animo umano. Scrollatosi di dosso quell’etichetta troppo angusta, Dostoevskij si avvia verso uno psicologismo sui generis, inaugurando una letteratura il cui realismo risiede nell’indagine della coscienza dell’uomo.
Nella testa del signor Goljadkin cominciò un ronzio, i suoi occhi si oscurarono; gli parve che una caterva, che tutta una filza di Goljadkin perfettamente simili irrompessero con rumore da tutte le porte della stanza; ma era troppo tardi…
Innegabile l’attrazione che l’originale opera esercitò in ambito psichiatrico, tanto da far pensare a un estroso resoconto clinico. Tuttavia, benché non sia del tutto errato associare Dostoevskij al mondo medico (vista la professione del padre, il dottor Michail Andreevič Dostoevskij), Il sosia rivendica a più riprese la propria appartenenza al genere romanzesco, dove sdoppiamento e pazzia sono del tutto funzionali al fatto poetico. In questa autoscopia, a dimostrarlo è la lingua stessa, chiara testimone di un monologo interiore, tanto sofferto e sentito da divenire un vero e proprio dialogo attraverso quel procedimento letterario che, secondo Michail Bachtin, fa della produzione dostoevskiana l’apripista del romanzo polifonico mondiale. I personaggi-voce si confondono nell’ingannevole gioco di riflessi di una Pietroburgo «umida, nebbiosa, piovosa» in cui grottesche figure dalla consistenza incerta vagano alla ricerca di spessore e solidità, città-specchio nella quale il confine tra sogno e realtà è una labile linea troppo facilmente valicabile.
Il giorno dopo, alle otto in punto, il signor Goljadkin si svegliò nel suo letto. Subito tutte le cose straordinarie del giorno precedente e tutta l’inverosimile, bizzarra notte, con le sue quasi impossibili avventure, si presentarono di colpo, a un tratto, in tutta la loro terrificante pienezza, alla sua immaginazione e alla sua memoria.
Che cos’è questo, un sogno o no? […] Dormo io, sogno io?
Non è un caso, né tantomeno una novità per l’autore, se nel 1866 decide, apponendovi un nuovo sottotitolo, di inserire Il sosia all’interno di quel testo di Pietroburgo che attribuisce all’allora capitale russa tratti estremamente alienanti e contro cui una schiera di eroi letterari aveva invano tentato di ribellarsi. Goljadkin segue le orme della rivolta del giovane Evgenij de Il cavaliere di bronzo (Puškin, 1837) e allo stesso tempo si scinde come l’assessore di collegio Kovalёv nel celebre racconto Il naso (Gogol’, 1836). Eppure qui, a differenza della divertente e assurda narrazione gogoliana, non c’è nulla di comico. Nella drammatica concezione realista di Dostoevskij, il grottesco si risolve inevitabilmente nella tragicità.
Il signor Goljadkin, continuando a sorridere, si affrettò a osservare che a lui pareva di essere come tutti, che lui stava a casa sua, che svaghi ne aveva come tutti… che lui naturalmente poteva andare a teatro, perché ne aveva pure i mezzi, come tutti, che di giorno era in ufficio, ma di sera in casa, che per lui non c’era proprio male; qui osservò perfino, di passata, che lui, per quanto sembrava, non era peggiore degli altri, che viveva in casa, nel suo appartamento e che da lui c’era Petruška. Qui il signor Goljadkin s’incagliò.
Come una marionetta, il goffo Jakov Petrovič si muove a scatti – suggerisce Vittorio Strada – prova a sfuggire con indifferenza alle opinioni altrui, si nasconde. Neutralizzato da un sistema burocratico paralizzante e schiacciato da una gerarchia sociale, l’eroe dostoevskiano è l’outsider, l’emarginato tormentato da un disperato bisogno d’affetto e comprensione. Escluso e solo nelle sue ossessioni, desidera un alleato, un “fratello” che possa tendergli la mano e incoraggiarlo in un percorso di affermazione del sé che si pone, come unico scopo, la sopravvivenza di un uomo in cerca di riconoscimenti.
Noi due, Jakov Petrovič, vivremo come il pesce nell’acqua, come fratelli carnali; noi due, amicone, giocheremo d’astuzia, giocheremo d’astuzia insieme.
Superato il disorientamento iniziale, il povero protagonista non esiterà ad accogliere in casa propria il sosia, per rendersi conto, solo in un secondo momento, di aver aperto il proprio cuore non soltanto all’ennesimo spietato opportunista, ma soprattutto al nemico più crudele con cui ciascun essere umano possa mai far i conti: se stesso. Accecato dalla possibilità di riconciliarsi con una società che lo rifiuta, Goljadkin spererà fino all’ultimo in un epilogo salvifico, in un tacito accordo con il proprio io interiore che possa, in qualche modo, strapparlo alla follia, eppure…
Il nostro eroe gettò un grido e si afferrò il capo. Ahimè! Già da un pezzo aveva questo presentimento.