Figli dell’ebbrezza – Mo Yan e “Il paese dell’alcol”
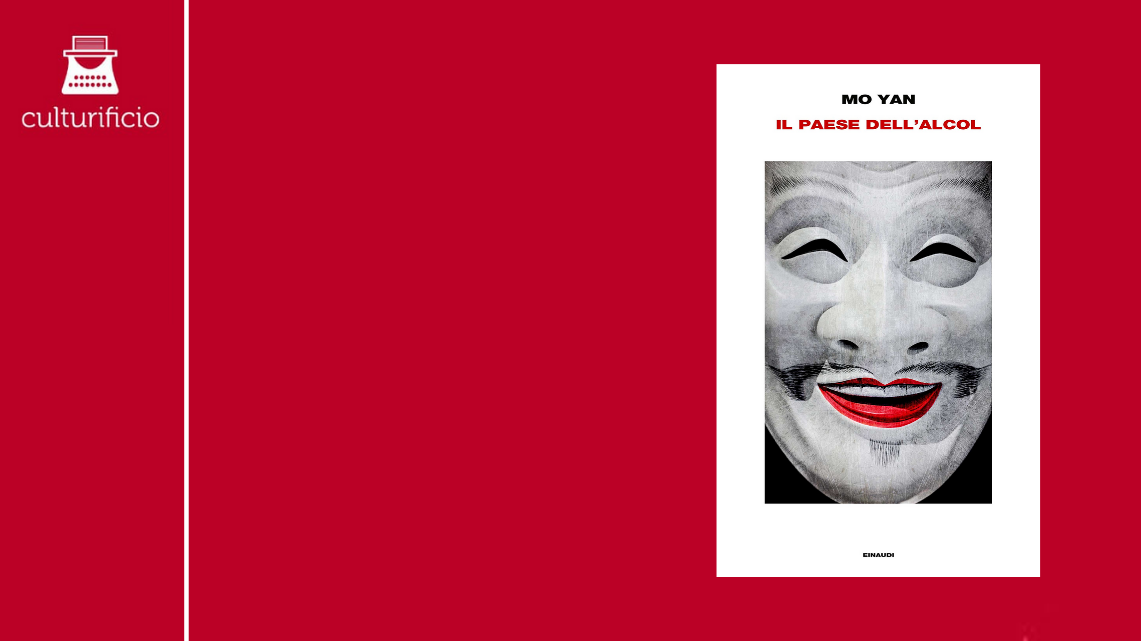
Ah, vecchio Ding, caro compagno Ding, voi siete veramente pieno di bontà e intriso di umanesimo, siete veramente ammirevole! Ma state commettendo un errore, siete vittima del soggettivismo. Osservate meglio: credete che questo sia un vero bambino?
Quando si parla di narrativa cinese contemporanea, il nome di Mo Yan è sempre il primo ad essere menzionato. Il grande scrittore, il premio Nobel, l’astro della “letteratura delle radici”, l’autore di innumerevoli best seller. Il suo romanzo più famoso, Sorgo Rosso, ha ispirato l’omonimo film del celebre regista Zhang Yimou, Orso d’Oro al festival di Berlino. Qualcuno ha addirittura affermato che il Nobel di Mo Yan sia stato il più meritato di sempre. Qualcun altro ha invece criticato la decisione dell’Accademia Reale svedese su basi politiche. Insomma, siamo di fronte a una vera e propria celebrità, anche al di fuori dei confini cinesi.
Mo Yan è in realtà uno pseudonimo, che in cinese classico significa “non parlare”. Dietro il nome di penna c’è Guan Moye, nato nel 1955 a Gaomi, nella provincia di Shangdong. La divisione in province è importante quando si parla di Cina; sulla cartina, lo Shangdong si trova nell’area nord-est. La Gaomi dove crebbe lo scrittore, che costituisce l’ambientazione di molti fra i suoi romanzi, era una comunità rurale, ancora profondamente legata ai costumi e ai valori confuciani. Come forse ricorderete dal testo introduttivo a questa rubrica, il sistema morale tradizionale fu bersaglio dei maoisti, perché promuoveva dinamiche feudali, favoriva l’oscurantismo e costringeva a rigide gerarchie familiari e sociali. Stabiliva, ad esempio, la sottomissione delle donne rispetto agli uomini e dei figli rispetto ai padri. La nuova ideologia comunista si scontrava con la mentalità delle masse contadine, legate a usi e costumi millenari. Questo contrasto fa da sottofondo costante ai testi di Mo Yan, che portano alla luce numerose problematiche emerse nelle fasi recenti della storia cinese.
Come molti scrittori coevi, durante la Rivoluzione Culturale Mo Yan dovette abbandonare gli studi per la vita contadina. Si dedicò dapprima alla pastorizia, poi alla coltivazione di cotone, e infine si arruolò nell’Esercito Popolare di Liberazione, attraverso cui poté intraprendere gli studi letterari. Bisogna considerare che in Cina la vita culturale è strettamente connessa alla dimensione politica e al ruolo pubblico dei suoi partecipanti; Mo Yan è uno di quelli che oggi appartengono alla letteratura ufficiale, appoggiata e promossa dallo stato comunista.
Non bisogna pensare che la sua sia una scrittura di propaganda; al contrario, i suoi romanzi sono costellati di critiche, anche violente e sferzanti, alle decisioni politiche del partito. In Grande seno, fianchi larghi (1995) e Le sei reincarnazioni di Ximen Nao (2006), Mo Yan esprime la propria angoscia per l’abuso delle risorse ambientali cinesi. Le Rane (2009), per citare uno fra gli esempi più celebri e recenti, è una cruda rappresentazione delle conseguenze della “politica del figlio unico”. Mentre la morale confuciana aveva abituato i cinesi a pensare che avere una discendenza numerosa fosse motivo di orgoglio, dal 1979 Deng Xiaoping impose un rigido controllo delle nascite.
L’obiettivo era quello di impedire un’esplosione demografica incontrollata, ma la popolazione faticava ad attenersi alle regole. In particolare, per molti era impossibile arrendersi all’interruzione della propria stirpe, qualora fosse nata una femmina. E così si continuava a fare figli tentando di nascondersi dalle autorità. Le pene erano severe e le regole applicate rigidamente; l’aborto veniva praticato anche in stadi molto avanzati della gravidanza e le coppie troppo prolifiche erano sottoposte a castrazioni forzate.
Mo Yan azzarda critiche dirette, incisive, sferzanti. Non abbandona tuttavia l’idea che il partito comunista, e in particolare il nuovo governo di Xi Jinping, agiscano nell’interesse del benessere nazionale. La vicinanza al potere centrale è l’argomentazione primaria dei suoi detrattori. Il grande artista dissidente Ai Weiwei è tra i personaggi più famosi ad aver criticato il conferimento del Nobel a Mo Yan, colpevole di non difendere i tanti intellettuali cinesi censurati e costretti all’esilio. L’autore, dal canto suo, accetta pacificamente la censura, paragonata alle procedure di sicurezza che precedono l’imbarco su un aereo.
Il tema dell’ingerenza statale nel mondo culturale cinese è estremamente delicato e complesso; senza prendere posizione, possiamo dire che la letteratura di Mo Yan merita il riconoscimento da parte della critica mondiale, talvolta ancora troppo eurocentrica. Il fatto che uno scrittore cinese sostenuto dal partito abbia ricevuto il Nobel ha rappresentato una svolta importante per la letteratura cinese in generale. L’Accademia Reale svedese ha così motivato il conferimento del premio: «[Mo Yan] with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary».
La caratteristica più impressionante dei libri di Mo Yan è la loro carnalità. La violenza, il sangue, il sesso. Il realismo vivido, le sensazioni più incontrollabili che escono dalle pagine e colpiscono il lettore con un’incisività tale da fargli pensare che sia troppo. Dai personaggi traspare la natura animalesca dell’essere umano, che nessuna modernizzazione o regolamentazione statale può frenare o cancellare. È nel reale che ogni vicenda trova il proprio svolgimento. Non ci sono elementi soprannaturali, fenomeni paranormali o dimensioni extraterrestri.
Ci sono invece le pulsioni ancestrali, gli istinti, i desideri che portano gli uomini alla degenerazione e alla corruzione. Quest’ultima è tra le tematiche predilette di un autore che non esita a scagliarsi contro i malcostumi della società cinese iperburocratizzata. La tradizionale figura del funzionario corrotto è resa oggi ancora più tragica dall’avvento della modernità, che con la sua smania di ricchezza e individualismo ha provocato una generalizzata perdita di valori e di identità.
Veniamo allora a uno dei romanzi più rappresentativi del realismo allucinato: Il paese dell’alcol (1992), edito in Italia da Einaudi, nella traduzione di Silvia Calamandrei. L’ispettore Ding Gou’er si trova ad indagare su inquietanti segnalazioni anonime, secondo cui nelle locande di una remota località rurale si starebbero consumando prelibate pietanze a base di carne di neonato. Gli eccessi alcolici e gastronomici sono anche il mezzo attraverso cui i funzionari locali si danno da fare per sviare le indagini del protagonista, mentre questi inizia progressivamente a maturare dubbi atroci sul nesso tra il traffico di bambini e i ricchi banchetti che gli vengono offerti. Il romanzo è, più che un poliziesco, una raffinata galleria di ritratti; l’ispettore Ding incontra una serie di personaggi pittoreschi, accomunati dalla smania di arricchirsi. La brama di denaro è l’elemento capace di annichilire anche i valori più radicati negli abitanti del villaggio, ormai disposti a cedere perfino i propri figli dietro adeguata ricompensa.
In un climax delirante, le situazioni incontrate dall’ispettore si fanno via via più paradossali e inquietanti, i contorni fra realtà e immaginazione vanno confondendosi, finché l’ispettore si trova nell’impossibilità di distinguere la verità dell’immaginazione. Nella sua mente si alternano momenti di delirio e lucidità, incubi terribili che assumono contorni estremamente concreti e che gli rendono impossibile capire se i fatti siano davvero così terribili, o se si tratti solamente della sua follia.
Al testo si intreccia un metatesto di lettere scritte da un dottorando appassionato di distillazione alcolica, rivolte allo stesso Mo Yan, per presentare i propri racconti. Lo scambio epistolare si fa sempre più fitto e incalzante, i testi del dottorando emergono con crescente vigore. In parallelo, il romanzo procede a velocità vorticosa, in un avvilupparsi di libagioni dalla natura sempre più ambigua, finché nell’ultimo capitolo i piani narrativi si sovrappongono.
Ecco allora che troviamo tra i suoi personaggi Mo Yan stesso, recatosi nel paese dell’alcol in compagnia del proprio corrispondente. La confusione si acuisce ulteriormente, con l’abbandono finale dello scrittore e del dottorando ai fumi dell’ebbrezza. Ai mille atroci interrogativi sorti nel corso della lettura non pervengono risposte; i personaggi e il lettore sono abbandonati alle proprie domande e paranoie.
Il paese dell’alcol è un romanzo affascinante e terribile, troppo particolare e tagliente per lasciare indifferenti i lettori. Sfrutta l’immagine del cannibalismo in chiave simbolica, espediente letterario caro alla narrativa cinese moderna. Il più grande scrittore del Novecento, Lu Xun, aveva adottato un’analoga metafora per criticare la società tradizionale; la mentalità ristretta e oppressiva del confucianesimo rendeva i cinesi accecati da istinti egoistici e interessi individuali. Mo Yan rielabora questo topos in chiave contemporanea, adattandolo alla realtà di un mondo che ha innalzato il denaro a divinità suprema.
Ne emerge un mosaico di personaggi disposti a farsi corrompere, una galleria di figure fameliche ed ebbre, bramose oltre ogni limite di potere e ricchezza. L’ispettore Ding finisce per smarrirsi in questo raccapricciante gioco di specchi, che culmina nella perdizione dell’autore stesso, parte anche lui della crudele società odierna, vittima e carnefice nel sistema avvelenato del capitalismo.
Ho scritto lungamente, lasciandomi trasportare dalla penna e sono sicuramente incorso in molte contraddizioni: prendi i miei consigli con le cautele del caso, non attribuendogli troppo peso. Se c’è qualcosa da cui guardarsi è la troppa coscienziosità: chi è troppo coscienzioso diventa noioso.
di Federica C.