Voland: Cronorifugio di Georgi Gospodinov
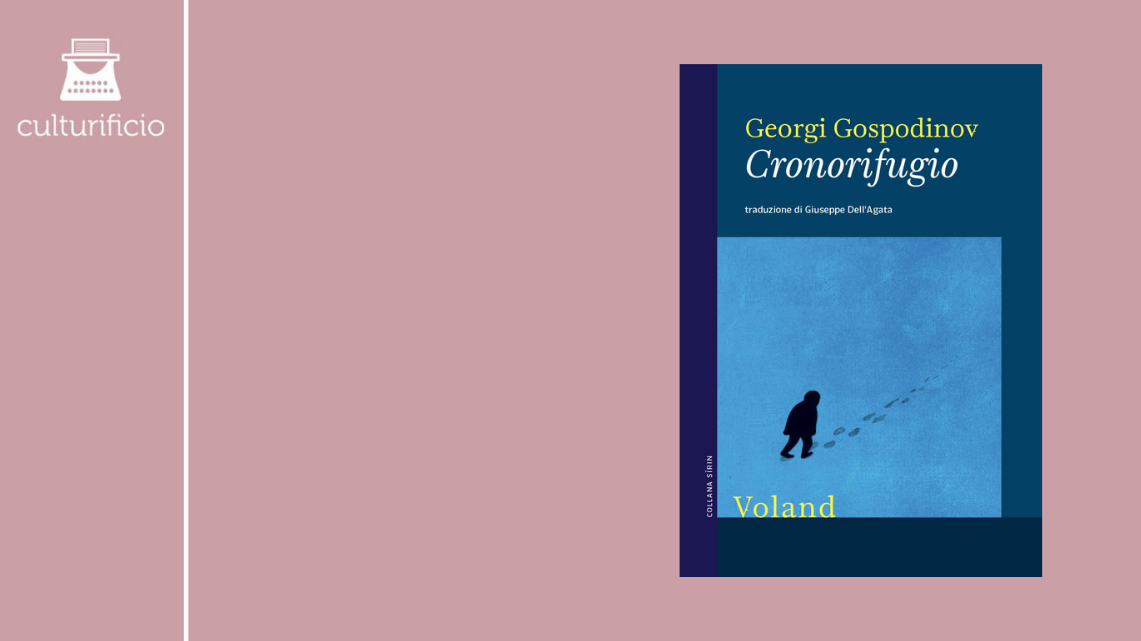
Le primulètte sono le prime letture dei libri che leggeremo, quelli che non ci vogliamo dimenticare. E per questo vogliamo seminarli prima che fioriscano tra gli scaffali delle librerie. Ecco la primulètta numero sei, Cronorifugio di Georgi Gospodinov (traduzione di Giuseppe Dell’Agata, Voland).
33. L’ULTIMA PARTITA
Camminavo in una calda sera di giugno del 1978. Da qualche parte della strada si sentiva such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place… Quell’anno risuonava dovunque Hotel California degli Eagles. Fosco ed esaltante, a volte perdeva di senso, poi tornava e la coda di chitarra ti ipnotizzava davvero. Quei ragazzi ci sapevano fare. Le riviste di musica prevedevano per loro un futuro luminoso. Trenta anni dopo, dei loro album sarebbe rimasto solo questo pezzo.
…some dance to remember, some dance to forget…
I tavoli all’aperto del ristorante sulla strada centrale erano strapieni. Su un panciuto televisore di bachelite davano la finale del campionato del mondo. Trasmettevano direttamente da Buenos Aires. Mi fermai e mi misi a guardare. L’Olanda contro l’Argentina. L’Europa contro l’America Latina. Sapevo bene come sarebbe finita quella partita, era la prima finale che avevo visto insieme a mio padre quaranta anni prima. A causa delle continue provocazioni degli argentini noi tifiamo per l’Olanda, ma è ovvio che perderà. Al novantesimo minuto Rob Rensenbrink riceve il pallone dopo un passaggio lungo, spara in rete e… prende la traversa. Abbiamo puntato sulla squadra perdente. Dovremmo esserci abituati, perché la Bulgaria ha sempre perso, anche se in questo caso sono altri a giocare. Ma non ci si abitua mai. E l’Olanda gioca divinamente. Non è giusto, i migliori dovrebbero vincere, sbatto sul tavolo il piccolo pugno. Provo ad arrabbiarmi più di mio padre. Lui si volta verso di me e dice: Vedi, vecchio (mi chiamava così), la vita è più di una sconfitta.
Ci sono cose che si ricordano per tutta la vita. Forse perché i padri di quei tempi, e mio padre non faceva eccezione, non parlavano mai con noi come se fossimo grandi. Perciò questa sua battuta andava annoverata tra gli eventi straordinari. Doveva essere una specie di testamento paterno. E non avevo capito bene se intendesse che la vita sarà piena di sconfitte e quella era solo la prima, oppure che la vita è più grande di ogni sconfitta. O forse tutte e due le cose.
Il ristorante è strapieno, tutti sono eccitati dalla partita. Laggiù, all’ultimo tavolo, c’è un uomo sugli 80 anni, coi capelli bianchissimi, occhi chiari, alto e magro. Non stacca lo sguardo dallo schermo, ma sembra non partecipare all’emozione, almeno non in modo visibile. Non batte ciglio e non si muove. Mi faccio strada e mi siedo vicino a lui. Posso? chiedo. Mi guarda senza girare la testa e si vede appena muovere il labbro inferiore.
La partita si avvicina alla fine del secondo tempo e le squadre sono ferme sul pareggio. Lo stadio ribolle. Il tiro sulla traversa deve ancora venire. Ci saranno i tempi supplementari. Tutti scandiscono il nome di Kempes. Ecco il novantesimo minuto. Magnifico tiro parabolico, ai tavoli tutti scattano in piedi, i tifosi dell’Olanda si alzano dalle sedie pronti a gridare, il pallone vola minaccioso verso la porta dell’Argentina, arriva sul piede di Rensenbrink che tira… Ah, aaah… Traversa. Il grido pronto per il gol finisce per disperdersi in un gemito prolungato…
Guardo l’uomo vicino a me. In realtà per tutto il tempo provo a guardare la partita attraverso i suoi occhi. Al tiro di Rensenbrink lui si limita a stringere la mano destra a pugno. Allora comunque si emoziona. Il risultato rimane in pareggio, la tensione cresce, il telecronista si è fatto rauco. Seguono alcuni minuti di pausa, nei quali si ordinano nuove birre. Guardo i volti delle persone. Chissà se tutti guardano questa partita per la prima volta. O se una parte di loro già la conosce e ricorda il risultato, gli accompagnatori di sicuro. Ma che importanza può avere, non fa nessuna differenza, i volti sono tesi e radiosi. Non si sa come finirà la partita, che è finita quaranta anni prima. Provo anche io a guardarla come se fosse la prima volta. Forse questa volta avverrà il miracolo. Tutto è possibile, tutto è ancora davanti a noi.
Domani i giornali andranno subito a ruba, avremo le prime analisi, le foto della partita. Le stesse di quaranta anni prima, ma ristampate su una carta nuova che odora ancora d’inchiostro. Si parlerà per un mese di quella partita e del gol di Kempes nei supplementari. Del rifiuto degli olandesi ad assistere alla premiazione, del rifiuto di Cruijff di far parte della nazionale dei tulipani, fatto che ha predeterminato l’esito dei Mondiali, dello sporco gioco degli argentini nel far ritardare la partita col pretesto del polso ingessato di un giocatore olandese… Di tutti quei particolari coi quali è fatta la storia.
Ma ora non mi interessa la storia, mi interessa solo la biografia. Le persone non si affrettano ad andar via, finiscono di bere le birre, commentano, si arrabbiano. Perfino quelli che parteggiano per l’Argentina non hanno il coraggio di gioire apertamente. Io rimango al tavolo accanto all’uomo. Fa buio, la gente si alza e se ne va. Comincia a tirare un vento freddo.
Lo prendo per mano e dico, a bassa voce ma con chiarezza: Vedi, vecchio, la vita è più di una sconfitta. Lui si volta molto lentamente verso di me. Mi guarda, non sono sicuro di cosa veda, cosa stia galoppano nella sua mente svuotata. Sono passati quaranta anni da quando guardammo insieme questa partita.
Se non sono presente nella sua memoria, esisto davvero?
Passa un minuto. Scuote le labbra e ripete senza voce, solo con le labbra, ma io capisco, si tratta di quella parola d’ordine, due sillabe: Vec-chio…
È la nostra ultima conversazione. Non mi riconosce più, tutto avviene orribilmente in fretta. Il cervello si è arreso, le province del corpo sono in rivolta. L’ho preso con me nel villaggio che Gaustìn ha appena aperto.
Certo, prima di farlo ho controllato cosa ci fosse a disposizione nel paese da cui provengo. La clinica dove ho utilizzato il pretesto di vedere un parente perché mi lasciassero entrare era un vero disastro. La maggior parte dei ricoverati era legata, in modo che non si dimenassero, roteavano istupiditi gli occhi e gemevano piano come animali che hanno perso la voce a forza di gridare. Penso che fosse la cosa più terrificante che ho visto in vita mia, e sì che di cose terrificanti ne ho viste. Cosa c’è da meravigliarsi tanto? Sono solo con 30 pazienti, non ce la faccio, ma non soffrono a lungo… disse uno dei sanitari che incrociai nel corridoio. Scappai fuori e, nel chiudere la porta d’ingresso, scorsi su un foglio di carta l’annuncio di una agenzia funebre e alcuni numeri di telefono. Ricordo il suo nome: “Memento mori.”
Acchiappai mio padre e lo condussi recalcitrante nella clinica di Gaustìn. L’uomo ha diritto di morire con dignità. Negli ultimi tre anni, quando è in grado di ragionare, chiede in continuazione di andarsene. Quando dice “andarsene” intende che lo aiutiamo a morire. Lo ha scritto su tutti i possibili foglietti e perfino sulla carta da parati della sua stanza. Finché poteva scrivere.
Dieci mesi dopo mi arrendo e decido di informarmi sulle condizioni per l’eutanasia. Solo per sapere.