Alessandro Polidoro Editore: Nefando di Mónica Ojeda
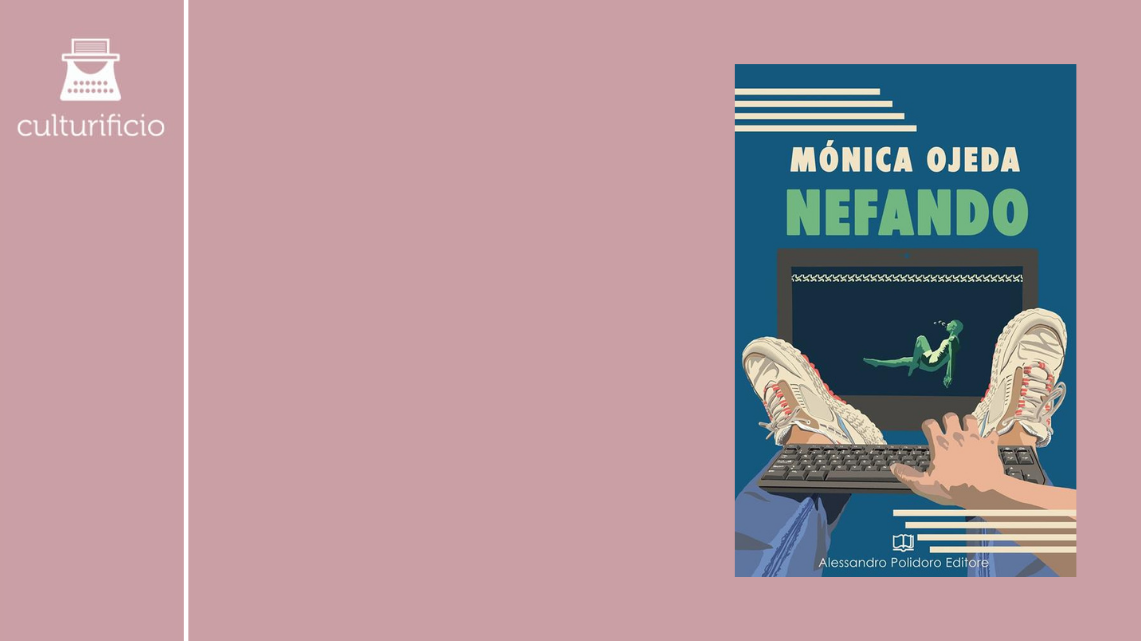
Le primulètte sono le prime letture dei libri che leggeremo, quelli che non ci vogliamo dimenticare. E per questo vogliamo seminarli prima che fioriscano tra gli scaffali delle librerie. Ecco la primulètta numero otto, Nefando di Mónica Ojeda (traduzione di Massimiliano Bonatto, Alessandro Polidoro editore).
Intervistato: Il Cuco Martínez
Luogo: Sor Rita Bar, Mercé 27, 08002, Barcellona
«Non so come sia successo, okay? Vivevamo nello stesso buco e avevamo gli stessi orari, così abbiamo iniziato a parlare. Cenavamo insieme, per dire. Io gli preparavo la tortilla di patate e loro il platano fritto o roba del genere. All’inizio facevamo conversazione perché era quello che ci si aspetta dalla nostra specie, che è stata castigata con il linguaggio. È la cosa di me che più mi disgusta: quando sto con qualcuno non sopporto il silenzio. Chissà da dove mi viene questo assurdo bisogno di parlare tanto per parlare. Anche se, a pensarci, è la funzione più onesta del linguaggio. Il semplice atto di pronunciare qualcosa ci distingue dagli animali. Lo so perché sorridi, okay?, non ti offendere: tu adesso non stai parlando e non assomigli a un animale, ma solo perché i tuoi occhi sono linguaggizzati. Voglio dire che il linguaggio ci trasforma e poi non siamo più come prima. Non so. Lo capisci subito guardando un neonato: sembrano scimmiette con gli occhi di un qualunque mammifero. Non per la forma, ma per il contenuto. Per il modo in cui guardano. Quando il linguaggio ci tocca, e lo usiamo per toccare le cose, dando loro un nome, descrivendole, allora pensiamo di sapere tutto, di poter imparare tutto, e da quel momento in poi i nostri occhi sono colmi di superbia. Questo è un problema per la conoscenza. Invece un programmatore sa di non conoscere il linguaggio che usa, lo crea. A creare qualcosa ci puoi mettere una vita intera, ci vuole una certa umiltà da classe operaia, mentre sapere qualcosa implica l’assenza del movimento, implica catturare qualcosa come una fotografia e pretendere che rimanga così per sempre. Non so. Dovremmo evitare il sintagma «saper parlare» perché ci fa credere che il linguaggio sia già fatto e finito e che basti impararlo in modo inequivocabile una volta sola. Quando diciamo che una persona parla male è perché siamo convinti che ci sia un modo corretto di farlo e, niente, non ti sembra tremendo? A me non piace dire a una persona che non conosce il linguaggio, ma solo alcune delle sue forme; non dico che non sa parlare, ma che l’atto del parlare è una ricerca, una sperimentazione con la grammatica e la sintassi. Provo a spiegarlo meglio perché vedo che mi sto già incartando: se ti dicessi che non sai parlare, penseresti che sono pazzo e che quello che dico non ha né capo né coda. Nessuno in questo bar accetterebbe di sentirsi dire che non sa parlare, perché sono tutti convinti di poterlo fare e confondono potere con sapere. Non vedono il linguaggio come qualcosa che si crea e si ricrea, ma come qualcosa di immutabile, fisso. Credono che la verità esista all’esterno di una frase e che questa serva soltanto a descriverla. Questo è un problema per la conoscenza. Non so. Dove voglio arrivare? Beh, cazzo, erano questi i discorsi che facevamo con i fratelli quando siamo diventati amici. Potrai anche non crederci, ma parlavamo di questa roba. Non all’inizio, perché non c’era ancora confidenza, però poi ci siamo trovati. Erano letterati o chiamali come ti pare, me ne frego. Mi chiesero di consigliargli libri di fantascienza. Qualcuno gliel’ho prestato».
«Quindi vi siete connessi a livello intellettuale».
«Non lo so, okay? Odio quella parola, mi confonde. Preferisco dire che ci siamo trovati. Però anche questa è in parte una bugia».
«Meglio se mi parli di Irene, Emilio e Cecilia. Uno per uno. Parlami di loro individualmente».
«Il fatto è che per me non esistevano individualmente. Lo so che detto così sembra tremendo, però in fin dei conti credo che nemmeno a loro piacesse vedersi separati. Credo avessero perfezionato per anni l’arte di presentarsi alle persone come una cosa sola. Non che fossero uguali, al contrario. Non lo erano neanche fisicamente. Non lo so. Irene non aveva paura di esprimersi. Era una di quelle ragazze che pensano a voce alta senza timore di essere guardate come delle sceme perché sanno benissimo di non esserlo. Ogni cosa che diceva sembrava tirata fuori da un libro. Parlava come stesse leggendo a voce alta, non so se mi spiego. Perfino le cose più banali, sapeva dirle in un modo speciale. Ascoltarla era piacevole, anche se capitava di sentirti a disagio perché spesso quello che diceva era un po’ troppo oscuro. Non che facessimo fatica a capirla, ma le piaceva discorrere di argomenti che ti rimescolavano dentro. Adesso non mi viene neanche un esempio. Ah no! La pornografia infantile. È comprensibile che ci pensasse spesso, però diceva cose veramente strane, okay?, tipo che era il tabù della nostra epoca, che se c’era una cosa che la nostra società non tollerava era la sessualizzazione dell’infanzia, che ai nostri giorni il sesso con i bambini o tra bambini era l’unica trasgressione al dover essere della sessualità umana; e poi parlava del senso di colpa, dei bambini che sperimentavano con il proprio corpo, dell’immagine dell’infanzia che, secondo lei, era una rappresentazione culturale inesatta, diceva che i bambini non erano tutta bontà, tenerezza e innocenza, non era tutto un eden di rigogoli e mirti, ma pure di toporagni, e potevano essere anche spregevoli».
«Già».
«Invece Emilio e Cecilia erano più riservati. Non so. Erano intelligenti come la sorella ma introspettivi, specie Cecilia, che parlava sempre con frasi brevi per dimostrare di avere uno stile parco. Prendeva ansiolitici. Una volta ha avuto una crisi parecchio spinta, i messicani si sono spaventati perché ha preso a sbattere la testa contro il muro della cucina e sembrava facesse sul serio, che se la volesse rompere davvero. Io non c’ero ma i messicani mi hanno raccontato che, mentre erano in camera, all’improvviso hanno sentito dei colpi secchi, tipo martellate, ripetuti, distanziati a intervalli di uno o due secondi, e hanno pensato che provenissero dall’appartamento di fianco o di sopra, così non ci hanno badato più di tanto, ma poi il rumore è diventato sempre più forte e Kiki è andata a vedere cosa succedeva perché i colpi si sentivano sia vicini che lontani, come se arrivassero da tutto intorno, e in cucina ha trovato Cecilia con le braccia flosce ai lati del corpo di spaghetto che sbatteva la testa contro il muro come una sonnambula; Kiki l’ha spinta, l’ha abbracciata tipo camicia di forza e poi ha gridato a Iván – lo sai, un grido come lo sanno fare solo i messicani – perché venisse ad aiutarla. Irene ed Emilio si sono presi cura di lei. Erano tutti e tre molto uniti, forse troppo, non so. Nel giro di qualche giorno stava meglio e non abbiamo più avuto episodi simili».
«Però, aspetta, tra te e i Terán doveva esserci una grande confidenza se ti hanno chiesto di creare Nefando».
«Beh, gli servivo. Mi hanno spiegato il progetto – in qualche modo lo devo chiamare – e l’idea mi è piaciuta. Non sapevo niente dei video perché a me non l’hanno mai spiegato. Quando l’ho saputo, cioè quando ho visto i video, il gioco era quasi finito. Di Nefando a me interessava l’idea di base. Mi pareva una figata. E mi sembra così anche oggi. All’epoca ero già pratico di deep web e darknet. Navigo ancora assiduamente quei livelli perché credo ci sia molto da imparare dalle profondità. L’internet che conosciamo è zeppo di luoghi, linguaggi, territori, proprio come un mondo alternativo. La cosa curiosa è che nel fondo, in questo nuovo mondo, non ci inventiamo un bel niente. Abbiamo davanti uno strumento potentissimo, un palazzo parallelo che, almeno all’inizio, dovrebbe essere ideale fintantoché siamo noi, i suoi creatori, a controllarlo, però ci trovi gli stessi errori funzionali del mondo fisico, o reale se preferisci. I problemi sociali del nostro mondo esistono anche in rete: furti, pederastia, pornografia, crimine organizzato, narcotraffico, sicari a pagamento… L’unica differenza è che nel mondo cibernetico tutti abbiamo il coraggio, almeno una volta, di essere dei criminali o moralmente scorretti; ma ce ne vergogniamo comunque, come non fossimo capaci di pensare all’esterno di un formato originale. L’essere umano ha creato questo meraviglioso spazio di libertà e ne ha fatto un calco del sistema-mondo. Sembra quasi che non abbiamo la creatività necessaria per una nuova morale che funzioni in rete, o per nuove rappresentazioni di noi stessi che si oppongano a quelle costituite».
«Insomma, mi stai dicendo che ti è sembrato giusto far girare Nefando perché secondo te internet dovrebbe avere una morale diversa».
«Non so. Forse. Senti, io non so parlare di questa roba, okay? Quando ho parlato con la polizia è stato diverso. È stato facile perché era una bugia. Hai visto? C’è sempre qualcosa di cui non sappiamo parlare, che non sappiamo esprimere senza dire quello che non vogliamo dire, eppure ce ne andiamo in giro beati e convinti di saper parlare della verità, quando invece è una stronzata monumentale, capisci? In questo momento so cosa dirti, ma non so come dirtelo. Devo scegliere le parole, ma per farlo devo pensarle e poi pensare alla grammatica con cui le devo ordinare, come se costruissi una casa di paglia che il vento soffierà via».
«Mi stai coglionando?».