Contro l’impegno: intervista a Walter Siti
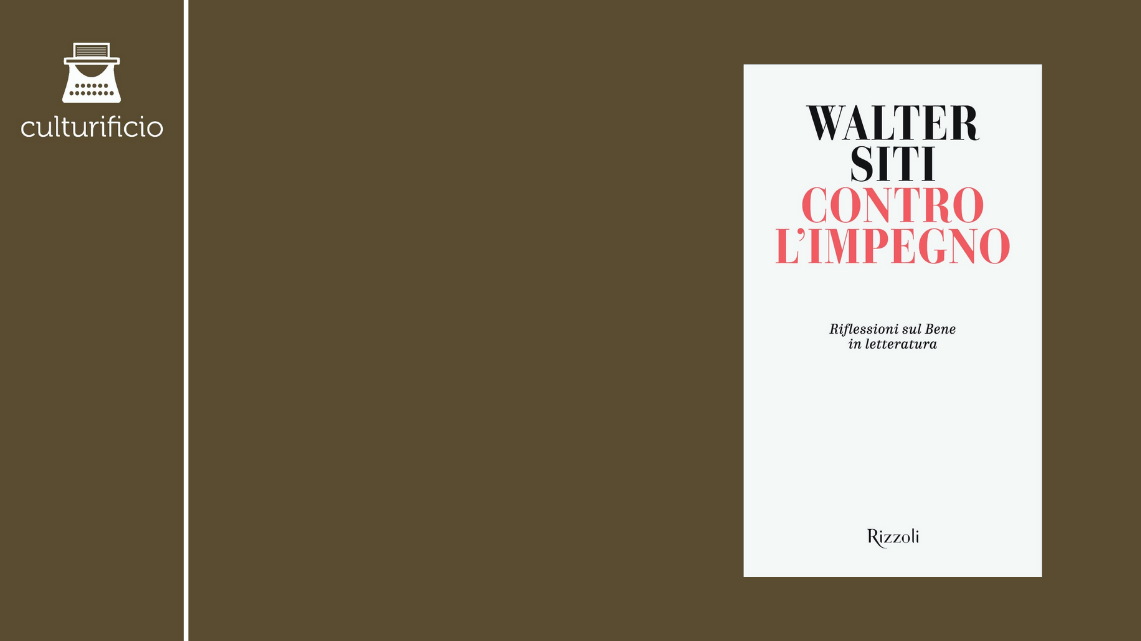
Tommaso Dal Monte: Claudio Giunta, su «Rivista il Mulino», ha scritto di aver trovato le parole con cui in Contro l’impegno (Rizzoli, 2021) critica gli scrittori neo-impegnati eccessivamente indulgenti, sostenendo di considerare più vere le stroncature di Ugo in Bontà (romanzo breve di Walter Siti del 2018, incentrato sull’editore Ugo), di base quindi tenendo ben distinta la parola romanzesca da quella saggistica. Francesco Pacifico, su «Domani», ha invece proposto di leggere il suo saggio come se fosse un romanzo, recuperando soprattutto la funzione di narratore inattendibile. In quale di queste letture si riconosce di più?
Walter Siti: In realtà in nessuna delle due [ride]. Nel senso che ci tengo a mantenere una distanza tra quando lavoro come saggista e quando lavoro come romanziere. La cosa di Pacifico è intelligente e coglie effettivamente un punto: che io mi diverto un sacco a leggere le cose che critico. Questo però ha a che fare con il mio carattere personale, e trovo che in qualche misura parametrare quello che dico come critico su alcune mie caratteristiche private sia come quando, pur fatto in modo meno offensivo da Pacifico, mi dicono che io starei dalla parte dell’impegno quando si tratta del male, e invece sarei contro l’impegno quando si tratta del bene. Sostengo, ad esempio, che quello che dice Leopardi sull’infelicità necessaria degli uomini non può essere misurato sul fatto che lui era gobbo. Io sono convito che qualunque letteratura che abbia delle verità precostituite e cerchi soltanto di ampliarle attraverso la narrativa è di fiato corto, sia che queste idee precostituite siano volte al bene che siano volte al male. Mi vengono in mente due esempi, che forse ho fatto male a non mettere nel libretto. Uno è De Sade: certe sue tirate filosofiche, che chiaramente sono volte al male e non al bene, le trovo molto noiose dal punto di vista narrativo, perché non va alla scoperta di qualcosa che non sa, ma semplicemente ha una teoria e la vuole esplicitare attraverso, per esempio, Justine o La filosofia nel boudoir. Un esempio più recente: certi rapper italiani che vogliono enfatizzare l’aspetto del male ‒ quindi la droga, trattare male le donne eccetera – e che scimmiottano il gangster americano sono delle imitazioni, e quindi dal punto di vista del valore dei testi sono dei testi non riusciti, anche se stanno dalla parte del male. Per questo aspetto non c’è nessuna differenza e quindi anche dire che Siti critica questi qui, ma sotto sotto sta dalla loro parte e li apprezza è vero, però significa tentare di smussare quello che io dico, credendoci, puntando su una mia preferenza privata. Quindi da questo punto di vista non sono d’accordo con quello che dice Pacifico, anche se poi mi sono proprio divertito e gli ho scritto che non gli si può nascondere niente, perché ovviamente quello che dice sul mio piano privato è vero.
Quanto a Giunta, la cosa che non mi convince troppo quando dice che sono stato troppo indulgente, è il fatto che lo dica perché, di alcuni scrittori – facendo i nomi: Saviano, Murgia e Carofiglio ‒, sostengo anche che hanno scritto alcune cose che a me sembrano buone, mentre lui preferirebbe un giudizio totalmente negativo. Ma io penso che, anche se uno scrive un pamphlet, non può dismettere il proprio mestiere di critico letterario e nel mestiere di critico letterario esiste il fatto che se tu analizzi tutta l’opera di un autore, puoi giudicare che alcuni suoi testi sono belli e altri sono brutti: non vedo perché uno debba partire subito dal “mi piace” o “non mi piace”. A me generalmente le cose di Saviano non piacciono, però Gomorra mi è sembrato un bel libro quando l’ho letto; così come le cose più polemiche che scrive la Murgia non mi convincono, ma Accabadora mi è sembrato un bel romanzo. Quindi, da questo punto di vista, mi sembra del tutto naturale che un personaggio letterario come era Ugo può permettersi di essere estremista finché vuole, perché tanto è un personaggio finto e uno sfoga anche tutte le sue passioni, quando però devi sostenere queste cose a livello critico, beh, l’estremismo deve essere un po’ temperato dall’analisi. Se l’analisi critica ti dice che invece una cosa è buona, perché devi dire che non è buona?
T.D.M.: Riflettevo sui titoli di alcune sue opere: Il dio impossibile, Il contagio, Il canto del diavolo, Autopsia dell’ossessione, Il realismo è l’impossibile, Resistere non serve a niente, Bruciare tutto. C’è spesso un senso di scacco e un’enfasi quasi mortuaria. Da scrittore, da che cosa si sente attratto quando decide di iniziare un libro? Qual è il suo approccio alla materia con cui si confronta?
W.S.: È una domanda molto difficile. Non so, direi che i titoli che lei ha letto hanno tutti una specie di eco nichilista. Questa è una cosa che personalmente sento molto, cioè io penso che il nulla sia altrettanto importante quanto l’esistenza; penso che dentro di noi esista una specie di nostalgia del non-essere, del nulla. Questa è una delle cose che mi muove di più, cioè quando sento che in una storia questo rifiuto globale del mondo è molto forte, che sia confessato o che non sia confessato, o quando ci sono delle contraddizioni talmente insanabili che l’individuo non riesce a venirne fuori, come nel caso di Bruciare tutto. In quel caso, io sono convinto che amare i ragazzini molto giovani sia un peccato imperdonabile, però poi se continuo a pensarci non c’è nessuno che possa operarmi il cervello e fare in modo che io non ci pensi più.
Così come a livello sociale: se io a un certo punto penso che la strada dell’economia come si sta organizzando adesso e della tecnologia strettamente correlata stia portando l’umanità verso un vicolo cieco, penso che la stia portando verso un vicolo cieco. Cioè penso che può essere che l’umanità, per cambiare davvero la direzione di marcia, abbia bisogno di uno shock molto più forte di quello che abbiamo adesso, dove si parla molto di green, del pianeta che si deve salvare ‒ a parte che il pianeta si salva benissimo anche senza l’umanità. Però ho l’impressione che finché non ci sarà davvero una catastrofe planetaria enorme, con la morte di milioni e milioni e milioni di persone, non ci sarà uno shock abbastanza forte perché effettivamente la direzione di marcia venga invertita. Perciò è vero che mi colpiscono i meccanismi di impotenza e di nostalgia del niente, quindi probabilmente quello che mi muove all’inizio è un po’ questo insomma. Adesso, se mai riuscirò a scrivere una cosa nuova, penso dall’anno prossimo comincerò a provarci, sono molto attratto da un personaggio giovane che non ho ancora ben definito in testa, ma insomma un ragazzo nato nel 2001, di quelli che a un certo punto a forza di lavorare virtualmente con il computer si chiude in casa e non ha più nessun contatto con il mondo esterno, che è un’altra forma di rifiuto e di sfiducia nell’esistenza.
T.D.M: Lei si è occupato sia di televisione, come autore televisivo e narrativamente in Troppi paradisi, che di social network, prendendo parte alla stesura di Fratelli per caso (storia dei Q4, un gruppo di giovanissimi tiktokers) in vista del suo prossimo romanzo, di cui ha appena parlato. I temi impegnati che trovano spazio in televisione le sembrano analoghi a quelli dei social?
W.S.: Da questo punto di vista mi sembra che la televisione sia più arretrata, nel senso che tratta di temi di cui si sta già parlando da molto tempo; anche perché la televisione, da quello che ho capito, è uno strumento che guardano quasi solo gli anziani. Ho l’impressione che i ragazzi che adesso hanno vent’anni o anche meno, tra i diciotto e i venticinque, non sono più abituati alla televisione nemmeno come elettrodomestico. Io vedo che addirittura quando decidono che gli interessa una cosa che viene fatta in televisione la guardano in streaming sul computer.
Quindi da questo punto di vista la televisione è una cosa che si rivolge agli anziani, e che quindi ha un range di temi positivi che vanno propagandati che sono quelli, avrebbe detto Mike Bongiorno, che vanno per la maggiore, cioè quelli più diffusi: i migranti, il rispetto che si deve alle donne, tutte le forme di minorazione fisica o psichica, la diversità eccetera. Mentre, per esempio, i temi green o altre cose sembrano più caratteristici dei giovani ed effettivamente sono più presenti sui social.
T.D.M.: Nel saggio, al capitolo III “Può l’illuminismo vincere facile?”, parla di Harvey, il romanzo di Emma Cline, evidenziando come la parola all’altro, cioè Harvey Weinstein, venga concessa solo quando esso è ormai degradato. Si parla molto del dare la parola e della visibilità che questo comporta: da una parte si incita chi ha una posizione di potere a lasciare il posto e la parola agli emarginati (o a farsene portatore), allo stesso tempo però il confronto con l’altro è spesso evitato: penso a molti influencer schierati su posizioni opposte o ai dibattiti politici tra i leader dei partiti che hanno concorso alle presidenziali del 2008, 2013 e 2018. Molte volte questo avviene con la giustificazione che il confronto potrebbe dare risalto e visibilità all’avversario. Come spiega questa dinamica della gestione della parola?
W.S.: Penso che ormai, siccome il discorso sia politico che della comunicazione in generale è molto polarizzato e quindi si tende a schierarsi in due fazioni che considerano l’altro “l’avversario”, se non il nemico, allora cedere la parola all’altro senza pregiudizio rischia non tanto di dargli visibilità, poiché la visibilità semmai sarebbe equamente condivisa, quanto che l’avversario ci convinca di qualcosa. Quindi se l’avversario ci dovesse convincere di qualcosa, butterebbe un po’ per aria la costruzione che noi ci siamo già fatti in testa.
L’esempio dei romanzi sui migranti secondo me è abbastanza caratteristico: nel momento stesso in cui la letteratura dice che vuole dare la parola a quelli che non hanno voce, poi però parla al loro posto, perché l’io che parla è sempre un io che dovrebbe essere quello del migrante, ma che in realtà è quello dello scrittore ‒ basta vedere il linguaggio con cui viene data la parola ai migranti. Questo avviene perché probabilmente si ha paura che, se si lasciasse parlare il migrante con la sua vera voce, magari il migrante potrebbe dire qualcosa di politicamente scorretto, qualcosa che lo potrebbe mettere in cattiva luce: viene alla luce che non è così vittima, ma magari può essere anche un tipaccio. Quindi saltano fuori, attraverso le contraddizioni, i santini che uno si è già preparato.
T.D.M.: Lei come romanziere la parola all’avversario l’ha concessa in Bruciare tutto, che non a caso è stato il suo libro più criticato. Perché, secondo lei, uno dei suoi testi dall’impianto maggiormente romanzesco, dunque finzionale, è stato criticato dal punto di vista morale ben più delle sue autofiction?
W.S.: In realtà credo che questa cosa di dare la parola all’avversario, a quello che comunque crea un mondo ingiusto, io non l’ho fatta per la prima volta in Bruciare tutto, ma in Resistere non serve a niente, dove in effetti ho provato a far parlare un broker finanziario e anche il suo capo, che apparteneva alla criminalità organizzata. Nel caso del broker, secondo me ci sono riuscito abbastanza bene, nel secondo no ed è una cosa che mi piacerebbe correggere di quel libro perché il capo criminale parla un linguaggio che non mi soddisfa ancora; però ho provato un pochino a dargli la parola e in effetti è stata la cosa più criticata anche in Resistere non serve a niente.
Per Bruciare tutto si sono aggiunti due grandi tabù credo, che si sono sentiti entrambi sfidati: uno è che i bambini non si suicidano, perché l’idea che un bambino si sucidi è come ammazzare la speranza, perché i bambini sono per definizione la speranza del mondo e quindi se io dipingo un bambino così disperato da darsi volontariamente la morte è come se uccidessi la speranza. Questa, secondo me, è veramente la cosa più forte che non mi è stata perdonata.
L’altro è il tabù della pedofilia. Bisognerebbe dimostrare però che Don Leo è un cattivo prete in quanto prete, e mi sembra invece che questa cosa non l’abbia detta nessuno. Per esempio tutti i discorsi che lui fa sul terrorismo islamico mi sembravano più pericolosi della pedofilia e stranamente su quello nessuno ha avuto niente da dire. Nel caso dell’autofiction, mentre lì c’era la scappatoia di dire che lui scrive queste cose insopportabili però le scrive perché è un povero disgraziato infelice, in Resistere non serve a niente e Bruciare tutto questa scappatoia non c’era, nel senso che io mi tiro indietro, sono un narratore abbastanza equanime e obiettivo e quindi non c’è questa strada.
T.D:M.: Carla Benedetti, in La letteratura ci salverà dall’estinzione (Einaudi, 2021), sostiene la necessità di sfruttare la letteratura come mezzo da cui prendere idee e schemi di pensiero innovativi per salvarci dal rischio di un’estinzione di specie. Essa si concentra molto sull’efficacia della letteratura e le riconosce un enorme valore, potenzialmente salvifico. Lei, in Contro l’impegno, depreca invece il valore dato all’efficacia, per concentrarsi maggiormente sull’analisi del senso. Crede che la ricerca di efficacia, anche immediata, sia inconciliabile con l’elaborazione di opere di grande spessore formale?
W.S.: No. Penso che uno scrittore possa benissimo anche tenere in primo piano l’efficacia che un suo libro può avere nell’immediato. Ho letto il libro di Carla. Lei in realtà poi cita quattro o cinque scrittori, non di più, in Italia soltanto Moresco e forse una cosa di Arpaia. È possibilissimo ed è anche possibile che poi questa cosa sia invece fatta in modo formalmente molto curato. Indubbiamente Antonio Moresco è una persona che sa scrivere molto molto bene, quindi penso che sia possibile fare questa cosa. L’elemento che, come dire, mi fa restare un po’ in dubbio su una tesi come quella della Benedetti è proprio la parola ‘mezzo’ che lei ha usato prima, cioè che considera la letteratura un mezzo per spaventare e terrorizzare l’umanità al punto tale da provocare un cambiamento di paradigma totale. Io non so, tutte le volte che la letteratura pretende di essere un mezzo per qualcos’altro ho un po’ di sospetto, anche se poi ad esempio lo so che Moresco non la considera un mezzo, ma un modo per esprimere una sua reale disperazione.
Come dicevo prima quando parlavo della cosa green, di Greta Thunberg eccetera, purtroppo credo che per un mutamento così radicale e veramente rivoluzionario sul serio si tratta davvero di abolire lo stato di cose presente, di cambiare completamente le radice della produzione, i modi anche di considerare che cos’è dignitoso per l’uomo eccetera. Io temo che per un cambiamento così radicale e rivoluzionario non basti la letteratura. Penso che la letteratura sia solo un massaggio rispetto a questo, e non ho la fiducia che ha la Benedetti in questa cosa. Penso appunto, come dicevo prima, che ci vorranno invece dei fatti concreti e terribilmente tragici perché questo accada. Greta diceva, tre anni fa mi pare, che dopo undici anni il cambiamento sarebbe stato irreversibile: ne restano otto e io non credo che in questi otto le nazioni del mondo si mettano d’accordo sull’inquinamento. Quindi se le parole di Greta fossero vere arriveremmo al punto in cui il cambiamento è irreversibile e dopo, qualunque cosa possa fare la letteratura, non ci potremmo fare più niente.
T.D.M.: In più parti del libro rivendica la necessità, quasi il dovere, da parte degli scrittori, di lasciarsi parlare e ispirare, citando i versi di Dante: «Poi piovve dentro a l’alta fantasia» (Purgatorio XVII, 25). E se l’unica cosa che ormai piovesse nella fantasia degli scrittori fosse la voce dei temi impegnati, a cui siamo costantemente esposti, più che in passato, soprattutto sui social?
W.S.: Eh, io penso però che non possa succedere. Cioè, vedo il pericolo perché, come dico verso la fine del libro, la moneta cattiva scaccia quella buona, per cui è chiaro che se libri di piccolissimo spessore vendono un’enormità di copie e alcune scrittrici che sono piccole scrittrici di romanzetti rosa vengono prese sul serio da alcuni scrittori che noi invece consideriamo importanti come quelli dello Strega, allora effettivamente il rischio di una confusione c’è e c’è il rischio che prenda il sopravvento questo tipo di scrittura. Però ho ancora fiducia che la letteratura sappia fare il proprio mestiere, sia pure magari quella minoritaria e un po’ di nicchia.
Io credo che non smetteranno mai di esistere scrittori che non abbiano tanta voglia di suonare il piffero a queste cose che sono adesso di attualità, ma che abbiano invece voglia di approfondire le proprie contraddizioni, di vedere che cosa le parole portano alla luce anche in modo sconcertate. Dipende se la letteratura potrà entrare in un cono d’ombra, se i canoni verranno completamente rovesciati, se i classici a cui io credevo magari verranno molto ridimensionati, però io credo che questa capacità della letteratura di essere contro corrente, di qualunque cosa si stia parlando, resterà per forza, perché è lo statuto costitutivo della letteratura stessa e non la si può negare fino a questo punto.
T.D.M.: Quale crede che sia il rapporto tra il disinteresse verso un certo tipo di letteratura attenta alla profondità e incentrata sull’ambivalenza, e la superficialità che domina nella comunicazione e nel discorso pubblico?
W.S.: Eh io penso che uno degli errori che stiamo facendo è confondere la letteratura con la comunicazione. Sono due cosa molto diverse. La comunicazione ha a che fare con il vivere degli uomini in società e quindi è sottoposta a tutta una serie di regole come la non contraddizione, la fedeltà alle proprie idee, la coerenza eccetera. Mentre la letteratura da questo punto di vista credo che sia più libera da questi condizionamenti: la letteratura può permettersi certe volte di risultare reazionaria, di risultare qualcosa che non combacia con le esigenze del vivere associato in quel momento perché magari poi diventa utile in un momento successivo, in cui le condizioni storiche sono completamente diverse. Quindi schiacciare la letteratura sulla comunicazione credo che impoverisca molto la letteratura.
T.D.M.: Nel saggio cita molti autori di cui critica la postura impegnata, mentre sono pochi quelli che conciliano l’impegno con le capacità conoscitive della letteratura, come ad esempio Houellebecq, Melazzini e Carrère. Ha un suo canone più esteso di autori contemporanei impegnati?
W.S.: Sì. Forse quello che mi piace di più non è uno di questi tre che lei ha detto, ma Achebe, uno scrittore nigeriano, perché fa emergere il problema del confronto tra culture e mette in discussione l’idea che la cultura occidentale coincida con i valori eterni dell’uomo, e mi sembra importante da questo punto di vista. Poi c’è il variegato mondo dei comici: in realtà anche il Pojana, il personaggio di Pennacchi, a me sembra che gestisca molto bene la parte illuminista del discorso. Ieri [ndr. domenica 16 maggio] è uscito un articolo di Tiziano Scarpa, sul mio libro ma in realtà molto più sui suoi, in cui per esempio dice qual è il tipo di impegno che lui intende fare ed effettivamente Tiziano è uno che fa questa cosa.
Penso poi per esempio ai Wu Ming: Roberto Bui scrive delle cose impegnate, che però non hanno quest’aria riformista e che seguono il trend del momento. Quindi ce ne sono anche contemporanei che sono capaci di fare una scrittura impegnata di livello. Poi guardi, io ho l’impressione che nel fondo gli scrittori che cercano di fare letteratura non possono evitare di occuparsi di impegno: spesso però l’impegno diventa come una specie di residuo di lavorazione. Faccio un esempio mio, per restare nelle mie piccole cose. Quando ho scritto Il contagio, io l’ho concepito come un romanzo d’amore e le peregrinazioni del vecchio protagonista nelle borgate romane sono fatte per seguire l’uomo di cui è innamorato. In realtà poi è stata presa per una cosa impegnata su come funzionano le periferie e per alcuni anni venivo invitato dagli urbanisti a parlare appunto dell’assetto urbanistico delle borgate romane. Quindi è risultato un libro impegnato, solo, in un certo senso, contro la mia volontà.
T.D.M.: Se avesse avuto trent’anni, dunque se fosse stato uno scrittore molto meno affermato e con una carriera ancora lunga da costruire, avrebbe scritto lo stesso questo libro?
W.S.: No, credo di no. Sia perché i malumori crescono pian piano con l’età sia perché probabilmente sarei stato talmente preso a cercare una mia voce, che non avrei avuto modo di riflettere su quello che stava accadendo intorno. I giovani scrittori chiaramente sono molto presi da loro stessi e dalla necessità di capire chi sono come scrittori. Per di più probabilmente lo stesso editore mi avrebbe detto di stare attento perché scrivere una cosa così può chiuderti delle porte, e quindi penso che non l’avrei scritto.