Di spettri e di gabbie: riflessioni su “Il conte di Montecristo”
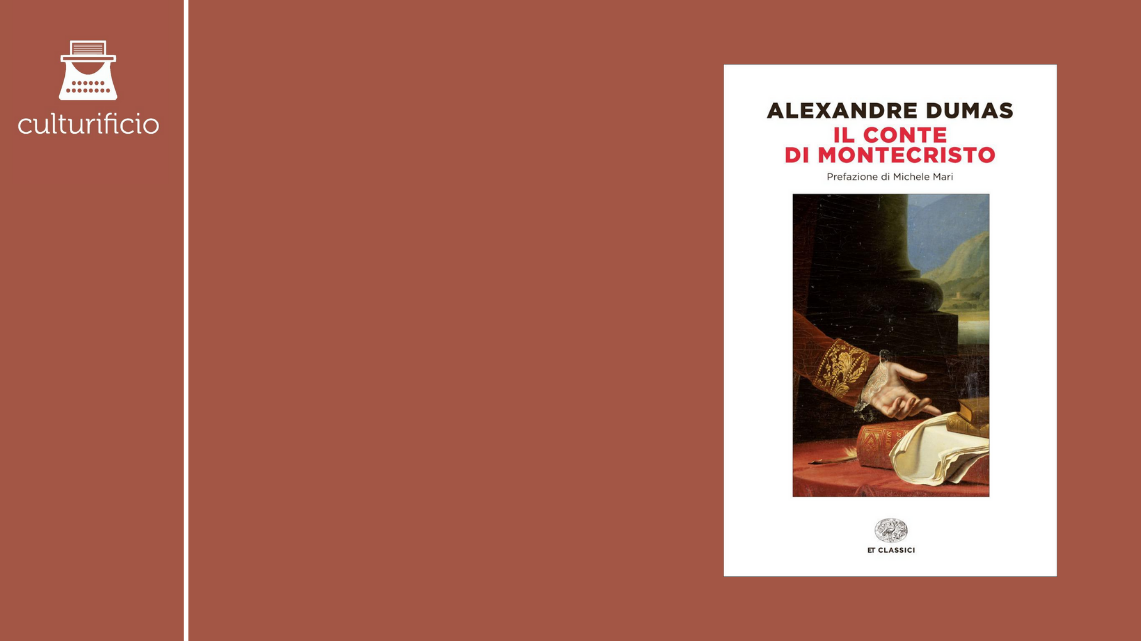
È poco rigoroso, forse, citare le quarte di copertina, ma quella dell’edizione Einaudi del Conte di Montecristo dice così: «Nessun romanzo, forse, ha avuto tante edizioni, tanti adattamenti cinematografici e televisivi; […] Tutti quindi possono dire di conoscerne almeno a grandi linee la trama e il protagonista».
Dice anche che non c’è trasposizione che regga il confronto con il piacere di leggerlo; non posso confermare nulla perché non conosco nessuna sua trasposizione (fedele o liberamente ispirata), ma che è un grande piacere leggere Il conte di Montecristo è molto vero.
Non è mia abitudine dilungarmi sulla trama dei libri, quindi mi soffermerò solo su qualche cosa in ordine sparso: la già menzionata prefazione, Alexandre Dumas e la sua ascendenza, i mostri in letteratura.
Alexandre Dumas nasce nel 1802 da Marie-Louise Elisabeth Labouret e Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, noto in Francia come il generale Dumas, nato da una schiava africana originaria di Haiti e un nobile francese che poi il generale ripudiò, assumendo di conseguenza il soprannome della madre (Du-mas). Il generale Dumas morì quando il figlio non aveva nemmeno quattro anni, probabilmente di cancro, in seguito a due anni di carcere scontati per aver disapprovato la politica imperialistica di Napoleone.
Alexandre Dumas crebbe quindi – sembra – mitizzando la figura paterna, simbolo del coraggio e della lotta contro (e in) una società classista e razzista, nella quale si era distinto per le proprie virtù; tale simbolo si ritrova nel suo romanzo, dove l’eroe puro di cuore, Edmond Dantès, assume come missione quella della vendetta nei confronti degli uomini corrotti e privilegiati, tali in seguito all’orchestrazione della sua rovina.
Attraverso la scrittura Dumas riabilita la memoria del padre, vittima del sistema nello stesso modo in cui lo è stato Dantès, che però – a differenza del generale – riesce a scappare dalla gabbia nella quale era stato confinato, fisicamente e metaforicamente.
Parlavo della prefazione all’edizione Einaudi. So che la pratica della lettura delle prefazioni conta tante abitudini quante sono i lettori, e non ci sono regole, io stessa mai me ne sono date. Questa l’ha scritta Michele Mari, a mio avviso uno degli scrittori più interessanti nel panorama italiano contemporaneo; dopo aver letto qualche suo libro è chiaro come sia perfettamente a suo agio nel ruolo di autore della prefazione al Conte.
Nei suoi libri i personaggi sono molteplici e, come se si trovasse in un grande uditorio, il lettore ha modo di ascoltare ognuno di essi. Ho ripensato a Leggenda privata, nel quale Mari si scioglie in una confessione scomoda, dando voce a tutte le ossessioni e agli esseri mostruosi che abitano sotto al suo letto; non mi stupirei se qualcuno dei suoi Accademici, così si chiamano, avesse le fattezze di Montecristo, innaturalmente pallido e scavato, spettro del ragazzo che un tempo fu.
Edmond Dantès entra come prigioniero nel castello d’If nel 1815: a quest’altezza Mary Shelley non ha ancora scritto Frankenstein (uscirà poi nel 1818), il Dracula di Bram Stoker non è nemmeno nei pensieri dell’autore, eppure è qui che Alexandre Dumas va a inserirsi, «seppellendo vivo Edmond Dantès, il vivo-morto, e facendolo evadere in forma di finto cadavere (il morto che vive), lo destina naturalmente al ruolo di vampiro o revenant» (dalla prefazione di Michele Mari all’edizione Einaudi del 2014).
La narrazione del Conte di Montecristo si apre con il ritorno di Dantès a Marsiglia; il futuro gli si profila già davanti: lavorerà per prendersi cura dell’anziano padre, sposerà Mercédès, perché così deve essere e non è preparato ad alcuna deviazione. Quando viene arrestato, il personaggio di Dumas non ha gli strumenti per vivere la propria solitudine: non è scaltro, non è colto, non può vedere al di là del presente.
Nessuna distrazione, quindi, poteva giungere in suo soccorso: la mente vigorosa, che non avrebbe desiderato di meglio che spiccare il volo attraverso le epoche, era costretta a rimanere prigioniera alla stregua di un’aquila in una gabbia. In quei frangenti Dantès si aggrappava a un’idea, a quella della felicità distrutta senza motivo apparente da una fatalità inusitata. Su tale idea si accaniva, la voltava e la rivoltava in tutte le sfaccettature, e la divorava per così dire a piene ganasce come nell’Inferno di Dante lo spietato Ugolino divora il cranio dell’arcivescovo Ruggeri.
Tutta la vicenda di Dantès si gioca, fin dall’inizio, nel segno della morte. La sua descrizione come giovane di bell’aspetto, alto, con folti capelli neri, non sopravvive all’incipit e il primo incontro con la trista signora avviene poco dopo l’incarcerazione, con la decisione di lasciarsi morire, e Dantès ci riuscirebbe anche, se non fosse per l’apparizione – che ha tutti i tratti del miracolo – dell’abate Faria. Il secondo padre di Edmond, quello dello spirito, assume le sembianze di un Robinson Crusoe delle prigioni. È lui a dare una seconda vita a Dantès, con la storia, la filosofia e la matematica. Non gli manca più nulla, dopo il loro incontro, se non la libertà, che arriva con la seconda morte e l’immediata rinascita, quella decisiva per lo sviluppo del romanzo.
«Gettò via i suoi cenci affinché sotto la stoffa ben si sentissero le nude carni, si infilò nel sacco sventrato, si mise nella posizione in cui era il cadavere»: Edmond Dantès viene gettato in mare, legato e chiuso in un sacco, esattamente come era stato fatto con ogni singolo prigioniero precedentemente morto al Castello d’If. Non è l’ultimo atto, però, per lui.
Sventrò lesto il sacco, tirò fuori il braccio, poi la testa. Allora, tuttavia, malgrado cercasse di dimenarsi per sollevare la palla, seguitò a sentirsi trascinato; si inarcò alla ricerca della corda che gli teneva avvinte le gambe, e con uno sforzo supremo la tranciò proprio nel momento in cui stava rimanendo senz’aria.
La sua rinascita avviene simbolicamente nell’acqua, uscendo da un sacco che potrebbe in effetti ricordare l’utero materno. Da qui il giovane Edmond Dantès subisce una serie di reincarnazioni e progressivamente si allontana dal ragazzo che nel 1815 era stato imprigionato fino a quando, specchiandosi per la prima volta nel negozio di un barbiere di Livorno, si rende conto di non essere più in grado di riconoscere nemmeno i propri lineamenti. La nuova fisionomia – linee dure e guance scavate, una fronte ampia, una carnagione lattea in luogo della pelle scurita dal sole del marinaio che fu – si accompagna a una nuova identità: è nato qui il conte di Montecristo.
Sarà un caso che il suo vero nome richiami Dante, dice Mari, ma anche il conte passa attraverso un inferno personale, risale il purgatorio tramite lo studio e la preparazione che l’abate Faria gli concede, come un’eredità, per assurgere alla fine al paradiso mondano che farà da sfondo alla sua missione. Sono tre anche i personaggi che convivono all’interno della figura del conte: il mite giovanotto, di cui restano i capelli neri e la statura, forse nulla più; il prigioniero disperato dal quale eredita la voce roca e la tristezza profonda e lo studioso iniziato, con la sua intelligenza sicura.
Non saprei dire se Montecristo sia davvero un personaggio o una maschera, come maschere sono quelle dell’abate Busoni e lord Wilmore, indossate all’occorrenza e repentinamente riposte nel baule; probabilmente è più corretto pensare al conte come a uno degli spettri che popolano l’opera di Dumas. Anche i titoli dei capitoli sono d’aiuto nell’inquadrare la vicenda in un mondo dai contorni sfumati, che si colloca in un limbo non meglio identificato tra vita e morte: Risveglio, Apparizione, La pioggia di sangue, I fantasmi, La tomba della famiglia Villefort.
Mari la chiama «febbre di contraffazione onomastica»: attraversa tutto il libro la tendenza ossessiva del mutamento del nome, portando i personaggi a nascondersi più volte dietro identità fittizie; non stupisce che nel progetto originario del romanzo, il conte di Montecristo avrebbe dovuto fare il suo ingresso in scena a Roma, durante la settimana del Carnevale. Non è solo Montecristo a vestire i panni di diversi uomini, però: Ferdinand Mondego diventa Morcerf, Benedetto ritorna come Andrea Cavalcanti e spesso i personaggi all’inizio delle scene non sono riconoscibili.
Tra tutte le maschere che Montecristo indossa, nessuna lo presenta nel segno della luce. È un «angelo malvagio» o un «angelo delle tenebre», e anzi Dumas arriva a descriverlo come un mostro crudele, impedito nei suoi propositi di morte solamente dalle convenzioni sociali. La figura del conte rimane ambigua, e anche quando le sue azioni lo qualificano come un personaggio positivo non è mai completamente buono né descritto con affetto. È sempre freddo, maniacalmente controllato, guidato soltanto da un sentimento di vendetta cieco davanti a tutto il resto. Anche l’attività di Montecristo come salvatore di schiavi si connota negativamente nell’accezione di white savior, ossia come il benefattore bianco che salva persone non bianche per un proprio desiderio egoistico. Tra le righe, però, se non emerge pietà, trapela fascinazione verso la figura oltremondana di un vendicatore che è tale per grazia di Dio (e lo dice lo stesso Montecristo: «Io invece tradito, assassinato, parimenti gettato in una tomba, da tale tomba sono uscito per grazia di Dio, e al cospetto di Dio ho il dovere di vendicarmi. Per questo motivo egli mi ha mandato, per questo sono qui»).
Io sono uno di quegli esseri eccezionali, e ritengo che fino ad oggi nessun uomo si sia mai trovato in una posizione simile alla mia. I regni dei re sono limitati, o dai monti, o dai fiumi, o da un mutamento nei costumi, o da un cambiamento di linguaggio. Il mio regno è grande quanto il mondo, giacché io non sono né italiano né francese né indù né americano né spagnolo: io sono cosmopolita. Nessun paese può sostenere di avermi visto nascere. Dio solo sa quale contrada mi vedrà morire. Adotto tutti gli usi, parlo tutte le lingue. Voi mi credete francese visto che parlo francese con la stessa facilità e la stessa purezza che avete voi, vero? Ebbene, Ali, il mio nubiano, mi crede arabo; Bertuccio, il mio intendente, mi crede romano; Haydée, la mia schiava, mi crede greco. Quindi capite, non appartenendo ad alcun paese, non chiedendo protezione ad alcun governo, non riconoscendo alcun uomo come fratello, non uno degli scrupoli che arrestano i potenti né degli ostacoli che paralizzano i deboli mi paralizza o mi arresta. Io ho solo due avversari, non dirò due vincitori, giacché con la perseveranza li riduco in mio potere: sono la distanza e il tempo. Il terzo, e più terribile, è la mia condizione di uomo mortale. Questa solo può fermarmi nel tragitto che percorro, e prima che avrò raggiunto lo scopo cui tendo: tutto il resto l’ho calcolato.
Non è vero che Montecristo teme la morte, come sembrerebbe emergere dalle sue parole. Solo la caducità del proprio corpo può fermarlo, ma questo è tutto, è un mero dato di fatto. La vicenda di Montecristo è completamente declinata nelle forme della missione e dell’ascesi; il mondo nel quale finisce per ritrovarsi, dopo la fuga, fa da sfondo con i suoi colori e le sue feste, non vanta mai una presenza reale del conte, che – sempre cupo, tetro – lo guarda da fuori senza esserne mai davvero coinvolto. Lo spettro di Dantès non si concede ai bisogni naturali, mangia poco o nulla, non prova istinti sessuali (in una prima versione avrebbe dovuto innamorarsi di una figlia di Villefort, ma Dumas lo priva anche di questa), e rifiuta l’amore di Haydée. Dumas lo ritrae in marcia verso il proprio obiettivo, il cuore che intanto gli si pietrifica nel petto. Il conte guarda quindi allo spettacolo della vita dagli stessi spalti sui quali si trovano i morti. Occasionalmente si arrischia tra i vivi, ma non resta mai, perché non è più il suo posto. Montecristo torna tra i morti, infatti, alla fine («il morto ritornerà nella tomba, il fantasma ritornerà nella notte»), al suo posto, è Edmond Dantès a firmare l’ultima lettera che Maximilien e Valentine riceveranno. A questo mondo non ci sono né felicità né infelicità, dice, ma il confronto tra queste condizioni. «Bisogna aver voluto morire, Maximilien, per sapere quanto è bello vivere».