Il Kojiki, le origini letterarie del Giappone
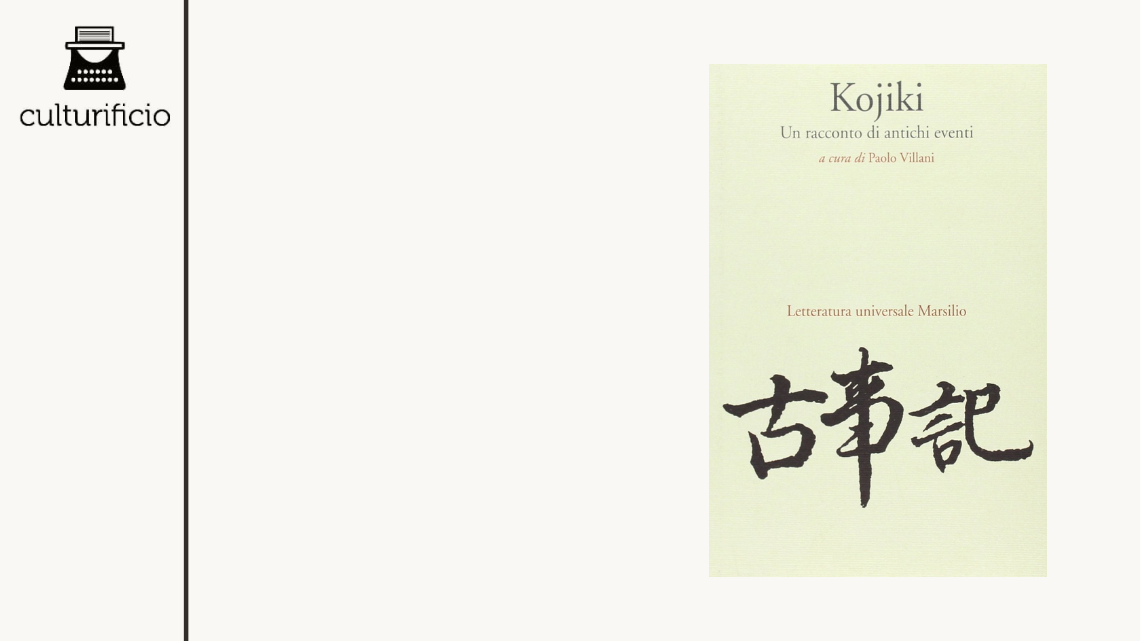
Il Kojiki (letteralmente “vecchie cose scritte”) rappresenta di fatto la più antica documentazione esistente della cultura giapponese. Formata negli ambienti di corte in secoli cruciali per la centralizzazione del potere politico e per i cambiamenti culturali (siamo tra la fine del VII secolo e l’inizio dell’VIII), viene verosimilmente completata nel 712 (anche se i dubbi riguardo a questa data rimangono molti).
Pur scritto in un periodo in cui il modello cinese tendeva a diventare egemone in tutti i campi, il Kojiki si discosta da questo influsso grazie soprattutto alle sue origini orali: nasce infatti probabilmente dalla recitazione ad alta voce di antichi testi che Hieda no Are, cortigiano dalle strabilianti doti mnemoniche e intellettuali, declama a Yasunaro, a cui il sovrano Tenmu ha affidato il compito di riscrivere e restaurare i documenti obsoleti. È lo stesso Yasunaro a fornirci nel testo le scarse notizie che abbiamo sul processo di compilazione, riferendoci le parole del suo imperatore:
Ho saputo che gli annali dinastici e le antichissime storie in possesso delle varie famiglie non sono più conformi a verità. Molte falsità vi si sono accumulate. Se gli errori non vengono corretti subito rovineranno ben presto il significato dei testi che trasmettono i principi fondamentali del nostro regno. Sarà bene dunque rivedere gli annali dinastici e controllare le storie antiche per eliminare gli errori e stabilire la verità da trasmettere ai posteri.
Da passi come questo è chiaro come il processo di compilazione dell’opera si inscriva nel quadro di una generale revisione storiografica messa in atto da Tenmu, allo scopo sia di legittimare la supremazia della propria dinastia, sia di ufficializzare la discendenza dei sovrani Yamato dalla dea del sole, Amaterasu. È addirittura possibile che sia stato lo stesso sovrano a correggere i manoscritti, adoperando Are come repertorio “parlante” da consultare, a cui far memorizzare poi le eventuali modifiche.
Il testo, suddiviso in tre capitoli secondo la concezione tipica del tempo, traccia una linea temporale che inizia dal racconto della creazione del mondo e da una prima età dell’oro del tutto dominata da figure divine (Kamitsumaki), passa a un’epoca in cui i primi imperatori sono ancora figura sovrumane (Nakatsumaki), per concludersi nel periodo che va dal sedicesimo al trentatreesimo imperatore, umani e dalle interazioni molto limitate con le divinità (Shimotsumaki). Non è un caso che l’opera si concluda prima dell’entrata in scena di Jomei, padre di Tenmu: è presumibile infatti che il sovrano considerasse gli eventi accaduti sotto il regno del padre come parte di un “presente” ancora inadatto a essere raccolto in un racconto di fatti antichi.
Il sipario si apre su una cosmogonia popolata di divinità shintoiste: da un caos primordiale descritto con una serie di immagini fisiche e concrete – grasso sull’acqua, salsedine, germi di giunco – emergono tre esseri misteriosi, che presto si moltiplicheranno prima in cinque divinità e poi rapidamente in sette generazioni.
In un universo impregnato di sacro e di zampillante fecondità, alla coppia di sposi divini Izanaki ed Izanami è assegnato il compito di generare le otto isole maggiori del Giappone: dopo un primo tentativo andato male, diventano genitori di un mondo brulicante di presenze e divinità che ben presto si fanno protagonisti di un altrettanto vasto ventaglio di eventi: si susseguono così con ritmo frenetico e quasi insostenibile (interrotto soltanto dalle lunghe sezioni genealogiche) tradimenti, inganni, scherzi e scene comiche, momenti sublimi, imprese epiche, astuzie, ma anche crudeltà e sarcasmo. Dèi e pescatori, principesse e contadini, come se non bastasse, si alternano ad animali parlanti e non, a coccodrilli beffati dalle lepri come nelle migliori favole di Esopo e Fedro e, persino, a un drago a otto teste.
Dal florilegio di creature presenti si intuisce facilmente come la magia abbia un ruolo predominante nell’opera e sia squadernata in tutta la sua casistica più classica e più bizzarra: si va da incantesimi e maledizioni a possessioni di spiriti, da metamorfosi in serpenti a uomini a cui cresce la coda, da sogni premonitori a cetrioli di mare che decidono di chiudersi in un mutismo selettivo (sì, avete letto bene).
Tra la miriade di oggetti più o meno fantastici che ricorrono nel racconto, le spade sembrano essere le più diffuse e funzionali come snodo narrativo: ne troviamo di false, di magiche, di “falcia-erbe”, di fertili e miracolose. I protagonisti sembrano non farsi troppi problemi a usarle: la violenza dilaga nel Kojiki, e rende palese una delle caratteristiche che differenziano la mitologia giapponese da tutte le altre: l’assenza di giudizi morali su ciò che è buono o cattivo.
I nemici vengono fatti a brandelli senza pietà e li si uccide senza remore persino mentre sono intenti a espletare i propri bisogni: i riferimenti osceni non sono oggetto di censura. Così apprendiamo che il dio Susanowo si è vendicato della sorella defecandogli nel palazzo, che la dea Izanami ha generato creature viventi anche dal proprio vomito, dalla propria urina e dalle proprie feci, o che le divinità possono offrire gustoso cibo estraendolo da tutti gli orifizi del loro corpo. Tutto fa parte dell’universo, e come tale può e deve essere narrato –anche perché, spesso, è pure divertente.
Ma non bisogna lasciarsi ingannare dal brio scanzonato di brani simili: nell’eclettismo strabordante di quest’opera tanto varia quanto breve c’è in realtà spazio per un concetto di morte più elevato e spirituale, che nel classico intreccio con Eros, è evocato dalla storia del principe e della principessa Kauru. I due fratelli con il loro amore incestuoso fondano l’archetipo, che tanta fortuna avrà nella letteratura giapponese e non solo, del doppio suicidio degli amanti osteggiati dalle convenzioni sociali (shinju). È nelle pagine a loro dedicate che si tocca una delle vette più alte e mature dell’opera:
[…] Il principe […] addolorato intonò canzoni:
[…]
Presso il fiume della remota Hatsuse
pianto due sacri arbusti
uno sul basso corso uno sull’alto
e vi appendo uno specchio e una splendida gemma.
Sei tu la mia gemma e il mio specchio
donna dei miei pensieri
e vorrei, solo tu fossi lì, tornare
alla casa e alla terra che amo.
Poi si diedero assieme la morte.
Canzoni come questa, scritte in caratteri fonetici e dunque difficilmente decifrabili, intarsiano il racconto assumendo ruoli diversi. A volte appaiono infatti sconnesse e incoerenti rispetto al testo e sono state dunque interpretate come componimenti a sé stanti (il passo in cui il principe Yamamori canta mentre i flutti lo trascinano via può darne un’idea); altre assumono invece una specifica funzione narrativa, servendo spesso da avvertimento più o meno celato per pericoli futuri. Tali intermezzi lirici si infittiscono man mano che si procede verso la conclusione, riuscendo ad aprire il racconto a orizzonti poetici inaspettati: pur non rispettando i canoni della poesia giapponese classica, attraverso questi versi si avverte irresistibilmente qui e là il sentore della raffinatezza e complessità a cui ci abitueranno opere e componimenti delle epoche successive.
Se le affinità del Kojiki con la mitologia greca, e in genere con fiabe e miti universali, sono evidenti e riconosciute da molti studiosi europei – dalle eroiche missioni del rude Yamato che ricordano quelle di Ercole o Giasone ai cavernicoli raggirati con abili camuffamenti come Ulisse e i suoi con il Ciclope; dal riferimento al mito di Atalanta e Ippomene alla esplicita rassomiglianza tra la storia di Izanaki che vuole recuperare Izanami dagli Inferi con il racconto di Orfeo ed Euridice–, è tuttavia importante rilevare che la maggior parte dei miti in esso contenuti sono chiari riferimenti a fatti storici reali: ad esempio la stessa spedizione del rude Yamato fa riferimento all’espansionismo del potere dinastico di fine quarto secolo, e l’incursione nella terra coreana di Shiraki è probabile segno degli effettivi rapporti tra Giappone e Corea tra quarto e sesto secolo.
Non si può non accennare alla rilevanza fondamentale che la questione linguistica assume nel Kojiki: è infatti il primo tentativo rimasto di mettere per iscritto la lingua giapponese, mediante un adattamento dei caratteri cinesi alla lingua nipponica che potesse risultare comprensibile e insieme preservare il patrimonio di varietà espressive, frasi idiomatiche, formule magiche, proverbi.
È lo stesso Yasunaro, alla fine dell’opera, a palesare le difficoltà che ha dovuto affrontare per mantenere l’equilibrio tra comprensibilità del significato e attendibilità della pronuncia: la sua scelta è quella di adoperare i caratteri cinesi in modo semantico per le parti in prosa e foneticamente, come si è accennato, per le parti in versi.
Questo comporta ovviamente maggiori difficoltà per la traduzione e l’adattamento del testo, che però Paolo Villani, curatore dell’edizione italiana del 2006 per Marsilio, nella collana Mille gru dedicata ai classici giapponesi, supera egregiamente, restituendoci un libercolo estremamente curato sia nel testo che nell’apparato, preciso e puntuale, di note e introduzione.
Il Kojiki è insomma un testo imprescindibile per chi si approccia alla cultura nipponica per studio o per semplice passione; è il perfetto specchio, nei suoi aspetti storici, culturali, antropologici e sociali, di un’epoca di passaggio da una tradizione orale a una corte dinastica sempre più conscia del proprio ruolo e della necessità di sancire un importante riconoscimento scritto del proprio potere.
E tuttavia è molto più di questo: è una storia divertente, godibile, interessante, meravigliosamente straniante.
Pur rimanendo, come ricorda giustamente Villani, un’opera acerba, vibra agli occhi del lettore di una potenzialità immaginifica e affascinante, capace di compiere l’incantesimo più potente di tutti: mostrarsi, anche se geograficamente, cronologicamente e culturalmente tanto distante, incredibilmente familiare.
di Rossella Miccichè