Immaginari e circolarità di provenienza balcanica
sul primo romanzo di Elvis Malaj
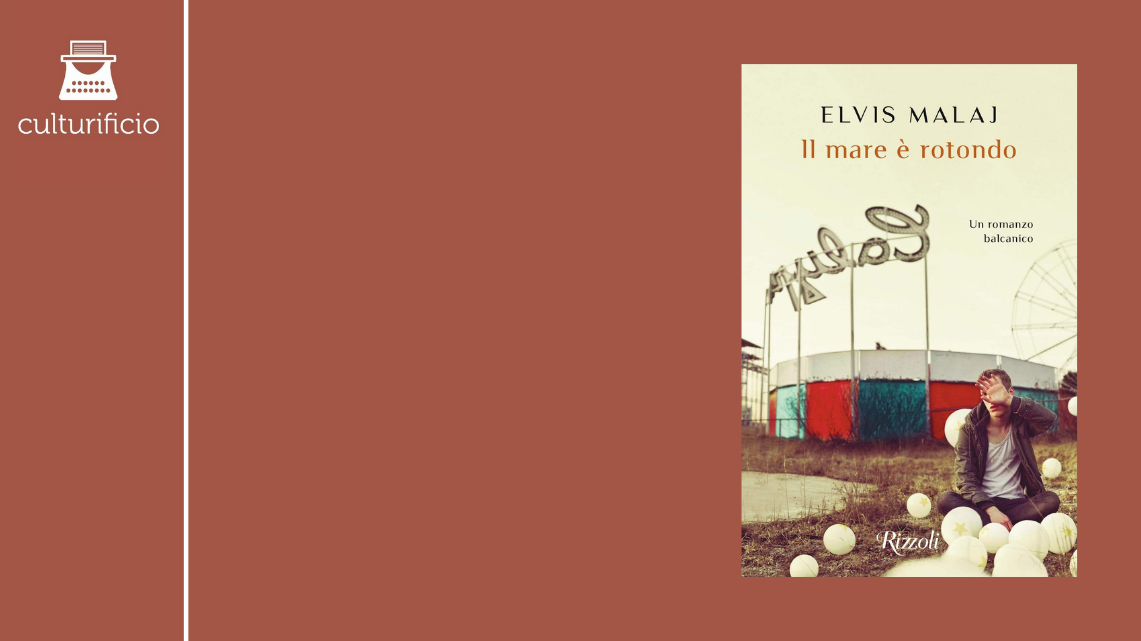
Ormai più di un anno fa, a ridosso della pandemia, usciva il primo romanzo di Elvis Malaj, Il mare è rotondo (Rizzoli, 2020). Malaj aveva già esordito con la raccolta di racconti Dal tuo terrazzo si vede casa mia (Racconti Edizioni, 2018) e si era subito messo in evidenza per il suo stile, caratterizzato dalla ricerca di un ritmo continuo. In quelle pagine veniva portata avanti una sintassi ridotta all’essenziale. Uno sguardo diviso tra due mondi, quello italiano e quello albanese, dava vita ad uno scambio interculturale a distanza, in un gioco di esperienze complementari.
In questo caso invece l’osservazione si sposta completamente nella terra di Malaj, mentre l’Italia viene soltanto evocata. Il decentramento dell’azione risente forse di alcuni stereotipi tipici della visione occidentale sui Balcani – irascibilità dei caratteri, atti di violenza improvvisa, stagnazione pre-moderna, inospitalità dello spazio architettonico e urbano – ma lo sguardo dell’autore rimane in molti aspetti aderente alla realtà, con l’ulteriore pregio di descrivere eventi relativi ad una fase storica, quella dei primi anni Duemila in Albania, che non aveva ancora trovato molte rappresentazioni nella letteratura italofona.
In Il mare è rotondo ho ritrovato senza dubbio il talento affabulatorio che mi aveva colpito nella raccolta di esordio. Vorrei continuare sulla strada dei riferimenti intertestuali tra le due opere, per dare forma ad alcune costanti dell’immaginario di Elvis Malaj. Quei racconti del resto costituiscono un serbatoio di idee che vengono poi riprese nel romanzo, in alcuni casi tramite riscritture piuttosto puntuali.
La dimensione del frammento e la capacità di mantenere sempre alto il ritmo narrativo, grazie alla tecnica del colpo di scena, rendono la lettura di queste 230 pagine snella e godibile. In 19 capitoli vengono raccontati alcuni episodi della vita del giovane albanese Ujkan. Il ragazzo vuole andare in Italia ma, arrivato a pochi metri dalla spiaggia, sul punto di saltare giù dall’imbarcazione che lo ha trasportato lungo l’Adriatico, decide di tornare indietro. Rientrato a Scutari, la sua città, si innamora di Irena, una ragazza controversa, chiusa in sé stessa e incline talvolta a reazioni violente.
Nel mezzo, un ristretto gruppo di amici: lo scrittore Sulejman, Gjokë, figlio di un uomo d’affari, e Bashkim, che si è già spostato in Italia e che dovrebbe rappresentare il tramite grazie al quale Ujkan potrà a breve raggiungerlo. Le giornate di quest’ultimo si disperdono in tentativi senza scopo: una attività di tipo imprenditoriale costruita attorno alla raccolta del ferro, l’attesa per una seconda partenza alla volta dell’Italia e soprattutto l’avvicinamento problematico a Irena, che spesso lo respinge dopo rapidi rapporti sessuali. Il tema della ragazza scontrosa, dalla psicologia complessa, era già comparso a più riprese nella raccolta del 2018. Il racconto Mrika ad esempio anticipa in alcune sequenze l’incontro tra i due protagonisti, incentrato attorno al magnetismo delle movenze del corpo della ragazza, osservata mentre si sposta in bicicletta.
Nel rapporto tra il dilatarsi del tempo e l’ironia con cui vengono demistificati i ragionamenti dei personaggi troviamo il senso che viene implicitamente trasferito all’aggettivo balcanico, che in copertina accompagna il romanzo. Alcuni stilemi vengono condensati in situazioni grottesche, quelle che i film di Emir Kusturica avevano portato all’attenzione alla fine degli anni Novanta. Ritornano intatte, assieme alle variabili dell’inatteso, alcune figure improbabili e il caos vertiginoso di azioni senza una chiara teleologia. In un’ideale trasposizione cinematografica molte delle scene de Il mare è rotondo non potrebbero che essere montate con l’accompagnamento ritmato dei clarinetti e dei bassi tuba della The no smoking orchestra.
Il personaggio incongruente, edificato sul motivo della circolarità che regge il titolo e la sematica figurale del romanzo, non fa altro che girare a vuoto su sé stesso. Questa «sindrome», che riporta sempre Ujkan al punto di partenza, sintetizza una incapacità di spingersi oltre (p. 70). Ma non si tratta di una condizione che interessa soltanto il protagonista. È tutta una antropologia a risentirne, mentre nasconde al suo interno una forma di dolore. Malaj sceglie di non esprimerlo attraverso i colori del dramma, perché la sfumatura da lui preferita è quella dell’assurdo. L’autore rinuncia a ogni tentativo di epica, anche nelle scene apparentemente più compromesse con il rischio della morte, come quelle dei pestaggi ai quali viene sottoposto Ujkan. Il malessere, anche esistenziale, viene espresso dalla costruzione di situazioni paradossali, rese meno brucianti dal registro dell’ironia.
Questa poetica dell’illogico è incarnata alla perfezione da un comprimario, il cantautore Shpat, che decide di togliersi la vita durante un concerto in piazza, sparandosi in bocca con un pistola. Shpat sopravvive, mentre è uno spettatore di un palazzo vicino al palco a perdere la vita, raggiunto da un beffardo proiettile vagante che ha perforato soltanto la guancia dell’aspirante suicida.
La fame di Italia che sembra nutrire Ujkan, assieme a Irena, viene demistificata da più di un particolare. Nel testo trova spazio un controcanto polemico e in sordina, che però parla in maniera incontrovertibile, restituendo immagini poco incoraggianti. Anche se il progetto del protagonista, velleitario e contrastato da una serie di imprevisti che ne differiscono ad arte il compimento, è quello di abbandonare per sempre l’Albania e cercare fortuna nel paese del presunto benessere, da una serie di indizi possiamo affermare che l’Italia appare più che altro come una falsa terra promessa. Inospitale fin dalla prima scena, quella in cui una retata delle forze dell’ordine accoglie sulla spiaggia i migranti appena tuffatisi in acqua dal barcone, nei racconti dell’amico Bashkim, trasferito da anni e integratosi nel sistema di lavoro italiano, troviamo conferma di condizioni disagevoli: pregiudizi; ragazze disinibite e viziate dal benessere paterno; clienti arroganti, in cerca di un pretesto per piantare grane; mancanza di soldi; pignoramenti forzati.
Quando Ujkan apprende del fallimento dell’hotel che avrebbe dovuto accoglierlo con un contratto di lavoro, si appella alla besë, al sacro rispetto della parola data, intesa anche come vincolo a tutti gli effetti giuridico. Gli risponde Bashkim: «Ma di che parli, Ujkan? Sii serio, siamo nel Ventunesimo secolo, non esiste più la besë. Poi qui non c’è mai stata, quello è solo folclore albanese» (p. 217). Il romanzo di Malaj decostruisce a distanza il presunto sogno italiano e lo proietta su uno scenario di desolazione anche morale. Come già aveva intuito Ornela Vorpsi nei suoi racconti (Bevete cacao Van Houten, Einaudi 2005), c’è una forza che erode dall’interno il mito di un Belpaese che accoglie e che regala opportunità. In uno scenario meno ottimista e meno aperto al tema dell’integrazione, rispetto a quello dei racconti di Dal tuo terrazzo si vede casa mia, Malaj sposta il focus su una contaminazione negativa tra due sistemi culturali sulla carta molti diversi eppure ora diventati simili.
L’avvicinamento, se avviene, è di natura globalizzante e tardo capitalista. Il patrimonio culturale delle singole realtà geografiche – in questo caso l’antico Kanun, il codice che aveva per primo normato le consuetudini del diritto albanese, più volte citato nel romanzo anche in chiave parodica – viene appiattito su una prospettiva esclusivamente economica. Per questo motivo ho trovato straordinariamente efficace che gli unici riferimenti a un testo da intendersi come guida anche etica siano quelli rivolti ad un manuale di tecniche di vendita: una sorta di nuova Bibbia comportamentale.
Alla fine, il fascino dell’Italia si riduce a poche cose, tutte di natura materiale: il prestigio delle vetture, evocato dalle lettere delle targhe. Le caramelle made in Italy, che valgono di più e che possono essere usate come merce di scambio. Anche in questo particolare torna il Malaj dei racconti, capace di descrivere certi oggetti con una notevole capacità empatica, investendoli di un fascino ipnotico – le scarpe di Dedë, il televisore abbandonato, la cravatta con un motivo floreale, che verrà ripreso nel romanzo con l’episodio di Fadil sull’autobus (pp. 129-132).
La struttura di Il mare è rotondo, tuttavia, trova in uno dei suoi punti di forza – la leggerezza svagata del frammento – anche una implicita debolezza. Per essere un romanzo, la linea narrativa risulta a tratti dispersiva, dominata più dall’episodicità che da un’architettura di fatti concatenati in direzione di una meta.
Il filo che tiene insieme i capitoli è rappresentato dalla faticosa rincorsa in direzione di Irena da un lato e, dall’altro, dalla rielaborazione di alcuni insegnamenti contenuti nel manuale di tecniche di vendita al quale prima facevo riferimento. L’altro diventa il cliente. L’insistenza, e la stoica impassibilità di fronte ai rifiuti, sono le armi per penetrarne la chiusura. Grazie a questi rudimentali precetti di matrice anglosassone Ujkan cerca di vincere le resistenze di Irena, nel tentativo di convincerla a instaurare una relazione duratura con lui. La strategia di persuasione si basa su un unico valore: la determinazione del piazzista.
A poche pagine dal finale del romanzo compare infatti un misterioso uomo, che chiude in qualche modo il percorso imprimendo ai fatti una circolarità anche di significato. In passato aveva incontrato Ujkan ragazzino e gli aveva “venduto”, consapevole che non avrebbe mai ricevuto denaro in cambio, il corso di vendita. In seguito a questo evento sono così maturate alcune convinzioni esistenziali che hanno reso la sua natura molto simile a quella di un venditore.
Sembra un passaggio da poco, tra l’altro nemmeno compiutamente risolto, ma è invece dal mio punto di vista la chiave di lettura dell’intera storia, o meglio, il dettaglio che permette di interpretare sotto una luce più complessa un plot a prima vista più esploso che incline alla ricomposizione. L’apparizione dell’uomo sconosciuto ha i connotati della figura tentatrice, quasi demoniaca. Trasferisce, senza pretendere un compenso, l’impulso di un cambiamento culturale e valoriale. Senza addentrarmi in una lettura eccessivamente ideologica, non consentita dalla natura del testo, questo cambiamento non è altro che il passaggio dal sistema comunista e stalinista fortemente voluto dal dittatore Enver Hoxha a quello occidentale, in cui dall’anno 1991 in poi ha prevalso la progressione del «libero mercato», come ha appreso anche una comunità apparentemente ai margini del tessuto sociale, quella degli Tzigani (p. 103). Questa transizione, che ha occupato in Albania circa venti anni, ha radicalmente trasformato ogni momento della vita culturale e sociale e ha proiettato il paese a ritmi vertiginosi direttamente nel Ventunesimo secolo. Il tardo capitalismo globale ha cominciato a prendere piede anche qui, procedendo a grandi falcate con l’affermazione dei suoi valori, connessi alla compravendita degli oggetti. Pregio del romanzo è aver saputo cogliere, in maniera implicita e narrativamente raffinata, il senso forse più profondo di questo passaggio, traducendolo in immagini che hanno anche le potenzialità di una lettura allegorica.
Non è un caso che i commerci di Ujkan e Sulejman abbiano origine in una discarica. I due cominciano a raccogliere materiali in ferro e in rame con l’intento di rivenderli a prezzi vantaggiosi. Lo scarto del bene in disuso trova una immediata rifunzionalizzazione in un movimento circolare che, questa volta, riguarda la merce e la sua inesausta capacità di ritornare economicamente produttiva. Il racconto di questi aspetti, e di una parte di Albania che comincia a cambiare il suo volto, può anche leggersi come una sorta di documento storico, con tanto di datazione. Nell’anno 2009 viene completata una della prime opere pubbliche nazionali, la Rruga e Kombit, l’Autostrada della Patria che collega tutt’oggi Durazzo al Kosovo, passando proprio da Scutari. L’infrastruttura viene esplicitamente citata nel momento della sua inaugurazione. A causa del furto di alcuni metri di guard-rail – una fonte di ferro a costo zero – Ujkan e Sulejman finiscono addirittura in carcere e incontrano la figura di un ombroso Presidente (forse addirittura Sali Berisha), che dialoga con loro e che alla fine è costretto a farli rilasciare.
In questo clima a tinte progressivamente fosche, tanto da far pensare a una virata noir, ci avviciniamo alla conclusione, non anticipata da alcun rallentamento del ritmo. Poco prima che Ujkan, probabilmente nel corso di un sogno o di una visione ad occhi aperti, si accenda una sigaretta, dopo essersi schiantato a bordo di un furgone lanciato a folle velocità contro le barriere dell’Ambasciata italiana, il romanzo trova un finale inaspettato, dominato dal registro del nonsense. E lì, in sottofondo, assieme ai titoli di coda, riparte il contrattempo di una musichetta alla Kusturica.
di Fabio M. Rocchi