No man’s grad: le dinamiche della memoria
“Una mappa per Kaliningrad. La città bifronte” di Valentina Parisi
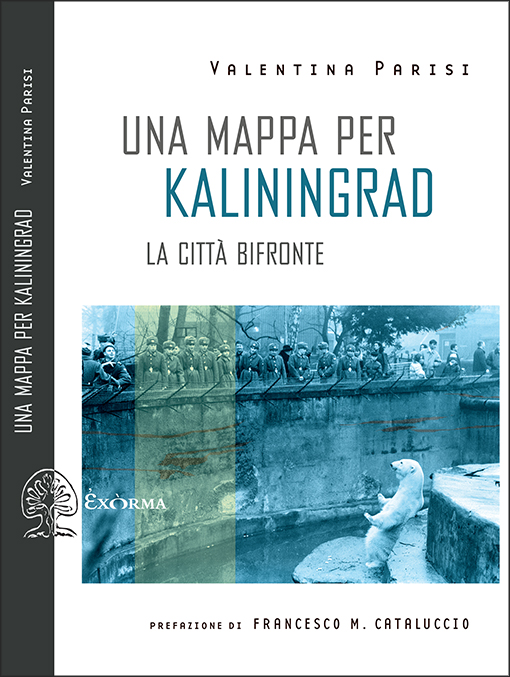
La Storia ha conosciuto la deportazione di massa, il forzato ricollocamento dei singoli, ma può esistere qualcosa di simile a una displaced city? Le città si possono s-postare, s-piazzare, dis-locare, dis-seminare?
La notte tra il 26 e il 27 agosto 1944 il cielo di Königsberg viene squarciato dal chiarore mortifero di fiamme ed esplosioni. La RAF sferra il suo attacco su una città pressoché allo stremo, sulle vestigia di quella che è ormai una città fantasma. Il fumo degli incendi si leva furibondo nell’aria della notte posandosi su quel che resta di macerie e cadaveri.
Il romanzo di Valentina Parisi Una mappa per Kaliningrad. La città bifronte (Exòrma, 2019, nella collana Scritti traversi)– già autrice del fortunato Guida alla Mosca ribelle (Voland, 2017) – prende le mosse proprio da questo evento: la vicenda si apre con la protagonista ferma davanti a uno schermo che trasmette la distruzione di Königsberg. Mentre guarda ossessivamente le bombe abbattersi sulla città cerca di immaginare suo nonno lì sotto le fiamme e tenta di dare un senso a tutto quello, per scacciare il senso di colpa davanti a quella sinfonia di morte e distruzione per lei ancora così intellegibile. Intellegibile, in un primo momento, è anche la città presente già nel titolo, quella Königsberg prima e Kaliningrad poi, la cui toponomastica schizofrenica e bifronte fa da fil rouge alle vicende.
Per me la parola Königsberg ha sempre avuto un sapore ben preciso: quello del vitello tonnato. Saltava fuori immancabilmente a ogni Natale.
Perfino il Natale ha quindi un carattere bifronte: da un lato c’è la classica festività che per Parisi si concretizza nella cena con i parenti e il vitel tonné; dall’altro però c’è il Natale senza vitel tonné, quello trascorso da suo nonno nello Stalag di Königsberg. I ricordi si sovrappongono, il vitello si intreccia con la sbobba e la fame nel lager; il buio familiare di Milano con l’oscurità senza luna; l’allegria della festa con l’alito di morte che aleggia sullo Stalag 1A e riaffiora nella mente e nelle parole del nonno ex soldato:
Perché mio nonno deve tornare a Königsberg ogni Natale? Perché non vuole stare con noi, adesso che è tornato? Perché soltanto a casa nostra si parla di fame a tavola?.
Parisi non può partire senza prepararsi. Inizia così ad aggirarsi nei meandri della rete, scovando documenti, fascicoli e soprattutto mappe. La sua ricerca spasmodica si trasforma in un’ossessione che travolge e ingloba la sua vita.
L’arrivo a Kaliningrad è previsto per il 9 maggio, il Den’ pobedy, il Giorno della Vittoria sui nazifascisti.
Voglio essere ovunque, a Kaliningrad come a Königsberg, ho bisogno di sprofondare nella città fino a perdermi.
Il libro si sofferma poi su una lunga e alquanto dettagliata descrizione del destino degli IMI, gli internati militari italiani. Ripercorrendo le tappe della loro cattura, prigionia e – a volte – del loro ritorno a casa, ci restituisce un pezzo di Storia troppo spesso dimenticato, quella resistenza silenziosa che fu quella degli internati militari italiani. Dopo l’otto settembre, il rifiuto di continuare la guerra al fianco dei tedeschi o di aderire alla Repubblica sociale, determina la deportazione dei soldati italiani nei campi di internamento e viene loro negato lo status di prigioniero di guerra sottraendoli così alla tutela della Croce Rossa Internazionale. Il nonno della protagonista rimarrà nello Stalag per due anni.
Quello di Parisi non è solo un viaggio alla ricerca della memoria del nonno ma anche un viaggio nella ricostruzione del Passato e della Storia. Il movente autobiografico risulta qui in espediente grazie al quale cercare di raccontare la storia di Königsberg, delle strade che la collegano, degli episodi del secondo conflitto mondiale che precedono, succedono ed esulano le vicende familiari.
Il romanzo rappresenta anche una piccola enciclopedia di citazioni sulla città che vanno dal suo illustre cittadino Kant allo scrittore russo Nemirovič-Dančenko, in cui si inserisce anche l’aneddoto su Curzio Malaparte che, inviato Königsberg per conto del Corriere della sera, si mette alla ricerca della casa di Kant per poi ritrovarsi davanti solamente a un modellino stile casa di bambola perché il vero edificio era stato abbattuto per fare spazio a una pasticceria. O ancora le poesie di Brodskij che fa della città di K., come la chiamava lui, “un simbolo universale e sovratemporale dell’inconsistenza delle ambizioni umane”. La storia della toponomastica della città emerge fra le righe:
Difficile però che Kaliningrad potesse tornare alla sua denominazione storica, e cioè Königsberg. Il primo ad accorgersene è stato Milan Kundera: «Attenzione: Kaliningrad non è stata e non sarà più ribattezzabile».
Il carattere duplice della città viene incarnato anche dalla figura dell’ippopotamo dello zoo di Kaliningrad. L’animale, sopravvissuto ai bombardamenti viene, dopo un primo momento di stupore di fronte a un essere che non avevano mai visto prima, adottato dai sovietici:
[…] gli uomini dell’Armata Rossa che il 13 aprile 1945 stanarono l’ippopotamo non dovevano intendersi granché di animali esotici, perché lo scambiarono per un enorme maiale”.
Hans, così viene chiamato, salvo poi scoprire che il suo vero nome era Rosa.
Il pachiderma, tuttavia, è malato. Il medico incaricato delle sue cure gli somministra così litri e litri di vodka (dopotutto, è pur vero che i russi sono soliti dire che «la vodka è la prima medicina»).
Quello di Parisi è un libro su Königsberg/ Kaliningrad dunque ma anche un libro sulla memoria.
Il ricordo, la memoria, sono spesso condivisi attraverso il raccontare. La molteplicità delle voci all’interno del romanzo permette una ricomposizione della Storia da più punti di vista, come quello di Erika K., una cittadina tedesca costretta a lasciare la città prima dell’arrivo dei sovietici:
Mia madre mi disse che dovevamo andare a trovare i nonni a Stoccarda. Che saremmo tornate di lì a qualche settimana. Era il novembre 1944. Ho rivisto la mia casa cinquant’anni dopo. Ma non era più casa mia.
Erika K. decide di tornare a Königsberg per ritrovare l’antica villa di famiglia che però non le appartiene più. La casa è da molto tempo abitata da estranei:
Loro hanno la casa, ma non le chiavi. Lei ha Königsberg, ma non Kaliningrad. Loro hanno Kaliningrad ma non Königsberg.
Erika K. vuole consegnare le vecchie chiavi della sua casa agli “occupanti” sovietici (ormai russi) non per riappropriarsi simbolicamente di qualcosa che le era stato tolto ma solo per porre la parola fine a tutta quella storia.
Quelli che Parisi ci mette davanti non sono che frammenti di una vicenda molto più grande. La stessa divisione in capitoli, che fa sembrare ogni blocco un racconto a sé, rimanda a questa dimensione del frammento. Sprazzi di vita in forma di ricordi, da quelli più strettamente storici con la ricostruzione della storia della città e della Seconda Guerra Mondiale, alle varie testimonianze che convergono tutte nel racconto di questo pellegrinaggio.
Il romanzo nasce dall’esigenza di fare i conti con il passato e con una vicenda che è stata tramandata. La polifonia di testimonianze e racconti aiuta la protagonista a prendere coscienza della sua “questione privata”. È solo alla morte del nonno però che Parisi decide che è arrivato il momento di affrontare quell’eredità della post-memoria che la accompagna e insieme tormenta sin dall’infanzia. Il percorso verso Kaliningrad rappresenta il suo modo di ricostruire il passato così ancora prepotentemente presente e cercare di dargli spazio. Rielaborare il passato e riattualizzarlo non tanto per riviverlo quanto per renderlo presente. Il viaggio di Parisi si va dunque a inserire in quel filone di romanzi come Ogni cosa è illuminata di o Molto forte, incredibilmente vicino di Johnathan Safran Foer. Qui la tragedia dell’Olocausto è assente ma gli espedienti e il tentativo di ricostruzione della storia personale e universale operato da Foer quanto da Parisi sono i medesimi: seconde o terze generazioni che si fanno portavoci della ricostruzione della memoria di eventi non vissuti in prima persona ma di cui diventano inevitabilmente il prodotto:
Eppure ho una sensazione inspiegabile di déjà vu, come se fossi tornata in un luogo a me straordinariamente caro. Si può fare ritorno in un posto dove non si è mai stati?
Il testo è arricchito da fotografie in bianco e nero che vanno a intrecciarsi ai racconti ed è appunto attraverso le immagini che spesso si tramanda il trauma nel contesto familiare. La fotografia e le testimonianze indirette ci riportano proprio a questa dimensione di trasmissione della memoria individuale e collettiva di generazione in generazione. Infatti, come recita una delle due epigrafi che aprono il romanzo: “La Storia comincia quando, all’improvviso, non ci sono più persone alle quali poter domandare, ma solo fonti” (Katja Petrowskaja, Forse Esther).