Un Murakami qualunque
"Abbandonare un gatto" e "Prima persona singolare"
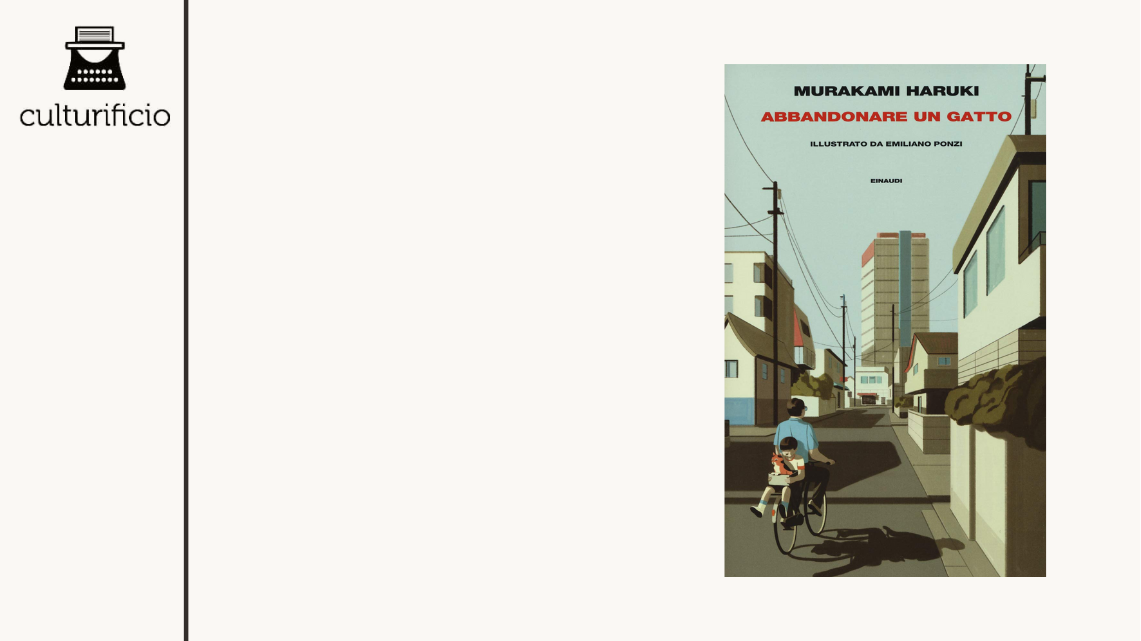
Il piccolo Haruki Murakami e il padre si recano in spiaggia per abbandonare una gatta, probabilmente perché incinta; al ritorno scoprono però con stupore (e malcelato sollievo) che l’animale li ha preceduti, è tornata a casa da sola ed è lì ad aspettarli. Con questo ricordo luminoso venato di infantile speranza si apre Abbandonare un gatto (Einaudi, 2020), breve memoir del più celebre tra gli scrittori contemporanei giapponesi, dedicato al suo rapporto con il genitore.
Con accorata intensità e il ritmo asciutto che lo caratterizza, l’autore racconta la vita di Murakami Chiaki, nato a Kyoto nel 1917, figlio di un prete buddista e destinato a diventare professore di letteratura giapponese. Molti ricordi e aneddoti si susseguono sulla sua figura sfuggente e portano la percezione di un continuo non-detto, di silenzi e interrogativi che rimangono ad aleggiare sulla biografia paterna senza che lo scrittore sembri desiderare davvero fugarli:
Se avessi insistito, ho l’impressione che qualche spiegazione in più me l’avrebbe data. Ma c’era qualcosa – l’atmosfera di quel momento, o una qualche reticenza dentro di me – che me lo impedì.
Solo un ricordo scampa all’oblio volontario: il racconto dell’esecuzione di un prigioniero ucciso con una katana a cui il padre aveva assistito (o forse a cui era stato costretto a partecipare) durante la guerra. Un trauma pesante, simbolo di tutta la sua esperienza sotto le armi, che l’uomo sente necessario condividere con il figlio, destinato a ereditare anche ciò che del genitore non sa.
Con questa e altre schegge della vita paterna di cui ci mette a parte – dal periodo come novizio in un tempio buddista al debole per l’alcol che accomunava tutta la famiglia, al suo amore e talento per gli haiku – l’autore evoca intorno alle proprie vicende private il vasto e difficile scenario del Giappone dell’epoca, illustrato con naturalezza attraverso riferimenti a tradizioni e riti buddisti, a gerarchie sociali e soprattutto, appunto, alle interminabili guerre che si succedettero nella storia nipponica di metà Novecento. Le atrocità perpetrate in quegli anni (una tra tutti, il massacro di Nanchino) e le loro pesanti conseguenze sulla vita delle persone comuni sono un tema che sta particolarmente a cuore a Murakami, che sembra riviverne lo strazio in prima persona.
È probabile, infatti, che il profondo e indistinto senso di colpa che grava sulle sue parole e che riemerge nella paura di deludere il padre, nella percezione netta della distanza generazionale e nel senso di incomunicabilità che li ha tenuti distanti per due decenni, nasca soprattutto dall’oscuro periodo militare di Chiaki, la cui narrazione occupa la maggior parte del racconto.
L’evidente processo di espiazione, spina dorsale dell’opera, permette però di veder affiorare l’altro lato della medaglia: è innegabile, infatti, l’intrinseca affinità tra i due, il reiterarsi inconscio degli stessi modelli di comportamento del genitore, il desiderio profondo di aggrapparsi a un legame così complesso. La sintesi di tale opposizione non può che essere l’accettare l’ordine delle cose:
Noi tutti non possiamo che respirare l’aria del nostro tempo, sopportarne il peso e crescere dentro la sua cornice. Non è né un bene né un male, semplicemente funziona così. Allora come adesso, i giovani si comportano in maniera irritante per i loro genitori.
Pur non trattandosi di uno tra i romanzi migliori dello scrittore giapponese, né quello più adatto per iniziare a conoscerlo, Abbandonare un gatto è un compendio necessario alla sua opera omnia che ci svela un lato reale (o realistico) perfettamente coerente con gli straordinari mondi paralleli a cui ci ha abituato.
Nell’edizione italiana la fascetta rossa che riporta a caratteri cubitali il fatto che si tratti di un «Murakami inedito» dà una prova piuttosto concreta dell’operazione editoriale che Einaudi ha orchestrato in questa pubblicazione; per quanto architettata a tavolino però, l’iniziativa riesce, oltre che per i contenuti in sé, per il contributo delle eleganti e raffinate illustrazioni di Emiliano Ponzi, che incorniciano come «polaroid invecchiate dalle tinte pastello» (così le definisce l’artista) le ottanta pagine scarse offerte nell’ottima traduzione di Antonietta Pastore.
Lo stile sempre limpido, distaccato, semplice in modo quasi spudorato, che ogni lettore di Murakami conosce bene, trova qui perfetta consonanza con la materia del narrare, volutamente (ricercatamente, oserei dire) banale e comune.
Il punto è che il senso del libro è tutto lì: non c’è alcun messaggio sottinteso da interpretare, e lo stesso autore lo ribadisce con forza sia nella conclusione sia nella postfazione/dichiarazione di intenti: tutto ciò che desiderava era raccontare il suo personale «frammento anonimo della storia», mostrare il suo essere un uomo qualunque, figlio di un padre qualunque.
Per una (stra)ordinaria catena di casualità, in cui anche un singolo tassello diverso avrebbe stravolto tutto, Murakami esiste in quanto tale, e scrive. Non c’è altro, né nella vita degli individui, né nella storia umana. In queste poche affermazioni, tuttavia, ci sono più cose di quante ne sogni la tua filosofia, Orazio: qui è cristallizzata l’essenza stessa della poetica di Murakami, e insieme, uno dei punti nevralgici del pensiero orientale, sia civile che spirituale.
Un gattino bianco si arrampica sopra un altissimo pino nel giardino di casa. Haruki bambino lo guarda divertito; subito dopo, però, l’animale inizia a piangere: non sa più scendere, e nessuno può soccorrerlo, è troppo in alto. È abbandonato al suo destino: sparisce tra il fogliame e la mattina dopo nessuno sa se sia sopravvissuto.
È un ricordo della mia infanzia che mi ha lasciato una forte impressione. Inoltre, mi ha insegnato una cosa importante: nella vita, scendere è molto più difficile che salire. In termini più generali, spesso il risultato va al di là dello scopo e lo rende inutile. A volte è un gatto a restare ucciso, a volte un essere umano.
Dopo questo breve libro Murakami non abbandona la nuova tendenza intimistica: anche la sua più recente raccolta di racconti, edita da Einaudi nella traduzione di Antonietta Pastore, dal non casuale titolo Prima persona singolare (2021), trae linfa dalle vicende personali, ma con una svolta nuova e decisamente più interessante.
In quella che può considerarsi una sorta di sintesi hegeliana, infatti, lo scrittore declina stavolta la vena autobiografica nel contesto del realismo magico a cui ha abituato i suoi lettori. Se i racconti si dimostrano sin dalle prime battute chiaramente improntati alla sua poetica più genuina, nella quale si intrecciano iperrealismo e fantastico onirico, il fatto che in ognuno degli otto brani a dire io sia un certo Murakami Haruki, nato a Kyoto, di professione scrittore, rende il gioco volutamente più straniante e assorbe il lettore in una divertita girandola in cui si finisce per credere alle narrazioni più irreali e a sospettare della storicità di quelle più verosimili.
Nella sua scrittura asciutta, velata di sottile ironia, lo scrittore torna a lambiccarsi con i suoi temi più canonici: mentre figure femminili evanescenti – alcune bellissime oltre ogni dire, altre decisamente brutte – appaiono e scompaiono in lampi epifanici e l’irrinunciabile colonna sonora risuona di continuo, da Charlie Parker a Beethoven, dai Beatles a Schumann, Murakami riflette instancabile su amore e morte, solitudine, memoria, senso di colpa, maschere e identità.
E tuttavia il senso ultimo delle carambole letterarie che imbastisce – che si tratti di scimmie parlanti o di pessime poesie sul baseball, di anziani nel parco che annunciano oscure profezie sui cerchi o di inesistenti (o forse sì?) registrazioni di Charlie Parker che suona la bossa nova –, in fondo, non c’è. Proprio come non c’era nella narrazione del romanzo precedente. Ed è ciò che, ancora una volta, allo scrittore giapponese preme comunicare, il nucleo sostanziale di ogni suo scritto:
A volte succedono, queste cose. Cose senza senso e senza spiegazione, che riescono però a turbarti profondamente. Quando capitano, bisogna chiudere gli occhi e lasciarle passare senza pensare a nulla, senza fare nulla. Come se scivolassimo sotto una grossa onda.
Haruki Murakami, ormai settantaduenne, trova dunque qui il perfetto compimento nel fondere le sue due anime; ben oltre l’autobiografismo di Abbandonare un gatto, in uno straniamento dello straniamento, al sicuro nell’alveo del suo mondo immaginifico e allucinato, si sente – e lo sentiamo – finalmente libero di raccontarsi davvero, di mostrarsi nella sua profondità. Che poi racconti il vero o il falso, davvero non importa.