Azzurro (ovvero acqua, isole, nuvole) – Antonella Cilento
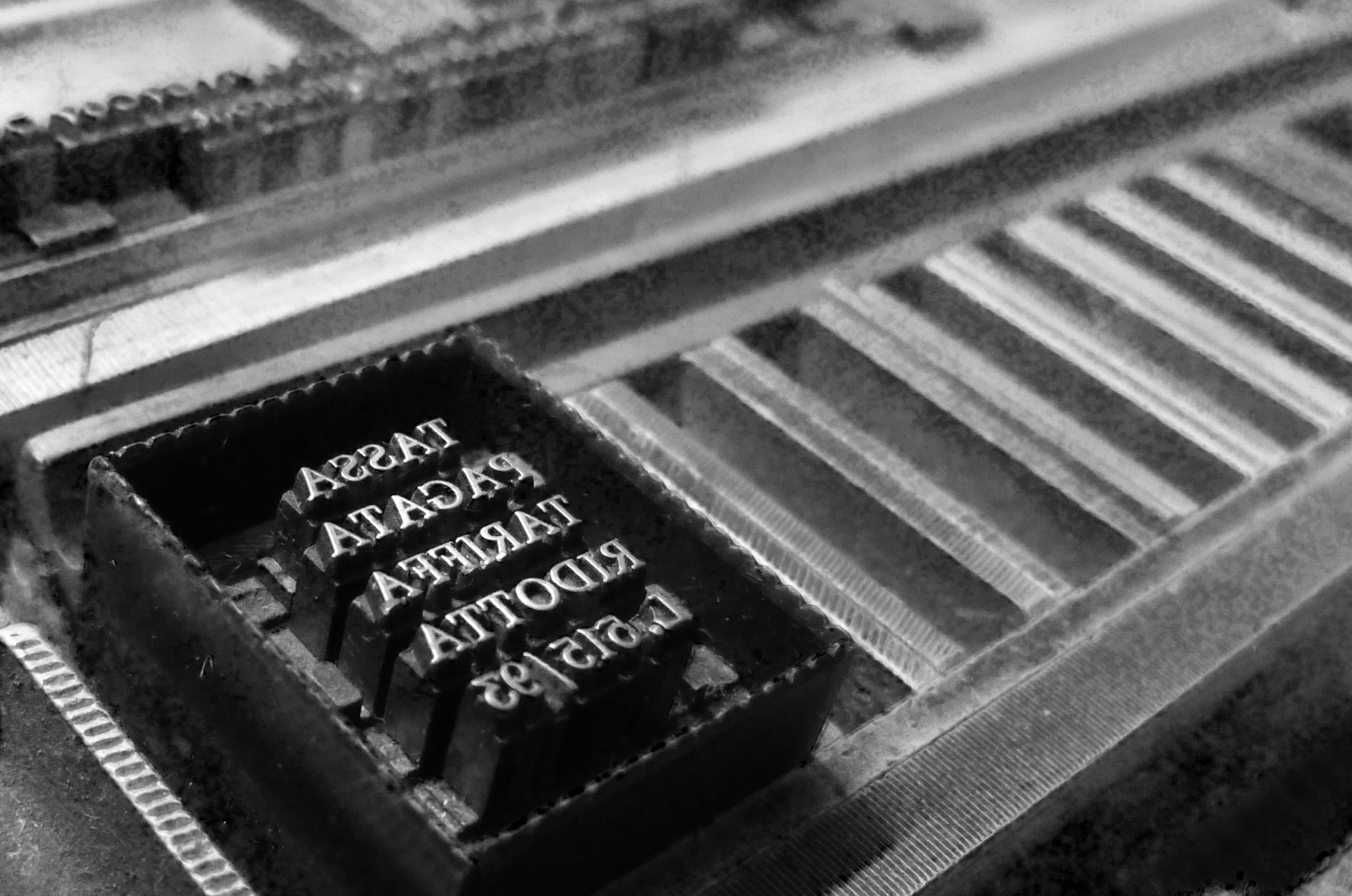
La scrittrice Antonella Cilento ci parla di “azzurro”, una parola che definisce il colore dello spazio in cui si muove la sua immaginazione.
Delimita il confine l’azzurro.
Tutto l’azzurro che posso vedere da una finestra, una finestra traversata da nuvole immense, come grandi fazzoletti.
La mia famiglia affacciata al balcone della camera da letto, genitori, nonni, zie, il passato davanti a me. Il ricordo è antico, un Natale azzurro che raccoglie i parenti dalle disperse isole d’Italia, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dall’Emilia, dal Friuli, e li raduna tutti sul mio balcone, sulla mia isola fatta di molti azzurri, i tratti di mare e cielo che si vedono sporgendosi dal salotto, le isole alla fonda nel golfo dal bagno.
C’è azzurro, fatto d’isole, cielo e mare, anche dalla casa della bisnonna, a La Maddalena, e attraverso quel colore che da trasparente diventa nero, salgono le sirene delle navi e delle barche che escono per la notte.
Fino a che l’azzurro delimita un capo, un lago, la prospettiva delle terre, mentre la vita è insopportabile, c’è anche la scrittura.
Tutto è azzurro nello spazio in cui cresce la mia immaginazione.
Ha a che fare con il corpo celeste di ortesiana memoria e con un’espressione che è in Ingeborg Bachmann e che viene da Georg Trakl: «la fiera azzurra».
Dentro di noi si muove incontenibile e eterna una fiera azzurra.
Una mia rubrica su Repubblica, in anni recenti, s’intitola La lente azzurra, modificazione di un altro titolo ortesiano, La lente oscura.
In certi giorni, l’azzurro è acqua. E se non acqua isole, altra parola d’infanzia e di senso. Acqua di mare, acqua termale. L’acqua mentre scrivo è ovunque. L’acqua e l’azzurro scorrono in tutti i miei libri, in ogni racconto, nei libri che non sono romanzi ma pamphlet, o viaggi sentimentali dentro Napoli. L’acqua delle terme di Baia, l’acqua sotterranea del tempio di Mercurio, abitata da pesci, dalle rifrazioni luminose dei lacunari della volta e dall’eco delle voci. Di solito ci vado a cantare, è il mio luogo di preghiera e magia.
L’acqua che dorme in Morfisa o l’acqua che dorme, capace di passare dal mare ai rubinetti, dalle fontane alle vasche da bagno, dall’anno Mille ai giorni nostri apocalittici, un’acqua che viaggia nel tempo e nello spazio, l’acqua delle ultime sibille.
Oppure l’acqua del mare che traversa Lisario, in Lisario o il piacere infinito delle donne, per liberarsi di Napoli, di un marito molesto, della condanna delle femmine, per arrivare su un’isola dove vivere la sua illusione d’amore.
Azzurri sono gli abiti delle donne nei miei romanzi, Aquila, Lisario, Morfisa, come manti di Madonna.
L’acqua delle isole senza mare nel romanzo omonimo, che corre nella memoria e, come le nuvole si specchiano nel mare, insegue la storia di Aquila, nobildonna decaduta destinata alla prostituzione nella Roma papalina, quella dell’isola de La Maddalena dove abitavano le antenate, le centenarie, dove si viveva davvero isolati e azzurri.
L’acqua sotterranea e rossa del Tunnel borbonico ne La paura della lince.
L’acqua marina dei Campi Flegrei, che circonda il Castello di Baia in un romanzo rimasto inedito, Ora d’aria, ambientato negli anni del fascismo in cui il castello fu orfanotrofio militare, la stessa acqua e lo stesso Castello in cui cresce, muta, a metà del Seicento Lisario e in cui inizia La paura della lince ai giorni nostri, con un incendio che quasi ammazza il custode muto, Nino.
Del resto, si trattasse anche di nuvole, sempre di acqua e azzurro parleremmo.
E sempre di isole che passeggiano libere nel cielo. Isole volanti.
Ogni volta che rileggo Le bave del diavolo di Cortázar mi riconosco.
Mentre Michel, fotografo e traduttore, narra delle scoperte spaventose che si fanno ingrandendo gli scatti che credevamo innocui, passano, fra parentesi, le nuvole.
No, non si può riassumere il lavoro di una vita in una parola: campionare le parole ricorrenti è gesto inerme quanto definire il carattere di un uomo dalla conta dei suoi globuli rossi. Però, si può circoscrivere quel mazzo di parole che ti vengono in aiuto quando rientri in te per immaginare.
A Napoli per fare il brodo i fruttivendoli ti vendono ’o mazzetto: cipolla, sedano, carota legati con lo spago. Il mio mazzetto è azzurro, fatto di acqua, isole e nuvole.
Poi, che brodo ne venga fuori è tutt’altra questione.
Perché questo brodo a volte contenga ceroplasti tarati o pittori della candela, maestri celebrati come Breughel o misconosciuti come Michael de Sweerts; perché s’addensi in ragazzine sfottenti, allegre e vogliose o in tormentati e infelici giovani omosessuali; per quale ragione navighi nel Seicento o faccia a gomitate coi nostri anni infelici e trafficati, non si può dire, dire e basta.
Quel che era da dire è stato lavorato per molti anni ed è nei libri editi e nei quaderni inediti.
Di quest’enorme castello di memorie, invenzioni, tessuti e trame che siamo, faranno pasto i pesci, quelli del mare o della polvere, non importa.
Era questo, diremo, che ci rendeva fertili e felici, eccitati, tristi, innamorati: l’ossessione, la speranza, il desiderio di pronunciare, catturare (o forse liberare) un’immagine.
da Isole senza mare, Guanda, 2009
La Maddalena della mia infanzia è mare trasparente come un pensiero primo.
È verde intenso di mirto, granito rosa bollente, profumo di formaggelle, spiagge vuote e silenziose. Si arrivava al mare faticosamente percorrendo strade senz’asfalto. Spalmatore, Punta Rossa, Monte d’Arena, Carlotto, il Polipo: sudati e storditi, con l’ombrello aperto per non scottarci, allunavamo sulla sabbia finissima e argentata, color tuta di astronauta, che scivolava sotto una tavola d’acqua trasparente. Punta Rossa era una spiaggia magra e lunga come una costola di capra, spinta a lama nel celeste. Era chiamata anche I Due Mari, perché l’acqua era tempestosa a occidente, calma e cristallina a oriente. Sul fondale fiorivano colonie di coralli e rarefattissime alghe a pennello. Il mare, lì, era sempre gelato: «¡Oggi i pesci vanno in cappottino!¡» si esclamava ogni volta, all’arrivo.
[…]
Aquila alzò la gonna, tolse le scarpe e scese nell’acqua fino alle ginocchia. Tutti seguirono l’abito azzurro immergersi. […] Aquila calò la testa nel tino, fino a toccare il vetro quasi con il viso. Sotto di lei il mare era una voragine blu: la costa calava a picco veloce, le rocce fumigavano di lilla e di verde, pesci guizzavano argentei, visioni improvvise. Spalancò gli occhi, come se l’acqua potesse allagarle le cornee: due meduse, le terribili e urticanti caravelle portoghesi, belle come l’abito di una principessa, veleggiavano serene verso il largo, sfiorando appena la nereide di marmo, seduta sulla schiena di una pistrice. Il mostro marino dalla bocca seghettata avvolgeva le spire squamose sul fondo. Saraghi, polpi e una miriade di pesciucoli senza nome che tracciavano spigoli fuggendo a zig zag nell’azzurro profondo erano intorno alla statua alessandrina. Aquila visse, per un attimo, la vorace ossessione di Campana: voleva avere la donna nascosta dal mare, voleva essere la nereide. Nulla era così perfetto, immoto e segreto come il cuore pulsante del marmo nascosto dal mare.
Antonella Cilento (Napoli, 1970) finalista Premio Strega nel 2014 con Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori), ha pubblicato numerosi romanzi, raccolte di racconti, reportage storici.
Dirige da ventisette anni una delle più antiche scuole di scrittura italiane, Lalineascritta Laboratori di Scrittura, e coordina da tre anni il primo master di scrittura e editoria del Sud Italia, SEMA, con Università Suor Orsola Benincasa.
Dirige da dodici anni la rassegna di letteratura internazionale STRANE COPPIE.
Scrive per il teatro e «La Repubblica – Napoli».
Di parola in parola è una rubrica a cura di Emanuela Monti. Dalla nota introduttiva è possibile scaricare l’archivio della rubrica, uscita finora in forma cartacea nella rivista «Qui Libri».