“Giorni maledetti” di Ivan Bunin
l’Apocalisse indossa una camicia rossa
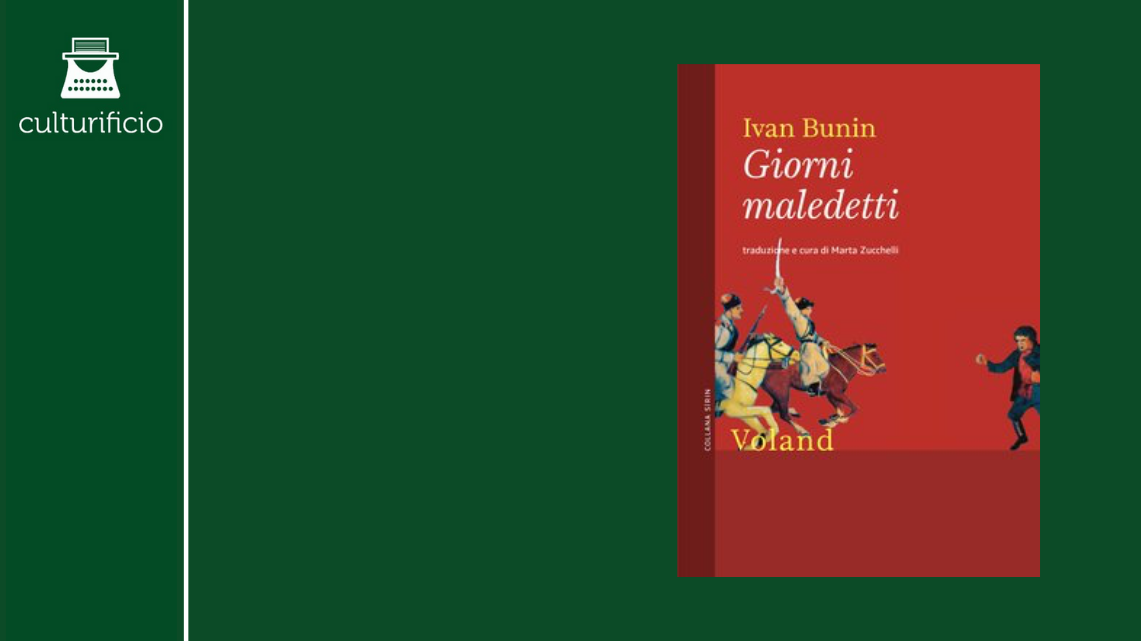
Questo anno maledetto è finito. E ora? Forse qualcosa di più terribile ci attende. Credo sia proprio così».
È con la fine del funesto 1917 e il presagio di rovinose sventure che si apre Giorni maledetti (Okajannyje dni) di Ivan Bunin, pubblicato per la prima volta in forma parziale nel 1925 a Parigi su «Vozroždenie», ora finalmente nelle librerie italiane grazie a Voland e alla traduzione di Marta Zucchelli.
La descrizione di questi giorni maledetti è affidata ad appunti su fogli sparsi che coprono le turbolente vicende russe postrivoluzionarie e la successiva guerra civile.
La narrazione, che prende la forma del diario di una penna stanca e disillusa, si divide in due parti: la prima copre il racconto di una Mosca spettrale in balìa di forze distruttrici e va dal gennaio al marzo 1918; la seconda, che si staglia sullo sfondo di Odessa, luogo in cui Bunin cerca rifugio, testimonia i fatti dall’aprile al giugno 1919.
Reazionario e fervente anticomunista, lo scrittore, nella Grande Guerra Patriottica che imperverserà sul suolo russo dal 1917 al 1922, si schiera dalla parte dei Bianchi. Di lui, dirà Tzvetan Todorov nel suo L’arte nella tempesta: «prova un rifiuto viscerale e immediato per tutto ciò che è rappresentato dalla rivoluzione». Quei fatidici “dieci giorni che sconvolsero il mondo” sconvolgono anche Ivan Alekseevič, costretto ad assistere all’ormai inevitabile declino della nobiltà terriera di cui la sua famiglia fa parte e alla vittoria di quel popolo, ai suoi aristocratici occhi, tanto rozzo e animalesco.
E non è dunque un caso che questo diario così antirivoluzionario e critico nei confronti del potere sovietico sia apparso in Russia solo con l’avvento della perestrojka e del conseguente allentamento delle maglie della censura.
Possibile che molti non sapessero che la rivoluzione altro non è che la versione sanguinosa del gioco della sedia, con il popolo che, sebbene per un po’ gli sia riuscito di sedersi, bere e far baldoria al posto del signore, finisce sempre per cadere dalla padella alla brace? (p. 135).
I proprietari terrieri si vedono sfilare la terra da sotto i piedi, le case dei borghesi vengono requisite e gli appartamenti occupati e ridistribuiti, le forze filozariste sono contrastate da una marea rossa e cenciosi mužiki (così venivano chiamati i contadini in epoca prerivoluzionaria) si trasformano in capi. La Rivoluzione d’ottobre ha spazzato via quell’età dell’oro in cui una ragionata gerarchia stabiliva ruoli e assegnava ricchezze, quel tempo in cui Bunin sapeva di essere un padrone e di avere dei servi di cui disporre.
L’ondata rivoluzionaria colpisce non soltanto la struttura politica ma si infrange anche sulla sfera del quotidiano. Comincia infatti una serie di riforme che modificano la scansione del tempo, le unità di misura, il sistema monetario, l’alfabeto ma anche la lingua. È proprio sull’aspetto linguistico di questa nuova Babele che Bunin si sofferma. Che fine ha fatto la nobile lingua russa martoriata dal giogo futurista di parole prive di misteriosa e fulgida bellezza? I vari Majakosvkij, Blok, Gor’kij, non sono che feccia traditrice al soldo del nemico della Russia. Perché i poeti si ostinano a farcire di espressioni pseudo arcaiche i loro componimenti? E, soprattutto, da quale antro maledetto è uscito il sudicio gergo bolscevico? A questi aspri e pungenti pensieri però si affiancavano sprazzi di pura poesia. È nei momenti in cui lo scrittore si sofferma sulle foglie di un albero i cui rami si poggiano su un bianco e polveroso muro o quando, alzando lo sguardo in una cupa notte, scorge il barbaglio dei raggi lunari che le pagine si riempiono improvvisamente di un delicato lirismo, quello stesso lirismo che ritroveremo nel suo capolavoro, la raccolta Viali oscuri del 1946.
La brutalità e la volgare violenza dei soldati che ciondolano per le strade, tronfi e ubriachi, porta Bunin a istituire un parallelismo fra questa rivoluzione e quella francese e il seguente periodo del Terrore. L’odio covato da tempo dal popolo russo nei confronti della borghesia e delle élites è la manifestazione di mostruosi istinti che possono nascere solo in una belva. Il radioso avvenire auspicato da chi ha visto la propria libertà soccombere sotto i privilegi altrui rappresenta per lo scrittore l’ombra dell’umana infelicità.
Finalmente, nel 1920, riesce a riparare insieme alla moglie Vera verso la Francia ed entra a far parte della folta schiera dei cosiddetti émigrés che popolano le vie della ville lumières. La scelta di definirsi émigrés e non esuli era determinata dall’idea che la Rivoluzione fosse certo una sciagura, ma un fenomeno passeggero, e che gli intellettuali russi presto sarebbero potuti tornare nell’amata patria, ora martoriata dai bestiali artigli del demonio. Nel 1933 Bunin diventa il primo scrittore russo a essere insignito del Premio Nobel. Dopo di lui toccherà a Boris Pasternak che con il suo Il Dottor Živago mostrerà i lati oscuri della Rivoluzione; ad Aleksandr Solženicyn e alla sua denuncia degli orrori del gulag e al “parassita” Iosif Brodskij, ognuno a suo modo in esilio.
La morte dell’autore, avvenuta nel 1953 proprio a Parigi, non è che l’emblema di quel beffardo destino che ha distrutto le illusioni di molti spezzando per sempre il fisico legame fra l’uomo e la terra natìa. Il sogno di un ritorno a una Russia prerivoluzionaria svanisce e la sua chimerica nebbiolina si dirada lasciando il posto a uno squarcio nella brulla terra dal quale sgorga inesorabile la barbarie.
Ho sognato di trovarmi in mezzo al mare, in una notte azzurra, scialba e lattiginosa, e vedendo le luci rosa pallido di un piroscafo mi dicevo che dovevo ricordarne il colore. A che serve ora tutto questo? (p. 131).