“L’ora di greco” di Han Kang
la Bellezza senza contorni e senza parole
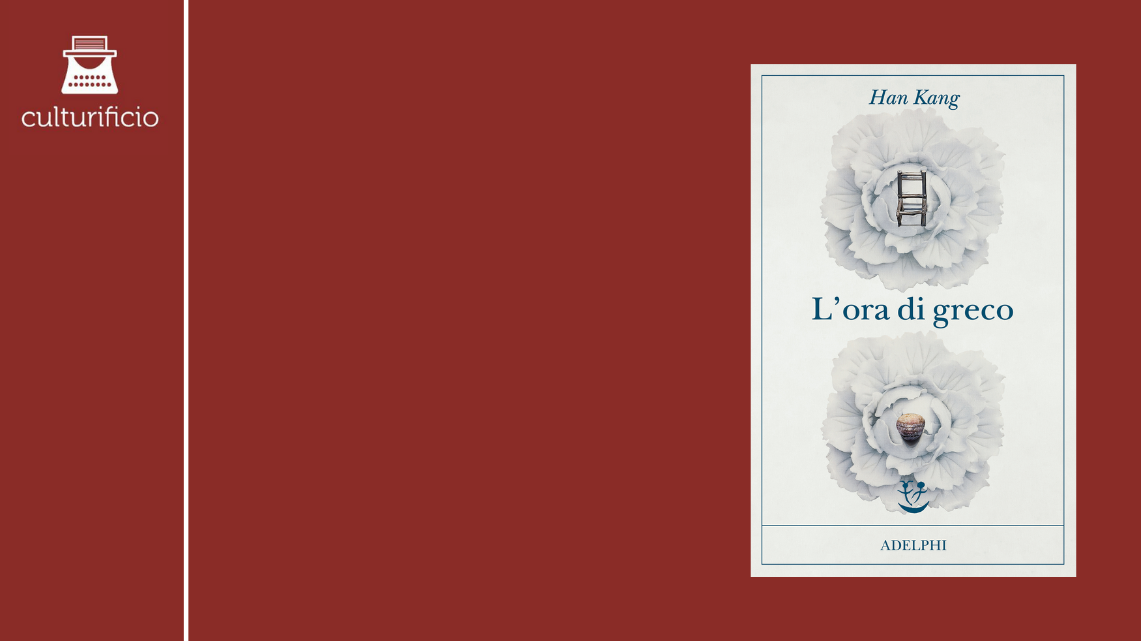
Il tempo della sofferenza si trasforma in tempo della conoscenza nell’ultimo romanzo della scrittrice sudcoreana Han Kang, L’ora di greco, tradotto per Adelphi da Lia Iovenitti. Sulla scia di un’espressione suggerita dalla tragedia greca, il Páthei Máthos, la scoperta del mondo attraverso il dolore si fa inaspettatamente sogno e stupore per i due protagonisti di queste pagine.
La città di Seoul definisce uno sfondo senza consolazione tra sguardi in direzioni opposte, gomitate distratte nella fretta, giornali a riparo dei senzatetto, luci delle auto sbiadite dalla pioggia, malinconia di qualcosa che non ha neanche un nome, ma che fa da muro tra sé e il senso delle cose. La protagonista attraversa queste strade avvolta nel colore nero a cui aveva ridotto tutto il suo guardaroba dopo la scomparsa della figura materna. Il tremore delle labbra e una fascia viola al polso, premuta su una cicatrice indicibile, restituiscono una nota di interesse alla sua figura altrimenti vitrea. Insieme alla madre, la donna perde l’affidamento del figlio di sette anni. In questa coincidenza senza appello anche la sola cosa che la tenga viva al mondo, la parola, la abbandona. Era già accaduto venti anni prima, in un tempo il cui ricordo era rimasto puntellato al termine Bibliothèque, termine trascritto alla lavagna senza troppa attenzione dal professore di francese e compitato con spavento e sollievo dalle labbra di lei, a lungo rimaste serrate. Allora si era consegnata a una lingua nuova, il francese, per recuperare le sillabe perdute, ora assegna alla lingua greca la possibilità di decidere chi sarebbe stata.
Le uniche cose che, facendo appello a tutte le sue forze, riesca a strappare al gelo del silenzio sono il viso del figlio, con cui è autorizzata a passare una notte ogni due settimane, e le parole di quella lingua morta che quasi incide nella carta con la matita.
Il greco è scelto perché lingua inconsueta, dalle regole circostanziate e dalla precisione radicale, in cui la narrazione del mondo si affida all’autosufficienza di ogni singolo vocabolo, declinato o coniugato in modo inequivocabile. Un linguaggio tanto perfetto quanto scevro di semplificazioni, al punto da perdere i contatti con il contingente.
La solitudine del silenzio e la conseguente conoscenza di una lingua inedita avvicinano lei all’altro protagonista del romanzo, il professore di greco.
Appassionato di Borges e della «spada» tra lui e il mondo rappresentata dalla cecità, l’uomo ha quarant’anni, una parte dei quali vissuti in Corea, una parte in Germania, un po’ trascorsi nella luce, un po’ nell’ombra. Anche a lui spetta una privazione, quella della vista, attesa tra l’orrore delle immagini smarginate e la possibilità salvifica del ricordo, come quello delle lanterne in una sera di Seoul e del loro ostinato color oro su di un cielo scuro. Un’idea di Bello che il suo amato Platone aveva raccomandato solo a un mondo ideale, perfetto nella sua distanza dal presente, come il volo delle lanterne, come la lingua greca.
E questa Bellezza senza orli e senza segni è ricercata ossessivamente dai due nel corso delle loro vite parallele ma coincidenti nella lezione di greco di ogni giovedì.
Lei rintraccia bellezza nel caleidoscopio architettato da bambina con i rettangoli di uno specchio ricomposti a forma esagonale.
Era rimasta immediatamente incantata dallo strano universo che si dispiegava all’interno ogni volta che accostava un’estremità all’occhio e lo agitava.
Da quando aveva perso l’uso della parola, ogni tanto quell’universo le appare davanti agli occhi sovrapponendosi al mondo reale.
Lui recupera bellezza nel sogno di una pioggia dal profilo di perle, nel sogno di una lettera in braille di un amico scomparso troppo presto, ma ancora convinto che bello fosse il reale, la sua gente viva, l’onore del sole a ogni mattino, il fresco nei polmoni, un tram che avrebbe portato lontano lui dal suo male incurabile.
Non c’è altro mondo al di fuori del sogno dove potrei fuggire di nuovo.
È quanto lui si dice a occhi aperti ma a immagini negate, sperando in un oltrevita.
Eppure l’ora di greco si rivela per entrambi l’intesa inconsapevole nello spazio tra banco e lavagna, nella stretta simultanea di un gessetto polveroso da parte dell’uno e di una matita corrosa da parte dell’altra, a voler ricalcare nei caratteri greci, sulla lavagna e sul quaderno, la sola perfezione ancora possibile mentre tutto si avvolge in un groviglio. Nel risvegliarsi di una lingua che intuisce la perfezione e ne sa fare norma, la donna e l’uomo restituiscono al silenzio e alla cecità un senso e un’intenzione. Non sono privazioni subite, le loro, ma volute, come un carapace dentro cui ripararsi per non vedere, per non sentire un mondo distratto da sé stesso.
Come nel romanzo La vegetariana (vincitore del Man Booker International Prize nel 2016, Adelphi, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra), dove Han Kang aveva presentato una donna che aveva manifestato la sua potente volontà di svanire progressivamente dal mondo fino a trasformare le proprie mani nelle radici di un albero e il corpo nel fusto e in una chioma alta a respirare cieli, anche qui riconosciamo un tentativo dei personaggi di andare verso l’evanescenza.
«La sua voce era priva di peso come una piuma […] Era il tono calmo di una persona che non appartiene a nessun luogo, di qualcuno che è entrato in una zona di frontiera tra diversi stati dell’essere» (La vegetariana).
Oltrepassare le sbarre che gli altri ignorano perfino, lasciarli tutti prigionieri di un tempo che serra il cuore e impone una stretta, forzare il confine e trasumanare in un sogno di colline, zolle, fusti, creste, foglie in cui ci si invola per non esserci più tra vuoti e inganni, diventa la direzione più vera e più giusta suggerita dai personaggi di Han Kang. Si tratta del solo viatico verso la Bellezza, quella impronunciabile esperienza che attendiamo da sempre e per sempre, senza mai sperimentarne il privilegio imperituro in questa vita. Chi vuole raggiungerla, può solo affidarsi a una rinuncia di immagini, colori, luci, fonemi, sillabe, voci contingenti. Può solo affidarsi a un foglio bianco su cui tracciare le parole di una lingua, quella greca, che non si lascia sfiorare perché si sottrae alle contaminazioni del presente.
Chalepà tà kalá.
Le cose belle sono difficili.
di Maria Cristina D’Alisa