Michael Kimball, “Big Ray”
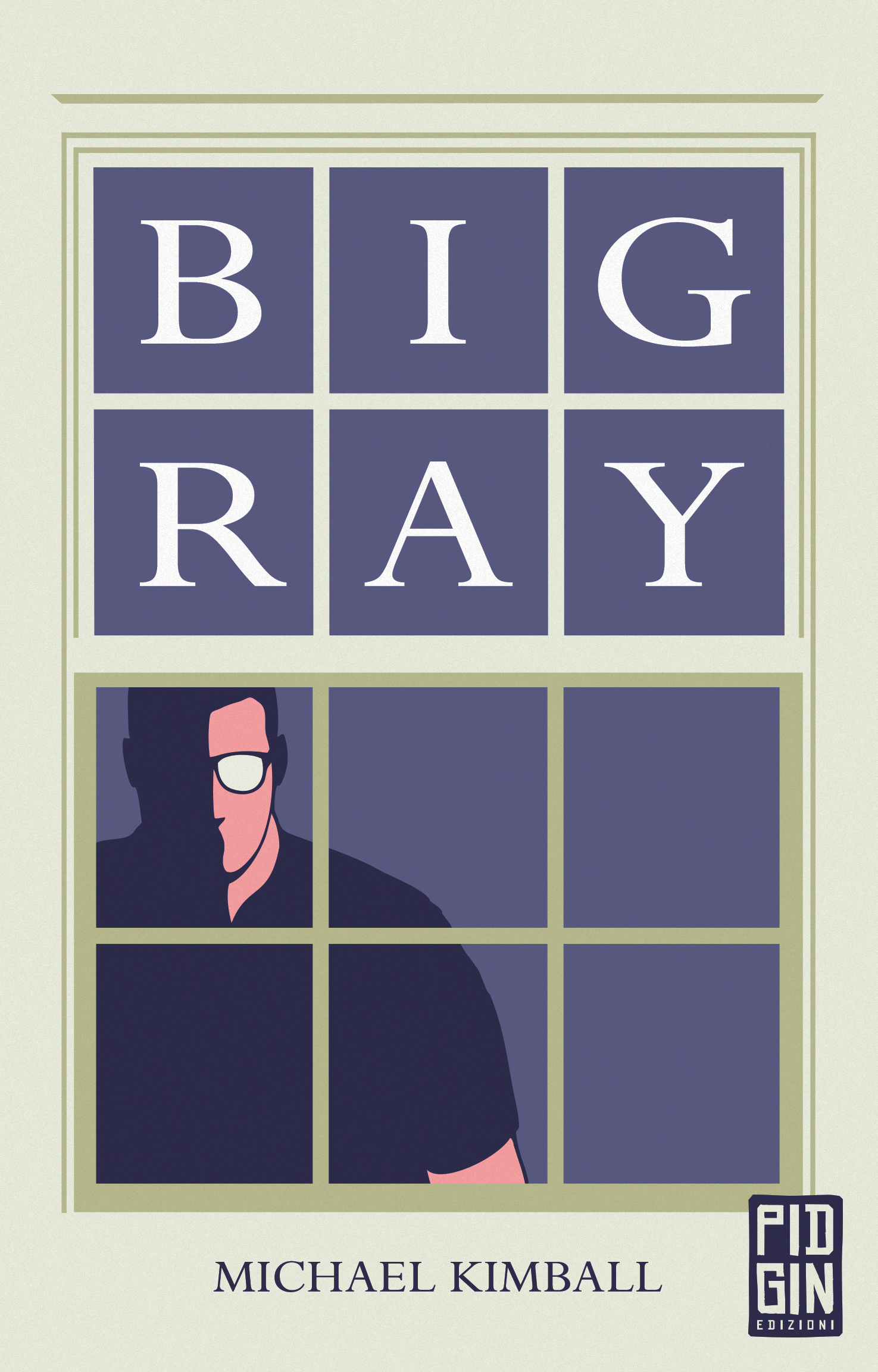
Personalmente, temo e desidero con la stessa intensità sapere cosa davvero pensi mio padre di me, come una specie di Odi et amo catulliano. Credo che, senza far di tutta l’erba un fascio, sia un desiderio molto comune tra gli adolescenti, ma non solo: non si smette mai di voler piacere al proprio padre, c’è “una forte pulsione a farti piacere tuo padre o tua madre, che tu lo voglia o no” scrive infatti Michael Kimball, autore di Big Ray (Pidgin, 2019), semplificando efficacemente una sensazione che è davvero difficile che non si sia provata almeno una volta. Il protagonista del libro in questione, dopo la morte del padre, si trova ad analizzare quello che è stato il suo difficile rapporto con lui e, riflettendo su suo padre, riflette su sé stesso, offrendo a noi lettori una tortuosa panoramica di una dinamica familiare incredibilmente disfunzionale, descritta attraverso un’analisi mai gridata e sempre lucida, molto intrigante, tanto che il libro può anche essere letto come un giallo psicologico, dove il lettore accumula dettagli e batte varie piste, formula diverse ipotesi su chi davvero fosse il padre del protagonista e cosa possa aver fatto, ma, soprattutto perché ha fatto ciò che ha fatto. Ecco il grande nucleo del romanzo molto intenso di Kimball: se credo che mio padre sia stato cattivo con me, perché lo è stato?
La trama è semplice: il protagonista, dopo la morte di suo padre, riflette su quello che è stato il suo rapporto con lui, riportando a galla episodi, aneddoti, sofferenze e gioie (rare) che hanno formato il loro rapporto padre-figlio. La configurazione del libro è molto interessante; è infatti costituito da piccoli frammenti di considerazioni/pensieri, microparagrafi lunghi al massimo una decina di righe, spesso dallo stile epigrammatico, che danno al romanzo l’aspetto quasi di un referto, uno scritto dallo stile essenziale e scarno, ammorbato da un’aria di secca e ineluttabile morte dalla quale il protagonista cerca di uscire, con l’analisi e la riflessione, attraverso la ricostruzione di un mosaico assai complesso come quello che è stato il rapporto con suo padre. Pagina dopo pagina noi lettori raccogliamo tessere preziose per cercare di ricomporre l’immagine di un uomo incredibilmente ingombrante (sotto ogni punto di vista e tra poco vedremo il perché) e il flusso di questa indagine in pieno stile romanzo giallo è coinvolgente e strano, sempre sul punto di scoppiare in qualcosa che, spesso e volentieri le laconiche e tristi considerazioni del figlio che ricorda il padre morto, disinnescano.
Non capisco i miei sentimenti complicati nei confronti di mio padre. Lo odiavo, ma volevo piacergli. Mi vergognavo di lui, ma volevo che fosse orgoglioso di me.
Il padre del protagonista è obeso, ecco perché è chiamato da tutti Big Ray. Big Ray, ci viene fatto capire dal resoconto del protagonista, era un uomo, un padre, che non solo occupava molto spazio, ma lo toglieva anche agli altri, a suo figlio, alla figlia, a sua moglie. L’ombra gigante e cattiva di un uomo che avvolge tutto e influenza negativamente l’assetto familiare. Un padre disgustoso, meschino, violento, pigro e fallito, visto dai figli in mutande, grosso, a grattarsi mentre cucina uova e bacon e il grasso che schizza ovunque in cucina: la scrittura di Kimball riesce ad essere soffocante, spregevole per quanto si addentra fin dentro il midollo osseo delle idiosincrasie del protagonista legate al padre, ma fa di più, le complica e le rende labirintiche, perché il protagonista lo odia suo padre, ma se solo riuscisse a capirlo, se solo trovasse un perché a tutta quella cattiveria…
[…] Non avrei riso della grassezza di mio padre se non fosse stato così cattivo: mi faceva sentire bene ricambiare la cattiveria.
A volte, di mattina prima della scuola, mio padre guardava come ero vestito e diceva” Stai alla grande.” Questo mi faceva sempre sentire molto bene.
George Saunders, scrittore americano, nell’introduzione alla raccolta di racconti intitolata Bengodi scrive una cosa bellissima che, parafrasando, suona più o meno come: realizzati e fai ciò che ti piace, sii soddisfatto della tua vita e di ciò che hai fatto, e rendi tutto questo un imperativo categorico perché altrimenti tutta la tua frustrazione, la tua delusione, il tuo vuoto esistenziale per non essere diventato ciò che volevi diventare, potresti sfogarlo sulle persone che ti sono più care e più vicine, ovvero potresti sfogarlo su tua moglie, sui tuoi figli, e li farai soffrire molto, nella migliore delle ipotesi, li distruggerai, nella peggiore. Big Ray, riversa tutti i suoi dolori psichici sulla sua famiglia, lasciando pendente sulla testa del protagonista una spada di Damocle tremenda: tale padre, tale figlio?
Kimball dedica il libro “al suo papà morto” e la stessa espressione “papà morto” compare almeno venti volte nel romanzo: la morte di padre è un evento traumatico che plasma tutta la struttura del libro, andando a influire sulla configurazione del romanzo, sul ritmo del libro, sulle sensazioni e sui pensieri del protagonista; è, in poche parole, totalizzante e annichilente, diventa concetto. E dopo la “morte di padre” il protagonista non può che constatare che tutta quanta la sua vita è stata penetrata da questo concetto, e che questa penetrazione ha lasciato un seme doloroso, ma probabilmente non sterile: forse sboccerà qualcosa di nuovo nella sua consapevolezza, forse sarà pronto ad accettare cose che non avrebbe mai potuto accettare con suo padre in vita.
Mi allaccio le scarpe la mattina e papà è morto. E’ ora di pranzo e papà è morto. Raccolgo la posta e papà è morto. Fuori c’è il sole e papà è morto. Adesso sono felice e papà è morto.
Duecentoventisette kg di peso, diabete mellito, speroni ossei, bara Golia, impedimenti fisici umilianti e raccapriccianti, il figlio ci dice questo sul padre, senza censure, e ciò colpisce perché, così facendo, lo scrittore ci consegna un’emozione autentica, sincera, che trova spazio nella mente del lettore e lì vi rimane per molto tempo, perché Big Ray è un libro semplice, veloce da leggere (quello che consiglio è provare a leggerlo tutto d’un fiato, se possibile, per assaporare pienamente l’atmosfera di solitudine post mortem) e allo stesso tempo efficace; è anche una storia molto intima (probabilmente a tratti autobiografica, vista la dedica dell’autore) e sincera, di quella sincerità che ti spezza il cuore.
Big Ray è come un iceberg, dove ciò che scrive Kimball è solo la punta, ma è sufficiente per far intravedere quanto ci sia sotto l’acqua, quello che viene solo accennato, quello che rimane volutamente implicito, la forza di concetti che quasi sembrano solo accennati, come ad esempio l’elaborazione del lutto, ma che in realtà sono struttura portante di tutto l’edificio narrativo e, nascosti in bella vista, sono la base immensa di questo iceberg letterario.
A volte cerco di immaginare quanto sarei diverso se mio padre fosse stato gentile con me. Mi impegnerei come ora? Sarei più felice di ora? […] Sarei più triste ma meno a pezzi?
A chi si sente di dover sempre e ancora dimostrare qualcosa di più, far vedere che è capace e competente perché il Padre possa essere soddisfatto, a chi si è stufato di farlo, ma che cerca ancora, nascondendoselo, forse, di portare avanti questa inutile battaglia, Big Ray potrebbe essere un pugno nello stomaco, massacrante, ma allo stesso tempo vivificante: vi sentirete liberi, alla fine, capendo che non è necessaria questa stupida prigione, se a chiudervi dentro e gettare le chiavi è stato proprio vostro padre.