“Quando mangiavo ciliegie sotto spirito con Hitler’’ di Manja Präkels
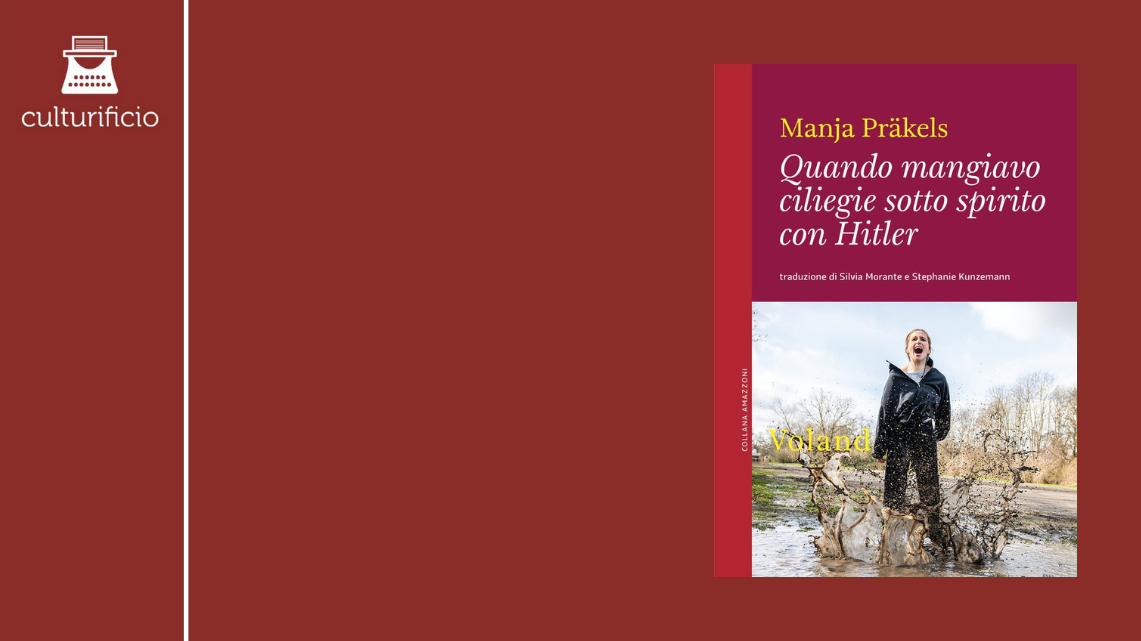
Questa è una delle tante storie di un paese che oggi non c’è più: sparito dalle cartine geografiche, rubricato e condannato dalla Storia come nota a piè di pagina, smembrato tra i ricordi di chi ne ha fatto parte e i souvenir delle bancarelle di Mauerpark.
È la storia di una roccaforte sulla riva dello Scamandro del socialismo reale che ha resistito per quarant’anni, con arroganza e dogmatismo e nonostante gli avvertimenti delle sue tante Cassandre letterarie, all’assalto del capitalismo dall’esterno e, soprattutto, alle reiterate richieste per una vera democrazia dall’interno.
Questa è, per così dire, la TAC con contrasto con la quale il vivere quotidiano sotto il martello e il compasso – simbolo della bandiera di questa altra Germania sorta dalle macerie della Seconda guerra mondiale – viene individuato e refertato nelle sue anomalie tra vecchi e nuovi malanni. La letteratura sa farlo spesso: dare ascolto a voci disperse nel tempo eppure croniste di un’epoca.
A far la diagnosi di questa isola che non c’è più, tra rimandi autobiografici, ricordi e attente ricostruzioni, è una sua ex abitante: le parole di questa donna, anche grazie alla distanza dagli eventi descritti, si rivelano preziose perché a pronunciarle è una dei ‘nati dentro’, ossia coloro che hanno vissuto sulla propria pelle, non senza cicatrici, la parabola della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, fiera terra indipendente e poi di conquista con l’arrivo degli Achei da Occidente.
Quello che stava accadendo alla nostra terra, la DDR, era difficile da capire per chi si trovava in basso. Nessuno la nominava più. Esistevamo ancora? C’erano state le libere elezioni. Il mio nuovo passaporto diceva che ero cittadina della Repubblica Democratica Tedesca. Ma tutti parlavano di Germania e intendevano la Repubblica Federale. La città di Karl-Marx-Stadt ora si chiamava di nuovo Chemnitz. Il Sudafrica aveva abolito l’apartheid, ma come Zottel ci faceva notare a ogni nostro incontro: «Qua da noi sono tornati i nazisti. E vai!».
È dunque la storia di un paese che, dall’oggi al domani, è stato privato non solo dei suoi antichi padroni, che la riunificazione ha mandato in pensione anticipata, ma anche di un’identità costruita a fatica dai cittadini e al tempo stesso gradualmente violata, paese in cui i passaporti mentono, mentre nuovi padroni alimentano un terribile senso di continuità con il passato della croce uncinata.
Manja Präkels, scrittrice, musicista e cantante, in questo romanzo d’esordio – pubblicato in Germania nel 2017 ora nella edizione Voland nella scrupolosa traduzione di Silvia Morante e Stephanie Kunzemann –, attraverso la protagonista e voce narrante Mimi, riannoda le vicende della propria esperienza di adolescente e poi di donna della DDR.
La sua ricostruzione è accompagnata dal tocco prensile del testimone delle nevrosi e delle violenze mai sopite di un paese che, benché crollato un regime, ha visto diffondersi nei propri Länder una nuova educazione sentimentale alla sottocultura neonazista, soprattutto tra i più giovani.
Sono quest’ultimi che calpestano vite e tranquillità nel Brandeburgo, le zone in cui è ambientato il romanzo, sono i figli delle false promesse, di un neoliberismo rivelatosi inadatto una volta esportato a Est, del disagio, del disorientamento, dell’incertezza, della crescente e inedita disoccupazione, sono figure tristi e piegate dalla Storia che impongono le loro storie di prevaricazione ai diversi, anche nella cerchia delle propria amicizie.
Per Mimi, con i suoi capelli colorati e il suo vivere alternativo, ne è un esempio l’amico di un tempo, Oliver, che è diventato per lei il nemico. È il vicino di casa con cui, lontano dai genitori, mangiava a volontà ciliegie sotto spirito per ubriacarsi, per sentirsi un po’ grandi, per avere una propria nicchia di libertà, e che, rasatosi la testa, indossati anfibi fino al polpaccio e, armato di manganello, ha scelto “Hitler” come nome di battaglia.
Ora con la sua cricca detta legge in un territorio dove lo Stato fa fatica a inserirsi, è diventato il predatore in cerca di “zecche”, punk, africani e senzatetto, ed è «la morte che si lustrava le scarpe e indossava un bomber». Non passerà inosservato che questi rigurgiti descritti da Präkels in relazione agli anni ’90 somigliano a quelli che riempiono la cronaca di oggi, in un’Europa che sembra sempre pronta a salire sul dorso di nuove divinità prevaricatrici.
È indubbio che in Quando mangiavo ciliegie sotto spirito con Hitler la narrazione indugi molto – quasi con ossessione (l’assillo di chi ha paura ma registra, di chi svela per mettere in guardia) – nel ricordare le derive neonaziste in un paese che, terminata la guerra, diversamente che in Germania Ovest, attuò un’opera di intensa denazificazione. Questa preferenza tematica porta Präkels a raccontare solo di sfuggita i numerosi problemi del post riunificazione, che forse avrebbero meritato più spazio.
Ci riferiamo alla crescente disoccupazione, alla svalutazione del marco orientale, alla chiusura di centri culturali e di aggregazione, a cominciare dalla prestigiosa Accademia delle Scienze di Berlino Est, al processo di valutazione, essenzialmente politica, ad opera di commissioni occidentali di personale docente nelle scuole e nelle università poi velocemente sostituto da colleghi dell’ovest (la madre di Mimi, insegnante, è proprio per questo costretta a tornare sui banchi di scuola), alle diverse speculazioni edilizie, fino alla cancellazione identitaria di un paese annesso più che riunificato e, successivamente, svenduto dal crinale vincente della Storia del fratello occidentale. Aspetto, questo, già sottolineato da Günter Grass e Christa Wolf che, pure scrivendo da fronti opposti del Muro di Berlino, hanno parlato di Abgewickelt, di declassamento, se non addirittura di amputazione.
Quel senso di spaesamento e, al contempo, di solitudine che unisce le nuove e le vecchie generazioni di ex DDR, insieme a una consapevole impotenza di fronte a un ingranaggio dai meccanismi complessi e a un ambiente sempre meno accogliente e salutare, permea il testo dall’inizio alla fine:
Nel mio ricordo ogni birreria si confonde con le altre. L’ingresso pieno di fumo, la carta da parati ingiallita, le finestre sporche e i bagni in cortile, tutto inverosimilmente coperto di polvere e abbandono. Luoghi tristi dove i sogni vengono lasciati all’entrata, come ombrelli appesi all’attaccapanni accanto alla porta e spesso dimenticati. Si respira a fatica, l’aria è carica dell’odore della birra e del fumo delle sigarette. Ai tavoli le persone stanno sedute immobili, a volte in gruppo, per lo più da sole. Anche se fuori splende il sole, dentro è tutto in penombra. Non ci sono stagioni, non ci sono giorni della settimana, non c’è né mattina né sera. Solo un’infinita attesa. Che l’oste svuoti il posacenere, spilli un’altra birra, porti il conto, che entri o esca qualcuno, che succeda qualcosa. A volte si sente uno scoppio di risa a uno dei tavoli in fondo. Uno degli anziani dalle mani callose parla da solo. Di quelli che se ne sono andati.
La quotidianità della DDR viene dipinta con un tono antielegiaco e tramite istantanee, schegge di immagini e di ricordi, ricchezza di dettagli, con un’efficace poetica dell’attimo che si esprime con un linguaggio asciutto, un umorismo secco, sismografo di una realtà cianotica – e non solo esteriore. Nella ricostruzione dell’autrice non ci sono più né i prati alluvionali né la piazzola della fiera, i ragazzini si incontrano di notte non per il tiro al bersaglio o per il calcinculo ma per le sigarette, la birra e un punto di ritrovo illuminato in cui pensarsi diversamente, un luogo da dove osservare il mondo dei grandi che lentamente va sgretolandosi. Mimi è una ragazza che ha affinato lo sguardo, le bandiere rosse, gli slogan, le aule e i corridoi delle scuole non le offrono più quel senso di protezione perché percepisce segnali sempre più vicini di pericolo, tensione, sguardi ostili e accesi di rabbia, da persone che sembrano condurre una guerra silenziosa.
Questi prodromi da eruzione vulcanica si avvertono già nel perimetro domestico:
Come la muffa nelle fessure delle cantine, la rabbia si era diffusa prima in casa, poi in strada, e alla fine dominava tutta la città. Mio padre ne fu colpito per primo. ‘’La malattia gli sta cambiando il carattere’’ ci aveva messo in guardia la nonna. Poi però vidi che colpiva anche altre persone. Senza farsi notare, la rabbia era rimasta acquattata per anni sotto il selciato, sotto le assi di legno marcio del pavimento, negli scarichi, nelle soffitte, e dietro le fotografie sbiadite. Potevo sentirla insinuarsi in casa nostra. Mi padre ci vietava di parlare, per intere giornate, senza che ne capissimo il motivo. Le parole restavano chiuse in testa, senza potere uscire.
Poi arriva la riunificazione. Il capitalismo si insinua in una realtà che per quarant’anni si era immunizzata, le pensiline dei bus vengono divelte e sostituite da cartelloni pubblicitari, le lapidi delle tombe dei soldati sovietici, che avevano liberato la Germania dal nazismo, un tempo meta commemorativa delle scolaresche, giacciono spaccate nella polvere.
E ancora: la gente fa la fila davanti a nuovi negozi in un clima di euforia perché tutte le promesse delle pubblicità, viste in TV sui canali occidentali, si sono riversate sugli scaffali e sono finalmente accessibili, mentre gli ultimi modelli di mangianastri, insieme ai loro proprietari, sono esposti senza pietà agli sberleffi della gente. Spira ovunque aria di rivalsa, di ricerca del tempo perduto.
Ma mentre l’ex DDR è scossa dai cambiamenti le bande giovanili di predoni, per lo più ubriachi, gridano per strade – che nel frattempo stanno cambiando nome – slogan nazisti, bruciano le case e i dormitori dei lavoratori stagionali stranieri rifiutando qualsiasi forma di autorità, tranne quella nei propri ranghi. Si impadroniscono inoltre di osterie, quartieri, contrabbando, narcotraffico e non lasciano respiro a chi potrebbe obiettare.
Sono ovunque. Ora anche in televisione. Tutti i canali mostrano un gruppo di facinorosi che si è radunato nei pressi dei quartieri costruiti dopo la riunificazione. Le loro voci isteriche, i cori carichi di disprezzo e volgarità si riversano dagli schermi nelle stanze degli spettatori levando loro il respiro e ferendone le orecchie. Agenti di polizia intervengono contro questi neonazisti che lanciano molotov contro le finestre. Nel riverbero delle fiamme sono gli eroi dei nuovi tempi di cui le ragazzine ammirano i muscoli, i loro visi appaiono fieri e impuniti perché sono i loro fratelli minorenni, e quindi non perseguibili, a compiere le violenze mentre intorno a loro ci sono, nell’ombra, persone che battono le mani e ridono trionfalmente mentre i lavoratori stagionali si sono nascosti.
Anche Mimi sta guardando la TV e il Never let me down again dei Depeche Mode, gruppo della sua adolescenza, suona sempre più come un imperativo e un tentativo di resistere:
Mi sentivo una straniera, senza nessuno che sapesse dove abitavo. Chissà se gli altri erano stati più fortunati? Seduta sulla S-Bahn mi sforzai di tenere gli occhi aperti, poi corsi fino alla porta di casa, stordita dal grigio dell’asfalto e dal rumore. In lontananza sentivo urlare i gorilla. Venissero pure.