Traccia – Bertini
ovvero della ricerca sulla base di indizi in letteratura
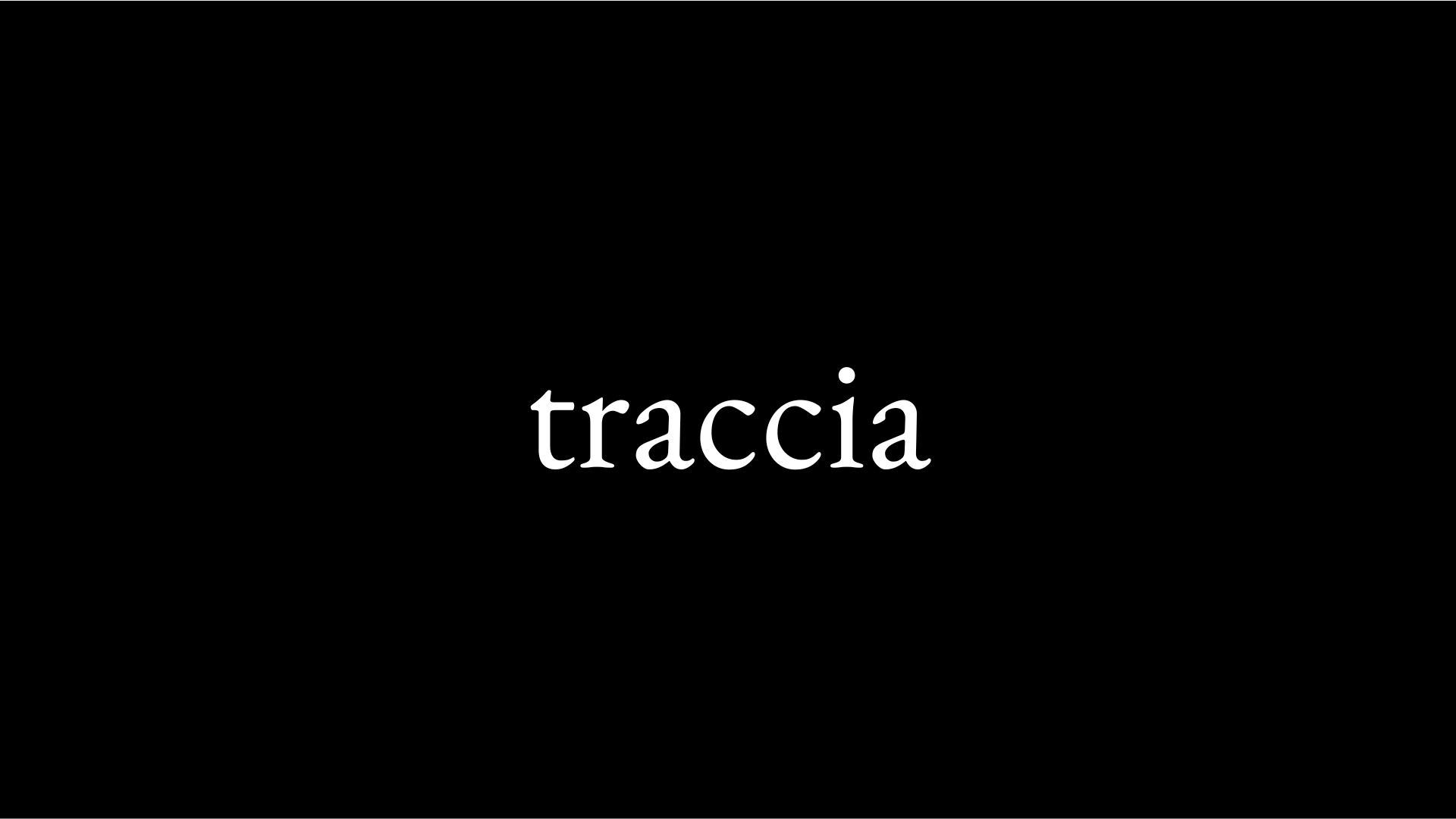
La scrittrice Mariolina Bertini ci parla di “tracce” e della sua passione per il “paradigma indiziario”
Come molti nella mia generazione – sono nata nel 1947 – sono stata una lettrice onnivora e precoce. Tra i sei e i dieci anni, in particolare, ho divorato tutti i romanzi di Jules Verne che mi sono capitati a tiro, con la cieca avidità dell’insetto che si scava a morsi una via d’uscita dal frutto o dal pezzo di legno dove è nato. Proprio in uno di questi romanzi – I Figli del capitano Grant – mi aspettava al varco una parola destinata ad avere un ruolo privilegiato nella mia vita di lettrice e di studiosa: la parola traccia.
In genere i Viaggi straordinari di Verne mi venivano proposti nelle austere versioni integrali della casa editrice Principato, accompagnate dalle originali incisioni ottocentesche in bianco e nero. Ma I Figli del capitano Grant mi si presentarono in una veste per me ben più accattivante: un’edizione SAIE alleggerita di tutte le digressioni didattiche più indigeste e illustrata in uno stile anni ’50 che ricordava le pubblicità dei gelati Motta o del sapone Lux. La storia era quella di una ricerca: i due giovanissimi protagonisti, coadiuvati da alcuni adulti di buona volontà, percorrevano prima l’America del Sud, poi l’Australia e infine la Nuova Zelanda, sulle tracce del padre, il capitano Grant, naufragato su qualche costa ignota e remotissima. Più volte ricorreva nel testo quell’espressione, sulle tracce: che andava intesa in senso metaforico, perché Robert e Mary Grant si spostavano da un continente all’altro seguendo non certo le impronte materiali del babbo disperso, ma i labili indizi offerti da un messaggio semicancellato da lui affidato alle onde dell’oceano in una bottiglia.
Nella seconda parte del romanzo però, quando il racconto si spostava in Australia, mi aspettavano sviluppi inattesi. Il piccolo gruppo degli amici di Robert e Mary, guidato dall’intrepido Lord Glenarvan, si imbatteva, per un’imprevedibile colpo di fortuna, in un certo Ayerton, che aveva servito agli ordini di Grant, era scampato miracolosamente al naufragio e decideva di partecipare alla ricerca del capitano. Nulla, nelle mie precedenti esperienze di lettrice, mi metteva in guardia contro il rude ma ingegnoso Ayerton, che sembrava inviato dalla Provvidenza in aiuto dei protagonisti. Una delle sue iniziative avrebbe però certo insospettito un lettore più avveduto: ricorrendo ai servigi di un maniscalco dalla fronte bassa e dalla fisionomia ripugnante, Ayerton faceva applicare al cavallo di lord Glenarvan certi ferri particolari, con impresso il disegno di un trifoglio. Per più di cento pagine la sua azione restava inesplicata. Quando però i nostri eroi, inoltratisi nelle zone più deserte e pericolose dell’Australia, vedevano morire avvelenati tutti i loro cavalli, tranne quello di lord Glenarvan, la trama malvagia di Ayerton veniva in piena luce: le impronte con il trifoglio dovevano permettere a una banda di suoi feroci complici di raggiungere e depredare gli sventurati viaggiatori.
Per la prima volta, da lettrice principiante, mi trovavo di fronte a un evento per me inaudito: un personaggio che pareva appartenere alla schiera dei buoni si rivelava invece malvagio. Era uno choc non da poco. E a quale stratagemma ricorreva quell’anima nera? Alla manipolazione delle tracce! Per una sorta di crudele contrappasso, lord Glenarvan e i suoi seguaci, partiti sulle tracce del capitano Grant, si lasciavano alle spalle delle tracce che rischiavano di compromettere la loro missione. Se le tracce di Grant avevano il compito di guidare gli eroi verso la salvezza, quelle manipolate dal diabolico Ayerton erano portatrici di morte e di rovina: nel bene e nel male, comunque, erano sempre le tracce l’elemento decisivo del racconto. Me lo avrebbe confermato, un paio d’anni dopo, un’altra lettura fondamentale: quella delle storie di Sherlock Holmes.
Nei romanzi e nei racconti di Arthur Conan Doyle di cui Holmes è protagonista, la decifrazione delle tracce è sempre centrale. Che si tratti di qualche goccia di cera su un cappello o delle impronte lasciate di notte da un terrificante mastino, non c’è traccia di cui il metodo di Holmes non sappia identificare l’origine e svelare il significato. Da indizi materiali opachi ad ogni altro sguardo, l’occhio del grande detective ricostruisce delitti impuniti, trame occulte, intere biografie. Balzac ammirava Cuvier, che da un frammento di osso riusciva a ricostruire lo scheletro gigantesco di un animale estinto da millenni. Del genio di Cuvier Holmes è in qualche modo l’erede, e dalla sua decifrazione di indizi apparentemente trascurabili prendono forma mille eventi nascosti: tutto il romanzo segreto di un XIX secolo oscuro e impenetrabile quanto le foreste della preistoria. Dai racconti di Conan Doyle è nata la mia passione per il romanzo poliziesco, destinata ad accompagnarmi per tutta la vita. Ma è nata anche la mia curiosità per il versante indiziario di certa grande letteratura, in particolare di Balzac e di Proust, versante meno esplorato di altri dalla critica degli specialisti.
Non meno decisivo dei Figli del capitano Grant e dei racconti di Sherlock Holmes è stato per me un saggio letto al momento della sua pubblicazione, nel 1979: Spie. Radici di un paradigma indiziario, di Carlo Ginzburg. Alla luce del paradigma indiziario, adottato, come spiegava Ginzburg, dallo storico dell’arte Morelli, da Sherlock Holmes, da Freud, molte pagine di Balzac e di Proust si prestavano a una lettura sino ad allora intentata. L’autore della Commedia umana aveva decifrato come indizi, come tracce dell’invisibile le fisionomie, gli abiti, i gesti di mille figure del suo tempo; Proust aveva letto come geroglifici da decrittare le affermazioni esplicite e le convinzioni coscienti dei suoi personaggi. Mi si apriva di fronte, con Spie, la strada del mio lavoro futuro: ricostruire l’avventura di Balzac e di Proust, lettori di indizi, frammenti e dettagli; la loro fatica mai compiuta e mai abbandonata di instancabili cercatori di tracce.
Da L’ombra di Vautrin. Proust lettore di Balzac, Carocci 2019, pp. 148-149
Balzac non esitava a citare tra le possibili forme di divinazione quella decifrazione dei tipi psicologici e sociali che è per lui la scienza parigina per eccellenza:
“La maggior parte degli osservatori della natura sociale e parigina possono indovinare a colpo d’occhio la professione di un passante solo vedendolo camminare”.
Grazie a un dono che Balzac definisce ‘sonnambulismo della mente’, il veggente può, di volta in volta, decifrare l’avvenire o indovinare il passato:
“Se quanto è avvenuto ha lasciato delle tracce, è verosimile immaginare che quanto deve avvenire abbia le sue radici”.
La conoscenza indiziaria si propone di risalire dalle tracce agli eventi passati; la divinazione di prevedere, in base a fenomeni naturali interpretati come presagi, quel che avverrà. Entrambe – suggerisce Balzac – si fondano sull’interpretazione di segni: perché dovremmo dar credito alla prima, e non alla seconda?
(…) Balzac opera qui una sorta di gioco di prestigio : istituisce uno spazio fantastico nel quale sono sovvertite le leggi della conoscenza e il mago e lo scienziato, l’indovino e l’inventore godono di identico prestigio, perché i confini tra conoscenza indiziaria e divinazione sono completamente (e arbitrariamente) cancellati. È in quello stesso spazio che Proust colloca Charlus.
Mariolina Bertini ha insegnato Letteratura francese all’Università di Parma dal 1988 al 2017. Ha curato edizioni italiane di Proust e di Balzac. Tra le sue opere ricordiamo Proust e la poetica del romanzo (Bollati Boringhieri 1996), L’ombra di Vautrin. Proust lettore di Balzac (Carocci e Classiques Garnier, 2019), che ha vinto il premio Italiques, il memoir Torino piccola (Pendragon, 2018 ) e Su Liala (Nuova editrice Berti, 2022). È socia nazionale residente dell’Accademia delle Scienze di Torino.
Di parola in parola è una rubrica a cura di Emanuela Monti. Dalla nota introduttiva è possibile scaricare l’archivio della rubrica, uscita fino al 2019 in forma cartacea nella rivista «Qui Libri».