Patimenti – Gilda Policastro
o dell’assedio permanente che la natura riserva alle creature
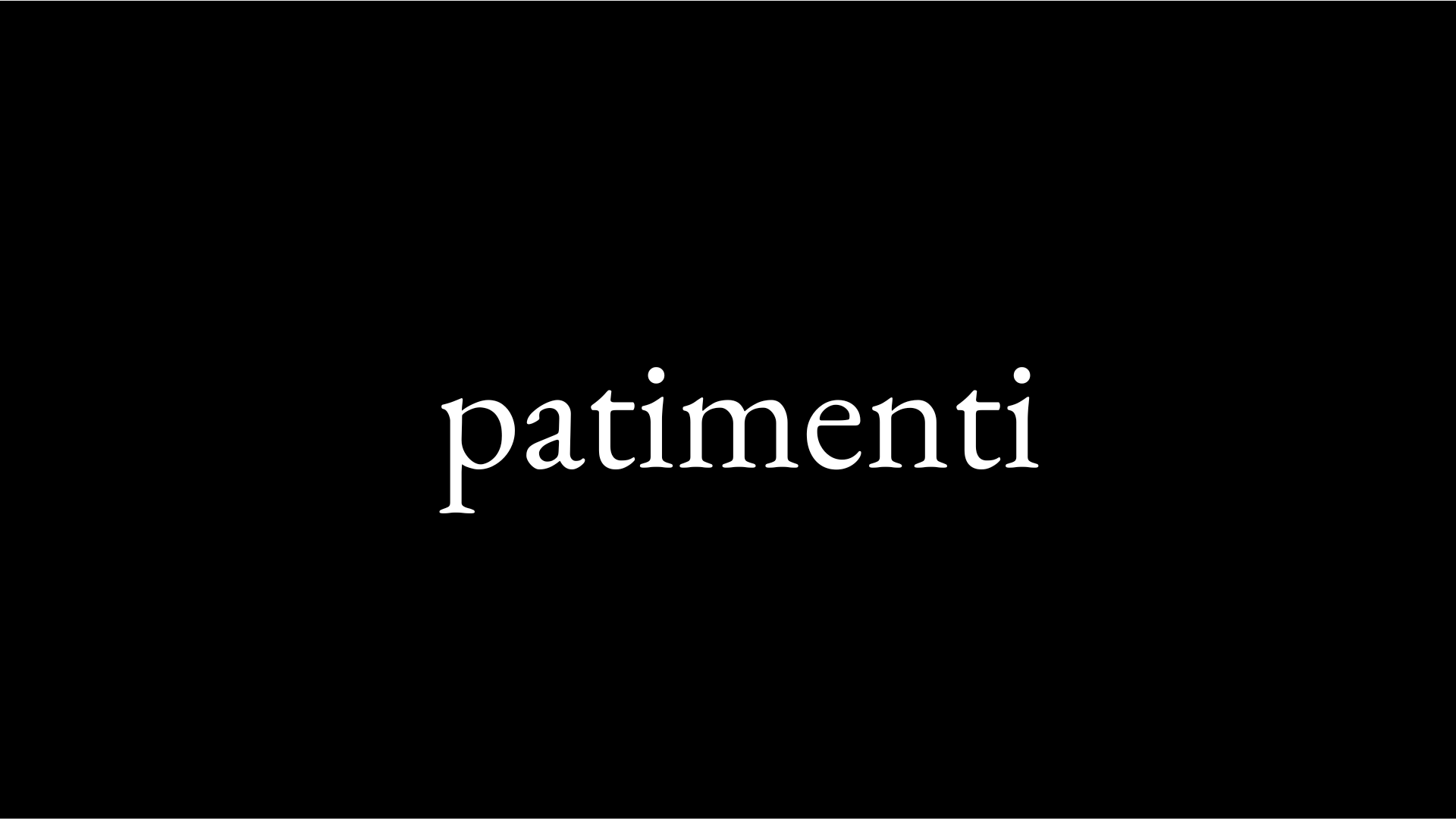
La scrittrice Gilda Policastro ci parla di patimenti, che la sua opera declina in ogni forma, evidenziandone in particolare la qualità reversibile
C’è una novella del Decameron che non è tra le più note, ma è interessante per un elemento di anticipazione (come molti altri, nell’opera di Boccaccio): quello che vi si descrive è, propriamente, un esercizio sadico. Di un sadismo prima di Sade, com’è ovvio, quindi da riportare al sistema valoriale del tempo, in cui i patimenti inflitti fungono (in senso moralistico) da contrappasso rispetto a quelli subiti. La novella ha come protagonisti Rinieri, uno “scolare” (ovvero uno studente) innamorato di una vedova, Elena, la quale per puro godimento lo lascia ad attendere nella sua corte una notte intera al gelo, nonostante le ripetute implorazioni, a cui oppone mille scuse. In realtà si sta trastullando con l’amante, il quale però, non molto tempo dopo, la lascia. La vedova, a giudizio del narratore «poco savia» oltre che disperata, è proprio alla porta dello scolare che va a bussare, servendogli l’occasione di mettere in atto un diabolico piano di vendetta: lasciare la vedova sotto il sole cocente ad arrostire (letteralmente), col pretesto di farle compiere dei riti magici volti alla riconquista dell’amato. La novella ripropone le stesse immagini rovesciate e cambiate di segno, da una situazione all’altra: così se Elena aveva turlupinato Rinieri confidando nel “fuoco d’amore” che avrebbe dovuto scaldarlo anche all’addiaccio, il giovane di fronte alle preghiere della donna di riavere indietro i propri panni non manca di ricordarle il sollazzo che aveva ricavato dalla medesima nudità, la notte in cui era stato lui a rimanere insufficientemente coperto. Poco prima Boccaccio aveva mostrato un momento di cedimento di Rinieri abbagliato dalla visione di Elena che «con la bianchezza del suo corpo vinceva le tenebre della notte». Non al punto, però, da farlo desistere, e questo vale anche per l’autore, perché la minuzia con cui Boccaccio descrive le ferite che si aprono nel corpo della donna è un’autentica prova di “sadismo stilistico”: nulla ci viene risparmiato, dalle piaghe agli insetti che si accaniscono sulla donna fino a farla parere «non corpo umano ma un cepperello inarsicciato».
Questa novella ha rappresentato l’archetipo di una serie di dinamiche che la mia narrativa, direi dal primo romanzo all’ultimo, intende rappresentare: i rapporti di forza che si stabiliscono in una relazione (professionale, amorosa, peggio se tutt’e due le cose insieme), che non sono però rapporti unilaterali e irreversibili, ma, al contrario, rovesciabili a seconda del momento e della piegatura del sentimento. Così nei miei romanzi Sotto (2013), dove il potere del barone universitario si sgretola di fronte alle strategie diversamente seduttive delle due allieve (una più consapevole e sensuale, l’altra ostentatamente fragile, ma per questo più suscettibile di protezione e alla lunga vincente) o in Cella (2015), dove una sorta di rediviva prigioniera “dribbla Proust” (come ha suggerito acutamente una lettrice) e si libera delle catene amorose con il colpo di scena finale: la riconsegna della voce al personaggio maschile, che ha finto, immaginato la storia della prigionia mentale della donna (priva di nome e identificata dagli altri personaggi metonimicamente come “Cella”), a mo’ di strategia di sopravvivenza rispetto alla propria prigionia (reale: l’uomo è un medico e ha curato una terrorista senza denunciarla).
La mia narrativa declina i patimenti in senso sia fisico che sentimentale, intimo. I patimenti sono quelli che la malattia infligge ai corpi in sofferenza del Farmaco (2010) o dell’ultimo romanzo, La parte di Malvasia (2021), ma anche le recite dei ruoli nel rapporto sadomasochistico. Un’altra fonte di ispirazione per me è l’espressione che usa Leopardi nello Zibaldone e nelle Operette morali: «l’esercizio dei patimenti». È una condizione permanente, quella dell’assedio della natura alle sue creature, che esplode in momenti eclatanti come la malattia o la morte, ma che si produce anche in microeventi o addirittura in situazioni di apparente benessere: per esempio la passeggiata in un giardino che ci rende consapevoli di come tutto il creato possa avere una funzione ambivalente (il sole scalda e secca, il vento rinfresca e sferza e così via). L’esercizio dei patimenti è allora la costanza con cui l’uomo prova a resistere a quei colpi, a quell’assedio (con una parola abusata si sarebbe più avanti definita “resilienza”, tradendo peraltro l’origine, che viene dalla scienza dei materiali e descrive la forza necessaria a determinarne la rottura). I patimenti richiedono esercizio, cioè pratica di sopportazione. Una di queste pratiche è la scrittura: il ticchettio dei tasti mentre scrivo è per me antidoto al malessere, esercizio quotidiano di sopportazione, tentativo (fallimentare in partenza) di rimbalzo del dolore. Quel che non è fallimentare è la condivisione: non per scarico, ma per incremento di conoscenza. Più hai dolore più impari, dicevano i tragici. Ogni tanto capita a qualcuno di portare un carico più pesante, e di imparare di più. Condividere fa bene, fa male? È talvolta indispensabile. È un esercizio di patimento, anzi di com-passione. Per chi porta la soma, e chi, senza doverla portare, ne com-prende il carico.
da La parte di Malvasia (La Nave di Teseo 2021)
Il richiamo alla vita che verrà è crudele quanto la percezione della sua inevitabilità: certo, verrà una vita, e come no. Tu non pensi che a nasconderti, vuoi scappare dall’evidenza. L’evidenza non è uguale per tutti, è la conversione all’ipotesi ulteriore che è realmente democratica. Non ci sono sempre altre possibilità, a volte proprio non ce ne sono. A volte, nello stesso spazio, si vive un tempo diverso: una saluta, quella sta arrivando, e forse si può riprovare, ma guarda che capelli, addio da una parte, scuse per il ritardo dall’altra. Forse nemmeno scuse, solo l’attivazione sconnessa di una colpa che parrebbe necessaria alla conversione dell’accadere in passato, di tutto quello che stava succedendo, e non più. Non più è il contrappasso dell’avvenire, tutto quello che potresti sperimentare si riconvertirebbe in abbandono, negazione, esatto contrario. Soffrire è esasperare l’assenza, crocifiggere la speranza, appendersi la gola al chiodo fisso. L’evidenza in questo caso non solo patisce quel tot di malleabilità in meno, ma s’incista proprio dove è lì che duole e non c’è niente che sappia esacerbare, assorbire, esaltare la concentrazione al pari di un dolore che da par suo sa insistere, battendo ogni tolleranza, ogni volta lotta strenua punto e a capo. Tu non ci sei e magari non ci sei più. No, tu c’eri è la chiave, è dover capire questo a spostare di una misura apprezzabile l’indice di sopportazione. Quanto a me, c’ero ma non ero veramente io. Come guardarsi a fari spenti, un’ombra scivola sulla memoria di qualcosa che deve ancora succedere, un flusso aperto quanto a direzione, non aspettavamo che di patire proprio questa sofferenza, così passare dall’aspettativa all’evidenza non è, di nuovo, interesse comune. Io adesso è qui che mi trovo. Tu?
Gilda Policastro insegna Letteratura italiana, ha curato «la Bottega della poesia» per il quotidiano «la Repubblica», è redattrice del sito «Le parole e le cose», insegna scrittura creativa presso l’Accademia Molly Bloom. Ha pubblicato romanzi, saggi e libri di poesia. I suoi titoli più recenti sono il romanzo La parte di Malvasia, La Nave di Teseo, 2021, candidato al premio Strega, e il saggio L’ultima poesia: scritture anomale e mutazioni di genere dal secondo Novecento a oggi, Mimesis, 2021.
Di parola in parola è una rubrica a cura di Emanuela Monti. Dalla nota introduttiva è possibile scaricare l’archivio della rubrica, uscita fino al 2019 in forma cartacea nella rivista «Qui Libri».